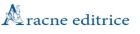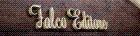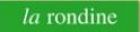Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Mario Saccomanno
A. XIX, n. 210, apr. 2025
 Retroscena della politica italiana:
Retroscena della politica italiana:corruzione, violenza, cospirazioni
di Giuseppe Licandro
L’attenta analisi degli aspetti più segreti e delle «oscenità del potere»
nel saggio-intervista: Il ritorno del Principe pubblicato da Chiarelettere
Niccolò Machiavelli, ne Il Principe, così descrive le due qualità che dovrebbe possedere chi aspira a conquistare il governo di una nazione e a mantenerlo saldamente: «Sendo, dunque, uno principe necessitato sapere bene usare la bestia, debbe di quelle pigliare la golpe e il lione [...]. Bisogna, adunque, essere golpe a conoscere e’ lacci, e lione a sbigottire e’ lupi».
Machiavelli aderisce a una concezione antropologica sostanzialmente pessimistica, che lo induce a giudicare gli uomini in genere «ingrati, volubili, simulatori e dissimulatori, fuggitori de’ pericoli, cupidi di guadagni».
Queste crude riflessioni, tuttavia, sono attenuate dalla consapevolezza che a fondamento di ogni retto governo ci siano «le buone leggi e le buone arme» e che l’agire politico deve porsi sempre come fine il bene dello Stato.
L’«oscenità del potere»
Al di là di quelle che furono le intenzioni del filosofo fiorentino, il “machiavellismo” è diventato nel tempo sinonimo di “condotta senza scrupoli” e ha finito per designare il comportamento disdicevole di chi governa perseguendo soltanto scopi personali.
Alla critica del “machiavellismo” e delle sue nefaste conseguenze è dedicato il saggio-intervista di Saverio Lodato e Roberto Scarpinato Il ritorno del Principe (Chiarelettere, pp. 354, € 15,60). Lodato, giornalista e scrittore, pone una lunga serie di domande a Scarpinato, procuratore aggiunto presso la Procura antimafia di Palermo, interrogandolo sugli aspetti più reconditi del potere politico e, in particolare, sui meccanismi autoritari e illegali che esso ha spesso assunto in Italia.
A tal proposito, Scarpinato nella Premessa dichiara che l’intento prioritario del libro è «descrivere i demoni del Paese», parlando dei personaggi «che hanno insanguinato la sua lunga storia e [...] che predando le sue risorse lo stanno condannando a un lento declino». Il volume, pertanto, si presenta come una rilettura della storia italiana, alla luce di ciò che i due autori definiscono «oscenità del potere», ossia la tendenza della classe dirigente nostrana a spostare i momenti decisionali ob scenum (“fuori scena”), scavalcando di fatto gli organismi a ciò predisposti (come il parlamento) e impedendo ogni forma di reale controllo da parte dei cittadini.
L’uso improprio della violenza
Nel primo capitolo del libro si tracciano le coordinate generali che il potere politico ha assunto nel corso dell’età moderna. Chiosando le affermazioni del cardinale Giulio Mazzarino («il trono si conquista con le spade e i cannoni, ma si conserva con i dogmi e le superstizioni») e del conte Joseph De Maistre («il potere deve essere tenuto fuori dalla portata di comprensione della folla dei governati»), Scarpinato sottolinea come gli atteggiamenti oligarchici, tipici dell’Ancien régime e dell’età della Restaurazione, si siano alquanto perpetuati fino ai nostri giorni, al punto da inficiare la natura stessa della società democratica. Anche in Occidente, infatti, «la democrazia rappresentativa è in parte una fictio dietro cui si cela una competizione tra ristrette élite per conquistare il governo della società». Ciò appare più evidente in paesi come l’Italia, in cui la tradizione liberale ha stentato ad affermarsi e si è scontrata con la sopravvivenza della forma mentis feudale.
A questo proposito viene riportata l’interessante dottrina del bargaining, elaborata a suo tempo dallo studioso statunitense Harold L. Nieburg, che individuò dentro ogni società «un ininterrotto e universale processo di contrattazione nel quale i gruppi sociali competono per la conquista di risorse, status e influenza». Questa contrattazione si può svolgere tramite il ricorso a pratiche pacifiche o violente, in base alle circostanze. Le nazioni più avanzate (come Francia, Gran Bretagna ecc.) hanno sostituito, a un certo punto della loro storia, la violenza bruta con un ordine legale che, pur rispecchiando i rapporti di forza esistenti fra le classi, garantisce in ogni caso una serie di diritti ai cittadini e pone dei limiti ai “poteri forti”.
In Italia, invece, il bargaining ha seguito un percorso distorto, al punto che, secondo Scarpinato, «tutta la storia nazionale dall’Unità a oggi è attraversata dal filo nero di un costante uso politico della violenza da parte di settori della classe dirigente». Lo testimonia una sequenza pressoché ininterrotta di tragici eventi: le modalità della guerra contro il brigantaggio postunitario; la repressione armata dei Fasci siciliani tra il 1893 e il 1894; l’eccidio di Milano nel 1898; le quattromila vittime dello squadrismo fascista nel biennio 1920-21; la strage di Portella della Ginestra nel 1947; la strage di Piazza Fontana a Milano del 12 dicembre 1969; la strage di Piazza della Loggia a Brescia e l’attentato al treno Italicus, accaduti nel 1974; l’esplosione della bomba alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980; l’attentato al treno 904, avvenuto il 23 dicembre 1984; gli atti terroristici compiuti dalla mafia nel biennio 1992-93; le violenze private e quelle istituzionali del G8 di Genova nel 2001. Si devono a ciò aggiungere una miriade di omicidi politici, i tentativi di golpe e i suicidi “sospetti” di personaggi eccellenti.
Il commento di Scarpinato è emblematico: «La storia politica italiana è stata segnata dalla figura del Principe: la componente più arcaica e premoderna della nostra classe dirigente il cui modo di praticare la lotta politica si è declinato, oltre che in termini palesi e legittimi, anche in forme criminali».
Il dilagare della corruzione
Nella seconda parte del volume si esamina il problema della corruzione, ricostruendo i principali scandali che hanno contraddistinto la storia italiana a partire dagli anni Novanta dell’Ottocento.
Lodato e Scarpinato descrivono, innanzi tutto, lo scandalo della Banca romana del 1892, che ne coinvolse il governatore, Bernardo Tanlongo, accusato insieme ad altri funzionari di vari reati, tra cui l’emissione di moneta falsa, la falsificazione del bilancio, la corruzione di circa centocinquanta politici. L’intricata vicenda interessò pure Giovanni Giolitti che, in qualità di presidente del Consiglio e ministro degli Interni, avrebbe fatto scomparire alcuni documenti, compromettenti per vari uomini politici, che erano stati ritrovati dalla polizia nei locali della Banca romana.
Tanlongo e Giolitti, tuttavia, uscirono indenni dalle inchieste giudiziarie.
Le malversazioni non vennero meno neppure durante il Fascismo, anche perché, come sottolinea Scarpinato, «approfittando dell’abolizione della libertà di stampa e del totale asservimento della magistratura, la corruzione di tanti capi e capetti [...] poté dilagare in silenzio senza alcun freno».
Con l’avvento dello Stato repubblicano, la situazione non migliorò granché.
È davvero sconfortante leggere l’elenco degli scandali, a partire dal 1954, di cui si fa cenno nel libro: Ingic, aeroporto di Fiumicino, vendita del monopolio delle banane, Anas, crack dei fratelli Caltagirone, Italcasse, petrolieri (1 e 2), fondi neri della Montedison, Lockeed, affare Sindona, caso Calvi, Ior, loggia massonica P2, Tangentopoli, vicende Cirio e Parmalat, “Furbetti del quartierino”, caso Previti, Calciopoli, Affittopoli, Sanitopoli (e gli autori ne hanno tralasciati diversi altri...)!
Il dilagare della corruzione nell’Italia repubblicana si è sviluppato attraverso tre momenti distinti. In una prima fase, collocabile tra gli anni Cinquanta e Sessanta, si è verificato «il passaggio da una corruzione di élite praticata da un ristretto vertice della piramide sociale [...] a una corruzione praticata sempre più a livello di massa da un personale politico e amministrativo di estrazione medio-piccolo borghese». C’è stata poi, negli anni Settanta e Ottanta, «la privatizzazione della decisione dell’allocazione delle risorse», ossia il trasferimento del potere decisionale dai centri istituzionali a gruppi privati (banche, logge massoniche, partiti, società per azioni ecc.) che agivano perseguendo i propri interessi. Infine, a partire dagli anni Novanta, si è assistito alla «legalizzazione del codice culturale della corruzione», che ha fatto assurgere le condotte illegali a «forma “naturale”» di gestione del potere. Molti fattori, infatti, lasciano presumere che «all’interno dello specifico orizzonte normativo della classe dirigente nazionale la corruzione sia considerata un comportamento normale e dunque culturalmente accettato o tollerato».
Persino la nascita dell’Unione Europea ha finito per ampliare la corruzione nel Belpaese, anziché ridurla, a causa dell’uso improprio dei finanziamenti comunitari. Infatti, «mentre in Irlanda, in Spagna e in altri Paesi i fondi europei hanno fatto da volano al decollo economico, in Italia [...] il fiume dell’oro di Bruxelles viene prosciugato lungo il suo percorso mediante mille canali di drenaggio che ne dirottano il corso verso i tanti rivoli della corruzione».
La costante presenza della mafia
Nell’ultima parte de Il ritorno del Principe Scarpinato ricostruisce la genesi e l’evoluzione della criminalità italiana, con particolare riferimento alla mafia siciliana. A differenza del brigantaggio, il potere mafioso svolse fin dall’inizio «una più generale funzione politica di mantenimento di un ordine reale fondato sul dominio dei pochi sui molti». Già nel 1876 Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, conducendo un’inchiesta sulle condizioni di vita in Sicilia, compresero chiaramente che la mafia non affondava le sue radici nelle classi subalterne, bensì in quella che fu allora chiamata «classe media» e che in seguito venne definita «borghesia mafiosa».
Il modello paradigmatico di questo ceto medio parassitario e illiberale fu rappresentato dai «gabelloti», i fiduciari dei grandi proprietari terrieri, che «prima avevano esercitato violenza per conto dei baroni nei confronti di masse sterminate di contadini affamati e sfruttati e poi avevano iniziato a usarla in proprio, sostituendosi ai vecchi padroni assenteisti e in declino».
Al servizio della «borghesia mafiosa» si pose una porzione di umili contadini e di sottoproletari, che costituì fin dall’inizio «la manovalanza» o, per meglio dire, «l’ala militare» della mafia, contro cui si concentrò l’azione repressiva dello Stato, senza toccare quasi mai i vertici della piramide criminale.
Il primo esempio di impunità della «borghesia mafiosa» si ebbe con l’assassinio di Emanuele Notarbartolo, il direttore del Banco di Sicilia, ucciso in un agguato nel 1893. Il mandante del delitto fu individuato nell’onorevole Raffaele Palizzolo, che tuttavia venne scagionato alla fine del processo, insieme al presunto esecutore materiale (Giuseppe Fontana, membro della cosca di Villabate).
Un apparente cambiamento di rotta si attuò durante il Fascismo, quando il prefetto Cesare (così noto ai più anche se il suo vero nome era “Primo”) Mori ricevette dal governo l’ordine di colpire «l’ala militare» della mafia, compito che portò a termine con molto rigore. Tuttavia, allorché le sue indagini si rivolsero contro alcuni gerarchi sospettati di collusione con il mondo mafioso (tra cui l’onorevole Alfredo Cucco), il cosiddetto Prefetto di ferro venne giubilato e mandato anzitempo in pensione! La «borghesia mafiosa» si integrò nel regime, abbandonando al loro destino i “picciotti” di piccolo e medio calibro. In quella fase storica, del resto, venne meno per i latifondisti la necessità di difendere i propri interessi tramite la criminalità organizzata, poiché fu lo stesso Stato a svolgere la funzione repressiva nei confronti delle masse lavoratrici.
Da Portella della Ginestra al golpe Borghese
Durante la Seconda guerra mondiale e nell’immediato dopoguerra, ragioni strategiche di vario genere spinsero il governo degli Usa a far leva proprio sulla mafia per ridisegnare gli equilibri di potere in Sicilia.
Sul modello delle gang italoamericane sorse Cosa nostra, una moderna organizzazione criminale, strutturata gerarchicamente, che entrò in sinergia con i settori politici più conservatori, appoggiando in un primo momento persino le istanze separatiste del Movimento indipendentista siciliano.
Il bandito Salvatore Giuliano si rese protagonista insieme ad alcuni mafiosi della prima grande strage dell’Italia repubblicana: il 1° maggio 1947, durante un comizio tenutosi a Portella della Ginestra per la celebrazione della Festa dei Lavoratori, i colpi di arma da fuoco sparati dai criminali sugli astanti provocarono 11 morti e 27 feriti! Si trattò, secondo Scarpinato, di «una strage politica», la quale servì come mezzo di dissuasione nei confronti del movimento contadino che rivendicava la riforma agraria.
Il carattere “classista” di Cosa nostra, del resto, fu subito evidente: tra le sue fila si contavano numerosi esponenti della borghesia più agiata, come Michele Navarra, medico e boss di Corleone, o Calogero Vizzini, proprietario agricolo e capomafia di Villalba. Tra il 1944 e il 1966 sotto il piombo mafioso caddero decine di sindacalisti e di militanti comunisti e socialisti.
La mafia, insieme ad altre organizzazioni criminali, fu implicata successivamente nella “strategia della tensione” e in una serie di inquietanti atti eversivi, che così vengono riassunti nel libro: «Basti pensare al coinvolgimento della mafia siciliana nei vari progetti di colpo di Stato come il golpe Borghese del 1970 o nel progetto di evasione dal carcere di Concutelli, al coinvolgimento della ‘ndrangheta nella rivolta di Reggio Calabria e a tanti altri episodi».
La trasformazione della mafia
Cosa nostra cambiò il suo volto tra gli anni Sessanta e Settanta. Da organizzazione prevalentemente legata al mondo agricolo si trasformò in un’“azienda” dedita ad attività illegali molto redditizie, la più importante delle quali fu sicuramente il traffico di sostanze stupefacenti. La «borghesia mafiosa» si inserì nei gangli vitali dell’economia nazionale, sfruttando al meglio le opportunità che le vennero offerte dal “boom economico” e dall’aumento della spesa pubblica.
Nuovi esponenti del ceto medio presero in mano l’organizzazione, come Michele Greco, un possidente che divenne, secondo Scarpinato, «ospite dei migliori salotti palermitani e romani», mentre centinaia di professionisti si affiliarono alla mafia (tra cui gli imprenditori Nino e Ignazio Salvo). Sul versante politico si fecero strada figure come Vito Ciancimino e Salvo Lima che, a parere di Scarpinato, svolsero «il ruolo di cerniera fra mondi inferiori e superiori dell’universo mafioso».
Il gruppo dirigente “borghese” di Cosa nostra, però, dovette fronteggiare due ostacoli, che ne incrinarono in parte la solidità: da un lato, la resistenza di chi si oppose alla prepotenza mafiosa; dall’altro, la leva di boss che guidò «l’ala militare».
Molti cittadini – in quegli anni e nei successivi – sacrificarono la propria vita per contrastare il fenomeno mafioso. Ricordiamo in particolare: Beppe Alfano, Pippo Fava (giornalisti); Emanuele Basile, Carlo Alberto Dalla Chiesa (carabinieri); Ninì Cassarà, Boris Giuliano, Lenin Mancuso (poliziotti); Paolo Borsellino, Rocco Chinnici, Giangiacomo Ciaccio Montalto, Gaetano Costa, Giovanni Falcone, Rosario Livatino, Francesca Morvillo, Cesare Terranova (magistrati); Peppino Impastato, Pio La Torre, Piersanti Mattarella (politici); Libero Grassi (imprenditore); Pino Puglisi (sacerdote). L’impegno di una parte delle istituzioni permise di infliggere alla mafia qualche duro colpo, in virtù dell’approvazione della legge n. 646 del 1982 sul sequestro dei beni patrimoniali dei mafiosi, della celebrazione del “Maxi-processo” di Palermo e della modifica dell’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario, che ha esteso anche alla criminalità organizzata il cosiddetto carcere duro.
Le stragi del 1992-93 e i nuovi equilibri di potere
Alla fine degli anni Settanta, avvenne quello che Scarpinato definisce «il colpo di Stato dei corleonesi». L’ascesa di Totò Riina al vertice della Cupola mafiosa mutò profondamente la strategia delle cosche siciliane: «Riina e i suoi [...] trasformarono di fatto la “democrazia imperfetta” di Cosa nostra in una dittatura, in una piramide controllata da un unico gruppo di comando che dal vertice dispone di tutte le risorse militari e relazioni delle varie famiglie». I corleonesi si affrancarono dal controllo della «borghesia mafiosa», organizzandosi in una sorta di “partito armato” che fu in grado di esercitare per diversi anni forti pressioni sulle forze politiche ed economiche.
La rapida evoluzione dei rapporti internazionali fra il 1989 e il 1991, con la crisi e la dissoluzione dell’impero sovietico, rese anacronistica la presenza di una mafia rozza e violenta quale quella corleonese, facendo venir meno «le ragioni di realpolitik che avevano imposto, in precedenza, di pagare a volte il prezzo di una larga tolleranza nei confronti della criminalità mafiosa». In tal senso, una svolta epocale nei rapporti fra Stato e mafia si ebbe allorché la Corte di Cassazione confermò le sentenze del “Maxiprocesso”. Ciò suscitò, però, la reazione furibonda di Riina e soci, che tra il 1992 e il 1993 infersero gravissimi vulnus sia alla «borghesia mafiosa» (uccidendo dapprima Salvo Lima e, in seguito, Ignazio Salvo), sia alla magistratura (con gli attentati in cui persero la vita a distanza di pochi mesi Falcone e Borsellino), sia alle istituzioni (con una serie di atti terroristici a Firenze, Milano e Roma). Fu persino ventilato dai corleonesi un progetto di secessione del Meridione, che avrebbe dovuto diventare «un paradiso offshore per tutti i capitali del mondo».
L’arresto di Riina e il mutamento del quadro politico indussero i capimafia, dopo il 1993, ad abbandonare la strategia eversiva, puntando a risolvere il conflitto con lo Stato mediante «una soluzione politica incruenta e graduale». Negli anni seguenti, pertanto, si è verificato «un riassetto degli equilibri globali che ha ristabilito in parte il vecchio ordine, restituendo alla borghesia mafiosa l’egemonia perduta».
«Buona fortuna, Italia...»
Ne Il ritorno del Principe si parla diffusamente anche di altre organizzazioni criminali (la camorra, le mafie americana e russa, la ‘Ndrangheta ecc.), che, insieme a Cosa nostra, si sono spartite il mercato illegale mondiale. Scarpinato auspica che, per arginarne la diffusione su scala globale, si adotti «un unico diritto penale e processuale transnazionale che consenta di condurre indagini a livello planetario senza i limiti e gli intoppi delle barriere statali e dei diversi ordinamenti».
Un altro argomento scottante affrontato nel libro è l’oscuro intreccio instauratosi nel tempo fra malviventi, personalità del mondo economico e politico, adepti delle logge massoniche deviate, membri dei servizi segreti e gruppi terroristici: un ginepraio di relazioni inconfessabili, di cui peraltro mancano a volte i riscontri certi. Lasciamo ai lettori il gusto di scoprire i retroscena di questa inquietante “storia segreta”.
Scarpinato, nelle pagine conclusive, paventa che nei prossimi anni s’intensificheranno le spinte oligarchiche del sistema politico italiano e s’indebolirà la struttura unitaria dello Stato, favorendo così le mire della «borghesia mafiosa». Infatti, «se il Meridione dovesse essere di fatto abbandonato gradualmente al proprio destino, le mafie [...] avrebbero finalmente coronato l’antico sogno di riaffermare la loro totale supremazia in questa parte del Paese».
I suoi timori ci appaiono fondati e ci sembra condivisibile anche il commento finale con cui Lodato chiude il volume: «Verrebbe da dire: buona fortuna, Italia...».
Giuseppe Licandro
(www.bottegascriptamanent.it, anno III, n. 21, maggio 2009)
Ilenia Marrapodi