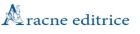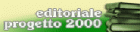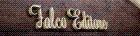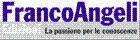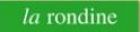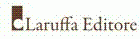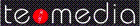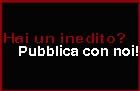Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Maria Ausilia Gulino
Anno III, n° 18, Febbraio 2009
L'immigrazione bangladese nella città di Roma
di Paola Mazza
Da una ricerca svolta nel VI municipio della Capitale, quartiere
con un’alta densità di immigrati: elaborazione ed analisi dei dati
Una ricca presenza di persone immigrate caratterizza la popolazione che abita il territorio su cui si estende il VI Municipio del Comune di Roma [1].
Diverse sono le nazionalità di provenienza degli abitanti stranieri, fra le quali emerge quella bangladese che, con i suoi 2.114 residenti, rappresenta il 17% della popolazione immigrata del Municipio (31.12.2006) [2].
La componente bangladese risulta spiccare non solo per la sua rilevanza numerica, ma anche per l’elevato livello di organizzazione e partecipazione che la caratterizza. Altissima, all’interno del territorio municipale, è la presenza di attività commerciali e spiccate sono le forme di associazionismo che rispondono con ampie reti di relazioni, formalizzate o meno, alle necessità dei migranti.
Una ricerca svolta nel mese di dicembre
La popolazione oggetto della ricerca è stata costituita dagli immigrati bangladesi – regolari e irregolari – che abitano il VI Municipio. Strumento utilizzato è stato un questionario che, tradotto in lingua bengali, è stato distribuito all’interno del territorio municipale a un campione di 100 unità.
Possiamo subito evidenziare come ci si trovi dinanzi ad una popolazione di giovane età (il 70% degli intervistati si colloca fra i 18 e i 30 anni) e di recente immigrazione (il 23% è in Italia da meno di un anno, il 39% da
Uno dei primi aspetti che emerge dai risultati della ricerca riguarda le forti differenze, nei numeri e nelle caratteristiche, che è possibile riscontrare tra la componente femminile e maschile.
Il fenomeno della femminilizzazione proprio dell’attuale migrazione in Italia – che ha come soggetto le migranti dell’Europa dell’Est in particolare, e molto meno quelle asiatiche – vede la crescita del numero delle donne, così come il mutare delle sue caratteristiche, divenendo la figura femminile sempre più spesso autrice di viaggi migratori, compiuti da sola, come primomigrante e per motivi di lavoro.
La componente bangladese appare invece caratterizzarsi per una migrazione femminile che avviene in numeri minori rispetto a quella maschile, in un secondo momento e principalmente attraverso la forma del ricongiungimento familiare. Tale aspetto è confermato dalla distribuzione delle risposte del questionario relative al possesso del permesso di soggiorno, condizione propria di solo il 26% degli uomini, mentre di ben il 90% delle donne. Emerge subito come la maggior parte delle intervistate possiede il permesso di soggiorno, al contrario di una minoranza degli uomini che, più facilmente, arrivano in Italia anche senza la sicurezza dell’ottenimento del documento (come avviene invece nel caso del ricongiungimento familiare). Si rileva come un altissimo numero di permessi per lavoro caratterizzi la componente maschile (85%) e risulti invece presente in maniera esigua fra la componente femminile (15%) presso cui sono difatti, come già accennato, quasi esclusivamente diffusi permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare (65% delle donne contro un 5% degli uomini).
La vita della donna appare inoltre svolgersi maggiormente all’interno dell’ambiente domestico e familiare, come è possibile notare innanzitutto – al di là della stretta ricerca in questione – attraverso un’osservazione quotidiana della loro scarsa presenza e partecipazione alla vita sociale del territorio.
Altra testimonianza ne è stata la somministrazione del questionario, strumento della ricerca. Se infatti si è arrivati a contenere la disparità tra la componente femminile a cui è stato distribuito il questionario (22% di donne) e la sua proporzione all’interno della popolazione bangladese municipale (31% di donne nel 2004 [3]), questo è avvenuto solo in seguito all’esplicita richiesta di far effettuare la compilazione, preferibilmente, a persone di sesso femminile. Il numero delle intervistate personalmente incontrate si riduce infatti a 5 su 49 (dunque al 10% circa).
Possiamo notare ancora dall’analisi delle risposte come vi sia un numero molto maggiore, nella componente femminile rispetto a quella maschile, di persone che rispondono di essere sposate (32% degli uomini e 77% delle donne) e di avere figli (19% degli uomini e 64% delle donne). O come affermi di avere un lavoro il 79,5% degli uomini e solo il 45,5% delle donne.
Si è poi voluto indagare la considerazione che si ha della libertà della donna. È stato chiesto se una “grande libertà della donna” potesse comportare conseguenze negative per la donna stessa, per l’uomo, per la famiglia, per la società. Innanzitutto si è osservato, nel momento del caricamento dei dati sul supporto informatico, come in relazione a questa domanda si sia presentato – bruscamente rispetto alla compilazione degli altri quesiti – un rilevante numero di non risposte. Il che evidenzia come ci si trovi dinanzi ad un tema caldo e delicato.
Si è riscontrato come la maggior parte delle risposte affermative si concentri in relazione alla modalità che indica conseguenze negative per la donna stessa, seguita da quella per la famiglia, per la società, e, solo infine, per l’uomo. Emerge dunque la percezione di una negatività della libertà della donna che si va a concentrare in particolare sulla donna stessa e sulla famiglia e che si pone come elemento di conferma e giustificazione della tendenza alla chiusura femminile all’interno dei circuiti domestici.
La domanda inoltre è stata posta due volte, una in riferimento alla libertà della donna bangladese, l’altra in riferimento a quella della donna italiana. Ci si trova dinanzi ad una diversa considerazione della prima rispetto alla seconda. In relazione alla donna italiana infatti diminuiscono fortemente le affermazioni di possibili conseguenze negative causate dalla sua libertà.
Andando a scomporre per sesso le distribuzioni riscontriamo una, seppur minore, presenza di tali affermazioni anche fra le donne, indice dell’interiorizzazione di tale concezione anche da parte della componente femminile.
Altro rilevante elemento che emerge dalla ricerca riguarda il ruolo fondamentale che assume, nei vari momenti dell’esperienza di migrazione, la rete di connazionali, con tutti gli aspetti – aggiungiamo – di accoglienza e sostegno, ma anche di “intrappolamento” e pressione, che può determinare. Troviamo infatti numerosi campi in cui tale rete assume una grande importanza, a partire dall’ideazione del viaggio di migrazione alla quale spesso appaiono concorrere i racconti dei connazionali. Inoltre cospicui risultano essere gli aiuti ricevuti nel viaggio verso l’Italia, così come quelli ottenuti una volta arrivati nel paese di immigrazione. Notiamo infatti come vi sia un’elevata tendenza a rivolgersi a persone bangladesi, più che italiane, in caso di varie necessità (nel trovare un appartamento, un lavoro, in caso di difficoltà varie come malattie o incidenti, in caso di problemi giuridici).
Queste fitte reti di relazione appaiono inoltre esistere anche a fronte di una non elevata quantità di rapporti che si vanno a instaurare fra immigrati e italiani.
Evidenziamo come dall’analisi delle risposte emerga che particolarmente carenti risultano essere i rapporti con persone italiane negli importantissimi ambiti delle relazioni interpersonali spontanee (come quelle di amicizia e tempo libero) e nei contatti con le istituzioni (come ospedali, uffici, scuole), necessari per una reale condivisione e partecipazione all’interno degli stessi spazi e obiettivi.
Interessanti si mostrano poi le osservazioni relative al possesso del permesso di soggiorno. Innanzitutto rileviamo una diffusa condizione di irregolarità con un possesso del documento che caratterizza appena il 40% degli intervistati (e, ricordiamo, solo il 26% degli uomini) [4].
La condizione di irregolarità risulta essere propria anche di molte persone che si trovano in Italia da un certo numero di anni, indicando dunque come sia frequente che il penoso status di irregolare connoti un immigrato per lunghissimi periodi, e come siano insufficienti le possibilità di regolarizzazione che il nostro paese offre.
È inoltre apparso come il possesso del permesso di soggiorno vada a influire su numerosi aspetti della vita individuale e sociale dell’immigrato. A partire dalla formazione di una famiglia (molto più frequente fra coloro che hanno il documento), alla possibilità di fare viaggi di ritorno in Bangladesh (molto più scarsa fra coloro che non lo possiedono).
Si nota come ovviamente la condizione di irregolarità influisca sulla percezione della propria esperienza di migrazione in termini di positività o meno. Coloro che sono sprovvisti del documento affermano infatti, in percentuali maggiori rispetto a coloro non lo sono, che, se avessero la possibilità di ritornare indietro nel tempo, non rifarebbero la scelta di venire in Italia. O che dall’Italia si sarebbero aspettati condizioni di vita migliori.
Rilevanti, le considerazioni relative all’assenza di un collegamento fra l’ottenimento di un permesso di soggiorno e il possesso di un lavoro. Il fatto che anche tra coloro che non possiedono il documento vi sia un’elevata percentuale di occupazione, conferma come grandi numeri di immigrati si inseriscano all’interno del mercato del lavoro sommerso.
Inoltre possiedono un impiego anche grandi percentuali di intervistati che si trovano in Italia da un ancora breve periodo di tempo.
Ci troviamo dunque dinanzi ad un contesto caratterizzato da un’estrema facilità nell’ottenimento di un impiego, condizione del 72% degli intervistati (fra cui anche il 73,9% di coloro che si trovano in Italia da meno di un anno). Si tratta spesso però di un lavoro in nero, con le gravi conseguenze di ricatto e sfruttamento che ne possono susseguire. Così come rileviamo dall’analisi dei dati che tali impieghi si inseriscono nella grande maggioranza dei casi, all’interno di settori poco qualificati, con una scarsissima corrispondenza fra i livelli di istruzione – che, come vedremo, si presentano elevati – e la tipologia dei lavori svolti, comportando spesso scarse sensazioni di soddisfazione. Molte persone affermano infatti di non svolgere un lavoro che piace e, soprattutto, di non sentirlo adeguato alle proprie capacità.
Si evidenzia ancora come i livelli di istruzione della popolazione in esame siano elevati, con grandi numeri di persone che hanno frequentato parecchi anni di scuola e numerosi intervistati che possiedono una formazione universitaria, evidenziando la nota problematica del riconoscimento dei titoli di studio acquisiti nei paesi di origine dei migranti. Tale aspetto si pone inoltre a conferma di un’emigrazione spesso proveniente dalle fasce più istruite della popolazione, anche a fronte di un livello di istruzione in Bangladesh che invece si dimostra fortemente basso.
La conoscenza della lingua italiana, si presenta invece a livelli che possiamo considerare scarsi, data la grande importanza di tale strumento per una reale possibilità di partecipazione alla vita di un paese. Una limitata padronanza della lingua si dimostra infatti come un indice di scarsa interazione fra la popolazione immigrata e quella italiana costituendo la lingua scritta e parlata un elemento fondamentale, il più importante strumento comunicativo dell’essere umano. Essa permette di comprendere la realtà in cui si vive, di partecipare attivamente a essa, di esprimersi, di venire a conoscenza dei propri diritti e della possibilità di reclamarli, di non rimanere soggetti passivi, ma di avere i mezzi per utilizzare le proprie capacità di critica e azione.
Si è poi rilevato come fra gli intervistati e, in particolare fra coloro i quali non possiedono un permesso di soggiorno, vi sia una percezione di condizionamenti, all’interno della propria vita, riconducibili allo status di immigrato che li connota. Un numero elevato di persone risponde infatti di percepire condizionamenti in relazione ad aspetti importantissimi della vita quotidiana, da cui derivano gravi limitazioni dei propri diritti, fra i quali usufruire dell’assistenza sanitaria e rivolgersi alle forze dell’ordine.
Sono state infine poste alcune domande volte a indagare specificatamente come l’esperienza di migrazione sia vissuta dal migrante, con particolare riferimento a ciò che esso si aspettava da tale esperienza al momento della sua ideazione, di quali aspetti della situazione italiana fosse a conoscenza, quale sia la considerazione che ne ha ora che il viaggio è stato compiuto.
Possiamo rilevare come il 74% degli intervistati affermi di essere partito per l’Italia con l’intenzione di restarvi (piuttosto che di fare ritorno in Bangladesh o di andare a vivere in un altro territorio), confermando la tendenza del nostro paese a divenire sempre più una meta dei viaggi migratori, con prospettive di stabilizzazione da parte degli immigrati. Tuttavia possiamo notare come la grande parte (l’81%) dei rispondenti affermi che si aspettava di trovare in Italia condizioni di vita migliori rispetto a quelle che invece ha poi effettivamente trovato.
Una distribuzione simile si riscontra per quanto riguarda la ricerca di un lavoro, che l’86% dei rispondenti pensava di trovare con più facilità rispetto a quanto è poi effettivamente avvenuto (nonostante, come abbiamo accennato il livello di impiego sia decisamente elevato); o riguardo il possesso del permesso di soggiorno, che il 75% dei rispondenti pensava di ottenere con più semplicità.
Inoltre indagando le conoscenze che gli intervistati avevano prima di intraprendere la migrazione, notiamo come, seppure alcuni aspetti della legislazione italiana fossero sufficientemente noti, si riscontra una rilevante ignoranza di alcuni elementi fondamentali. Ad esempio ben il 29% dei rispondenti afferma che non era a conoscenza del fatto che, per rimanere regolarmente in Italia, avrebbe dovuto ottenere un permesso di soggiorno; così come il 34% di essi risponde che era ignorante del prioritario collegamento fra il possesso di un impiego regolare e l’ottenimento di un permesso di soggiorno.
Rilevanti appaiono poi le risposte alla domanda volta ad indagare se, ora che si è a conoscenza delle condizioni a cui si è andato incontro, se si avesse la possibilità di tornare indietro nel tempo, si rifarebbe la scelta di venire in Italia; infatti ben l’81% risponde negativamente alla domanda. Così come si riscontra un 83% di risposte negative in relazione al quesito che chiede se, ora che si è a conoscenza delle condizioni a cui si è andato incontro, si consiglierebbe a un connazionale di venire in Italia.
Dunque l’intenzione di partenza per molti migranti intervistati – che, aggiungiamo, sono arrivati ad una scelta difficile come quella di intraprendere un viaggio che mette in gioco progetti, aspettative, identità di coloro che lo portano avanti e che vivono queste duplici esperienze di emigrati dal proprio paese e di immigrati nel nuovo territorio – cambia nel corso del tempo. Infatti, se, come accennato, tantissimi intervistati sono arrivati in Italia con l’intenzione di restarvi, e il 63% dei rispondenti afferma ancora (una volta che il viaggio è stato effettuato) di volervi rimanere, abbiamo visto come la grande maggioranza di essi, se potesse tornare indietro nel tempo, non rifarebbe la scelta di migrare verso il territorio italiano, così come non la consiglierebbe a un connazionale.
Abbiamo delineato numerosi elementi ma quest’ultimo aspetto in particolare, corroborato da molti altri emersi nella ricerca, si pone alla nostra attenzione e si colloca purtroppo ad ulteriore conferma dell’inadeguatezza delle risposte che il nostro paese dà al fenomeno dell’immigrazione.
Pur senza entrare in questo luogo nel merito delle politiche esistenti in Italia per, e contro, l’immigrazione (in un panorama che come quello attuale che si dimostra tra l’altro sempre più chiuso e restrittivo), se analizziamo che la condizione della componente femminile rimanga così diversa da quella italiana; che vi sia una visione separata e differente della donne bangladesi e italiane; se il possesso del permesso di soggiorno possa essere così influente nella vita delle persone; se la rete di connazionali finisca per assumere un ruolo indispensabile; se le interazioni fra immigrati ed italiani risultino essere così carenti; se limitazioni derivanti dal proprio status di immigrato debbano concentrarsi anche in ambiti importanti come quelli dell’assistenza sanitaria e del rivolgersi alle forze dell’ordine; se il mercato del lavoro sommerso, sicuramente piaga non solo dell’immigrazione, coinvolge gli immigrati così ampiamente; se vi è un enorme scarto fra le professioni svolte ed i livelli di istruzione posseduti; se la conoscenza della lingua italiana si dimostra a livelli ancora molto scarsi; se, soprattutto, non si rifarebbe la scelta di venire in Italia, il caso della componente bangladese nel VI Municipio del Comune di Roma (nonostante tra l’altro, come abbiamo accennato in apertura, sia quella più presente numericamente e organizzativamente all’interno del territorio), si pone, in molti suoi aspetti, come nuova dimostrazione di quanta strada bisogna ancora percorrere perché un’appropriata risposta sia data a tali fenomeni.
E ci piacerebbe pensare a questa risposta partendo dal presupposto non di un discorso che si veda, ancora una volta, funzionale all’Italia, ai suoi cittadini, al suo ordine economico, politico, sociale, quanto piuttosto delle effettive opportunità dei vari attori che compongono le scene di godere di reali e uguali diritti e libertà all’interno della propria esistenza e indipendentemente dalla provenienza e dai valichi di determinati confini che delimitano i territori.
Paola Mazza
(www.bottegascriptamanent.it, anno III, n. 18, febbraio 2009)
[1] Il 31 dicembre 2006 il Municipio – il quale comprende le aree di Casilino, Pigneto, Torpignattara, Quadraro e Gordiani – contava 12.416 immigrati regolari, che rappresentavano il 9,9% della sua popolazione. Cfr. Caritas di Roma, Osservatorio Romano sulle Migrazioni. Quarto Rapporto 2007, Idos, Roma, 2008.
[2] Tale percentuale si pone nettamente al di sopra di quella nazionale e comunale. Se nel VI Municipio gli immigrati bangladesi, rispetto alle altre nazionalità di provenienza, risultano essere i più numerosi, il contesto nazionale li vede – nel numero di 55.242 – appena al diciottesimo posto (rappresentando l’1,6% del totale della popolazione immigrata in Italia), cfr. il sito Internet http://demo.istat.it. Il Comune di Roma conta invece 10.625 residenti bangladesi che si collocano al quinto posto (costituendo il 4,2% della popolazione immigrata comunale), cfr. Caritas di Roma, Osservatorio Romano sulle Migrazioni. Quarto Rapporto 2007, cit.
[3] Cfr. Comune di Roma, Annuario statistico 2004, consultabile on line sul sito Internet www.comune.roma.it.
[4] La percentuale di intervistati senza permesso di soggiorno, al 51% (il 9% non risponde), si colloca come nettamente superiore rispetto a quella della popolazione irregolare in Italia. Il contesto nazionale vede infatti, nel 2006 – oltre ad una popolazione immigrata di circa 3.700.000 persone regolarmente soggiornanti – una stima, secondo il Rapporto Italia 2007 dell’Eurispes, di 800.000 irregolari (e dunque del 18% circa).
Elisa Calabrò, Mariangela Monaco, Maria Paola Selvaggi, Tiziana Selvaggi
Giulia Adamo, Lalla Alfano, Mirko Altimari, Valeria Andreozzi, Simona Antonelli, Marta Balzani, Claudia Barbarino, Valentina Burchianti, Paola Cicardi, Guglielmo Colombero, Francesca Commisso, Simona Corrente, Giulia Costa, Alessandro Crupi, Simone De Andreis, Marina Del Duca, Anna Foti, Maria Franzè, Annalice Furfari, Simona Gerace, Barbara Gimigliano, Valeria La Donna, Giuseppe Licandro, Anna Teresa Lovecchio, Rosella Marasco, Francesca Martino, Francesca Molinaro, Mariflo Multari, Sara Parmigiani, Anna Picci, Mariastella Rango, Marilena Rodi, Roberta Santoro, Marzia Scafidi, Fulvia Scopelliti, Alessandra Sirianni, Alba Terranova, Raffaella Tione, Filomena Tosi, Laura Tullio, Monica Viganò, Andrea Vulpitta, Carmine Zaccaro
Margherita Amatruda, Natalia Bloise, Pierpaolo Buzza, Elisa Calabrò, Anna Guglielmi, Luisa Grieco e Mariangela Rotili, Angela Potente, Francesca Rinaldi, Maria Paola Selvaggi