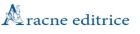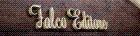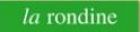Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Mario Saccomanno
A. XIX, n. 210, apr. 2025
 Una silloge oscillante fra estasi
Una silloge oscillante fra estasivisionarie e anatemi iconoclastici
di Guglielmo Colombero
Edita da Armando, l’eclettico, enigmatico ed esoterico
microcosmo poetico di Andrea “P.Untho” Castiglioni
Eclettico, enigmatico, esoterico: tre aggettivi che iniziano per “e” risultano perfettamente idonei a rappresentare Rappoesia (Armando editore, pp. 256, € 16,00) il microcosmo poetico del “rapper letterario” Andrea “P.Untho” Castiglioni. Una rapsodia oscillante fra febbrili estasi visionarie e lucidi anatemi iconoclastici: in tal senso, spicca subito emblematico, e illuminante, l’incipit della prima parte della silloge, Selezione naturale, che riecheggia certe suggestioni del De André de La canzone del padre («Confesso / Sono giudice e giuria / Anche quello che non ho commesso» come «Il tribunale mi ha dato fiducia, / assoluzione e delitto lo stesso movente»).
L’autore accenna a quel «sacro terrore che mi tiene in vita», e amaramente conclude «Voglio pensare di aver vissuto»: proiezione simulacrale di un’esistenza incompiuta. Riaffiorano traumi infantili («Inseguendo sogni di luce / In una stanza buia»), scorre un rivolo di rabbia come un fiume carsico dentro l’anima («Mi attacco a questo foglio / Che è un figlio di puttana / Ci sputo sopra una rima»). Anche il mondo delle fiabe viene brutalmente dissacrato («Quel che ti spaventa non è mai il lupo / Ma quel cazzo di Cappuccetto rosso cupo»), impastato con una citazione del vademecum orrorifico di Lovecraft («Leggo il Necronomicon ad alta voce»). E, con pasoliniano furore, l’io narrante si dibatte nella palude fangosa dell’ipocrisia («La mia lingua è sporca ma dice la verità / La mia vita è storta ché puzza di libertà / È lingua morta sopra un’urna greca»), evoca fasi storiche del passato per esorcizzarle nel presente («Nella mia testa non c’è / Nessun papa nessun re / A fuoco pira da inquisizione»), usa il turpiloquio come un dirompente ariete dialettico («Prima di farvi la guerra io di bombe ne ho pieni i coglioni»).
La simbologia dello specchio infranto e la dimensione autopsicoanalitica
In apertura della seconda parte, Evoluzione della specie, la simbologia dello specchio infranto riflette la «rabbia giovanile / Che puzza di umana delusione» (un riferimento fin troppo esplicito all’effimera stagione sessantottina). L’io narrante si concede qualche polemica di sapore addirittura evangelico (fa pensare ai “sepolcri imbiancati”, e non manca una citazione estrapolata alla lettera come «Tra pianto e stridore di denti»): «Tutti talebani a giudicare gli altri / Tutti voi ogni giorno un po’ più morti», e trova espressioni di tangibile crudezza («Mangiare polvere e ruggine», «Siamo pelli abitate da mostri») e di inguaribile pessimismo di fronte al declino culturale dell’Occidente («Che le pagine dei libri non servono a niente / Sono tutte vuote / Sono bianche come la neve / Che muore sopra ogni cosa») e all’apatia di una società ormai incapace di reagire e di rivitalizzarsi («a vegetare ci pensate voi / Pallidi sotto il sole che state sempre all’ombra / Delle vostre ultime stronzate»).
La terza parte, L’uomo nello specchio, trasporta l’io narrante nella dimensione di una vera e propria seduta autopsicoanalitica, costellata di impennate surrealiste alla Magritte («il mio sorriso che corrode i muri di questa città»), da accenti squisitamente junghiani («L’uomo nello specchio mi appare tanto distante / Quanto lo sono io da me stesso»), da simbolismi raffinati e inquietanti («Mantengo il sole acceso anche di notte»), e di nuovo da urticanti insulti scagliati contro il conformismo borghese («Hanno divorziato dalla verità / A favore di una vita tranquilla») e il vuoto spaventoso che tenta vanamente di occultare («Che se poi vi fate i cazzi miei / Vuol dire che non ne avete di vostri»). Non risparmia neppure gli strali contro il secolarismo delle gerarchie ecclesiastiche («Tenete Cristo legato a una catena / Come se fosse un vostro balocco») e l’idiozia pecoreccia delle masse («La maggioranza non sceglie, non pensa, segue / Chi urla più forte, chi la colpisce alla panza»), argomento, purtroppo, di ansiogena attualità.
In alcuni passaggi l’autore rigira il coltello nella piaga, e rappresenta con cruda fisicità l’intossicazione di massa del mondo globalizzato: «forse ci meritiamo / Quello che c’è in giro / Ma più che sciacquarti le orecchie / Dovresti farti un bidet al cervello», ma non solo, anche il degrado del Bel Paese («l’Italia che va giù / Come un gelato con la panna a cui manca il cono»), e lo slittamento in un cupio dissolvi nichilista («Rompendo lo specchio in mille parti / Tagliando le vene e i polsi a questa realtà / Per scriverci sopra la nostra stori»).
La raffigurazione del contesto sociale e le pennellate apocalittiche
Nella quarta parte, Inkognita, l’io narrante ribalta qualsiasi prospettiva fideistica («Credo nei miei demoni, meno negli angeli lassù nel cielo») fino a sfiorare la soglia della parodia blasfema («Dio / Non è nient’altro che un pusher / Con cui hai un debito»). La raffigurazione del contesto sociale resta impietosa («Un tempo erano le zanzare ad attaccarti la malattia / Ora è tutta la società la malaria / Malata di salario, orario e straordinario»), l’Italia declassata a un «museo di cera a cielo aperto», la filosofia sbeffeggiata («un cazzuto Platone seduto sul cesso»), un persistente “male di vivere” («Quel sapore particolare di sangue sulle labbra / Sa di ferro, sa di miele, sa di promesse infrante»), un attonito smarrimento esistenziale («Siamo come dadi ma con nessuna faccia / Numeri chiusi in gabbia, successione di Fibonacci / Bambole di pezza con desideri di stracci»), la rassegnazione di fronte al disfacimento delle utopie («Alle prese con una rivoluzione che non vuole finire / Perché non è mai incominciata»), la derisione corrosiva verso le pulsioni autodistruttive del genere umano («Voi ammazzate la gallina e volete pure l’uovo»).
Dalla quinta parte, Anonimo, emergono pennellate apocalittiche («Non c’è un cazzo da fare siamo tutti quanti scimmie / Nella stessa gabbia ormai piena (altro che occhi della tigre)»); l’angoscia dell’ineluttabile consunzione del tempo («Per rifarmi una vita ribalto la clessidra / Che il tempo è infame e ladro / Mi porta ogni giorno più alla deriva»); l’ennesima folata di insanabile scetticismo («Malato mistico mastico cicoria senza speranza di redenzione»); la stanca sfiducia in istituzioni ormai deteriorate («Questa è democrazia sincopata», «Denazificata, ma sempre carica d’oppressione»).
La nostalgia per l’utopia dell’immaginazione al potere
Nella sesta parte, RKR Kaso rosso kupo, l’autore tratteggia immagini di intensa suggestione metaforica («Tu sei come le ginestre che crescono sulla roccia prima del ponte / Affacciate sull’abisso, affamate di bellezza»), continua a propagare le ondate concentriche della sua rabbia antiborghese («Il marcio del concetto di patria e di nazione»), innesta frammenti di mitologia guevarista («siempre izquierda / Hasta la victoria / Questo è il succo della storia»), personifica una nazione in ginocchio nella figura di una donna piangente («Quante lacrime ha l’Italia e nessuno che gliele / A-sciu-ga!»), evoca al ritmo di una ballata macabra il personaggio sinistro di Mastro Titta, il boia papalino «mai andato in pensione».
Nella settima parte, PDP partigiano della parola, l’autore sviscera la nostalgia per l’utopia dell’immaginazione al potere («Al posto degli occhi hai due grilletti, due pistole / Con cui spari sogni e colore»), rappresenta il processo creativo come un’effusione di fluidi vitali («Avere il sangue in bocca dieci, cento, mille rime in gola»), sprigiona lampi di energia trasgressiva («Di gabbia in gabbia / Hanno provato a rinchiudere la mia rabbia / Ma non ce l’hanno fatta»), ribadisce il motto Nemo propheta in patria («sono l’alieno dalla lingua biforcuta / Che chi dice e proclama verità merita solo la cicuta»), ammonisce la massa intontita dal Grande Fratello televisivo sulla persistenza di rigurgiti reazionari («Gira una gran bestia in città / una bestia per il mondo! / Si chiama fascismo e razzismo e uccide / non è morto!»).
L’invettiva antiborghese
Nell’ottava parte, Diecimila buone ragioni, si amplifica il tenore dell’invettiva antiborghese («Siamo fuorilegge perché ci avete espropriati dei pensieri / Venduti un respiro alla volta alla vostra bella società»), l’io narrante si incattivisce in vampate di furore solitario («Intingo la penna di P.Untho / In sangue, merda e sudore»), sogna lo sgretolamento dei valori tradizionali («Di parole su una base sono pieno, di strofe infinite abrase / Buone per far esplodere tutte le vostre caaa-se»), imprime una spinta destabilizzante contro la letargia conformista («Sono lo scemo del villaggio di cui tutti avete bisogno / Che non riuscite più a distinguere il vostro incubo dal sogno»), recrimina sui fallimenti ideologici di intere generazioni («Siamo figli del nostro tempo / E di una madre sbadata»), trasfigura gli ambienti in una dimensione surreale, quasi dadaista («Questo è il quartiere in cui sono venuto al mondo / Luogo di sogni, chimere e abisso profondo»), punta l’indice contro una società globalizzata in cui nessuno può dirsi innocente («Siamo tutti colpevoli ma abbiamo deciso di assolverci / Per insufficienza di prove»).
La nona parte, Prima la parola, condensa la rabbia nell’ispirazione musicale («Faccio una canzone ignorante / Portatrice sana / Di una furia costante»), la cristallizza su un sentiero sempre più nitido e incalzante («Niente nebbia nei miei pensieri / La mia strada d’oro la lastrico di rabbia»), e, fitta di innumerevoli citazioni (da Guernica a Clint Eastwood, da Crasso al Cile, da Chernobyl a Dante) e di estrosi neologismi (“Utopika”, “Exarchia”) visualizza come un’istantanea scattata su un magma caotico la diffusione ormai incontrollata dell’alienazione di massa («Quando è l’incubo che vince, la ragione perde / Affascinano gli scaltri, seguiti dagli idioti / Gli intelligenti fanno a gara per diventare i loro nuovo iloti»), che riecheggia la sconsolata profezia firmata da Georges Bernanos in I grandi cimiteri sotto la luna: «L’ira degli imbecilli riempirà il mondo».
L’amaro sapore della disillusione
Nell’epilogo contenuto nella decima parte, Pensodenso, l’autore cerca di tirare le somme: stigmatizza il nodo irrisolto dell’incomunicabilità («Parliamo una lingua straniera / Per le vostre orecchie abituate a ciò che vi dice il sistema»), esprime l’amaro sapore della disillusione («Il cielo in una stanza / Per me non esiste più») e il tracollo delle filosofie alternative («Da qualche parte c’è il beat perfetto / Che combatte i draghi con la cerbottana»). Infine, suggella l’inestinguibile vocazione autoritaria della democrazia di facciata («Un nuovo governo bussa al Quirinale / Adesso tutto è chiaro: è il potere a essere criminale»).
Guglielmo Colombero
(www.bottegascriptamanent.it, anno XVIII, n. 197, febbraio 2024)
Ilenia Marrapodi