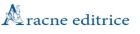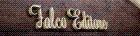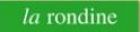Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Anno II, n° 9 - Maggio 2008
 Tuareg nel deserto delle certezze:
Tuareg nel deserto delle certezze:sono i trenta-quarantenni italiani
di Annalice Furfari
Un libro edito da Rubbettino tratteggia i (troppi) affanni dei giovani
nella gerontocrazia del Bel Paese “moderno”. Con pungente ironia
La “generazione Tuareg” avanza felice nel deserto delle certezze: la sua unica bussola è il coraggio della sfida, il nemico da combattere è l’assenza di prospettive, il suo futuro è la flessibilità, la sua arma è l’unione del gruppo. È così che Francesco Delzìo dipinge la sua generazione, quella dei trentenni e dei quarantenni di oggi, paragonati ai mitici nomadi del deserto (i Tuareg, appunto) in un libro intitolato Generazione Tuareg. Giovani, flessibili e felici (Rubbettino editore, pp. 94, € 8,00); il pamphlet affronta, con sguardo profondo, ironico, e lungimirante al tempo stesso, i problemi dei giovani italiani, costretti a costruire il loro avvenire in un paese che sembra aver perso la capacità di far leva su energie nuove e vitali e di puntare sull’innovazione politica, economica e sociale.
Il problema principale dell’Italia odierna è, infatti, la sua dilagante gerontocrazia, che taglia trasversalmente ogni ambito di attività, tanto da apparire come «una “piramide rovesciata” che si regge sulla punta», concentrando simultaneamente distribuzione anagrafica, investimenti pubblici e rappresentanza politica sulle generazioni più anziane. Anche il mondo del lavoro, senza alcuna distinzione legata ai differenti rami professionali, risente della presenza dominante dei sessantenni, soprattutto nelle cariche dirigenziali, ostinandosi a rimandare in eterno il tanto discusso e auspicato ricambio generazionale. Questa situazione ha condotto l’universo giovanile a scontrarsi con gli affanni della precarietà lavorativa, che si tramuta, necessariamente, in insicurezza e instabilità familiari ed esistenziali, tramontato il mito (con cui sono cresciuti i loro genitori) del “posto fisso”, quello che si conquista con relativa facilità e dura tutta la vita.
Gli effetti della riforma “Dini”
Secondo l’autore del libro, la madre di questa ingiustizia generazionale è stata, innanzi tutto, la riforma “Dini” (1995), nonostante essa sia, ancora oggi, lodata da ogni colore politico per avere consentito la sistemazione dei conti pubblici del paese. Il problema è che tale assestamento economico, necessario per riportare sotto controllo il sistema previdenziale più costoso d’Europa, è stato ottenuto a prezzo di un insormontabile svantaggio pensionistico per i più giovani. Infatti, la riforma ha diviso i lavoratori in tre categorie: quelli che, al 31 dicembre 1995, avevano accumulato almeno 18 anni di anzianità contributiva, ai quali continua ad applicarsi il più generoso sistema pensionistico precedente; i lavoratori che, entro la medesima data, presentavano meno di 18 anni di contributi, i quali beneficeranno del vecchio sistema retributivo per gli anni di servizio svolti fino al 1995; e, infine, i soggetti entrati nel mercato del lavoro a partire dal 1996, ai quali si applica solo il nuovo sistema contributivo. In definitiva, i trentenni e i quarantenni di oggi hanno un’unica sicurezza: «quella di non aver diritto neanche alla certezza più granitica delle generazioni precedenti: una buona pensione». Queste disuguaglianze generazionali si riflettono, così, anche sul sistema di tassazione: a partire dall’entrata in vigore della “riforma Dini” «il 46% dei contribuenti – spiega l’autore – furono esentati dall’onere di partecipare alla modernizzazione del sistema previdenziale italiano», mentre «il costo sociale della riforma fu scaricato in grandissima parte sul 18% dei lavoratori». Si tratta, ovviamente, dei ventenni e dei trentenni di oggi, che pagano tasse elevate per mantenere i loro nonni, anziché per assicurarsi un futuro sereno. Ecco come si è giunti all’Italia dei “bamboccioni” (per usare una parola tanto cara al ministro uscente dell’Economia, Tommaso Padoa Schioppa), i ragazzoni cresciuti, che continuano a vivere in casa dei genitori un po’ per pigrizia o scarsa intraprendenza, un po’ per paura dell’avvenire, un po’ per sfiducia nei confronti delle opportunità offerte (o meglio, non offerte) dal mondo del lavoro, un po’ per mancanza assoluta di garanzie provenienti dall’universo politico ed economico.
La precarietà: un terreno su cui non si può costruire
In questo clima, di incertezza e scoramento generalizzati, diventa impossibile progettare la costituzione di una nuova famiglia. E, qui, interviene il secondo problema dell’Italia contemporanea: il rischio di “estinzione”. Il nostro, infatti, è il
paese più vecchio del mondo (preceduto solo dal Giappone), con un tasso di fecondità tra i più bassi del pianeta. Pare che questa situazione peggiorerà sempre di più con il passare del tempo: le statistiche mostrano che «nei prossimi quarant’anni – come ci illustra Delzìo – la popolazione italiana crollerà dagli attuali 59 milioni a 40 milioni di abitanti». Così, l’Italia è destinata a diventare «la “Florida d’Europa”. Un paese con molti pensionati e pochi lavoratori, i giardinetti del Vecchio Continente». Si tratta di uno scenario a dir poco angosciante se si pensa che la potenza di una nazione si basa sulla sua capacità di innovarsi, di guardare con fiducia e ottimismo al futuro delle giovani generazioni, prerogative che l’Italia sembra aver perso da tempo. Infatti, spiega l’autore, «senza un’adeguata base demografica non può esserci sufficiente domanda interna, né crescita significativa della produzione di ricchezza nazionale e nemmeno ruolo internazionale. In definitiva, non può esserci futuro per la “potenza Italia”».
È evidente che il problema va risolto urgentemente se si hanno a cuore le sorti del paese. Bisogna, innanzi tutto, partire dalla consapevolezza che «fare un figlio vuol dire investire sul futuro. Nelle società avanzate, si tratta di una scelta fortemente influenzata dal sentiment generale di un popolo: dal suo livello di fiducia nelle prospettive del Paese in cui vive e nella possibilità di dare a chi verrà una buona qualità della vita». Per incentivare i giovani italiani a staccarsi dalla propria famiglia di origine, con l’intento di dare vita a un nucleo familiare nuovo, di mettere al mondo dei figli e assicurare, così, la continuità della specie, è fondamentale offrire loro opportunità lavorative stimolanti, che siano adeguate al percorso di studi intrapreso con grandi sacrifici e che diano possibilità di carriera. La parola d’ordine, secondo l’autore, deve essere quella di puntare a una flessibilità – diventata ormai un’esigenza basilare di tutti i sistemi economici moderni e avanzati, fondati sulla globalizzazione – che non si trasformi inevitabilmente in precarietà. E per tradurre in azioni concrete questa necessità, è decisivo rendere più duttili i mercati dei servizi, in particolare quello del credito, che penalizza fortemente i giovani italiani, i quali non vengono messi nelle condizioni di richiedere il mutuo per l’acquisto di una casa propria.
Oggi si fa un gran parlare di precarietà nel mondo del lavoro, diventata il terreno su cui tutti gli schieramenti politici si misurano in sede di propaganda elettorale, a suon di slogan accattivanti e promesse mai mantenute. Ma il vero problema non è costituito dall’imperativo di passare con facilità e grandi capacità di adattamento da un lavoro all’altro, o da un settore a un altro, bensì dall’estrema rigidità del sistema del welfare, «che non copre le situazioni di disoccupazione, che non aiuta a ritrovare un lavoro quando lo si perde, che non garantisce una copertura previdenziale nei periodi di esclusione dal mercato del lavoro», in un «mercato fermo all’età del posto fisso, che non tiene conto in alcun modo della nuova condizione dei lavoratori flessibili», leggiamo nel testo.
Il merito come giusta unità di misura
È, poi, fondamentale puntare sulla meritocrazia, un altro “cavallo di battaglia” dei partiti durante le campagne elettorali, l’ennesima promessa mancata di tutti i governi che si susseguono nella direzione del paese. L’assenza di essa nella selezione delle classi dirigenti politiche, delle élite economiche e dei quadri responsabili dei più disparati settori professionali è un problema che l’Italia si trascina dai tempi della rivoluzione del Sessantotto, la causa principale della «vittoria dell’egualitarismo sul merito», che ha disseminato i suoi cattivi frutti soprattutto nel mondo della formazione, «nell’utopia della scuola e dell’università uguale per tutti, nell’accantonamento progressivo di merito, capacità e competenze a favore di un ideale di formazione collettiva e indistinta». Tutto ciò non ha fatto altro che determinare un profondo livellamento verso il basso di studenti e docenti, il quale, del resto, non ha prodotto nemmeno la tanto auspicata parità nelle opportunità di formazione e carriera lavorativa. Infatti, «nella classifica della mobilità sociale, l’Italia è l’ultima tra i principali paesi dell’Unione Europea». Ciò significa che i figli continuano a svolgere il medesimo lavoro dei padri: la prole degli operai resta operaia, così come quella degli imprenditori permane imprenditrice. E, ancora oggi, le università sono frequentate soprattutto da ragazzi che provengono da famiglie benestanti. Così come bisogna aiutare i giovani meritevoli, appartenenti a nuclei familiari che non possono permettersi di pagare loro gli studi, mediante l’attivazione di un maggior numero di borse di studio, è anche necessario determinare la differenziazione e la specializzazione universitaria, «introducendo premi e incentivi che leghino le retribuzioni di docenti e ricercatori alle condizioni di mercato» e liberalizzando le tasse universitarie, in modo tale da favorire la costituzione di atenei d’eccellenza (sul modello di quelli statunitensi), nei quali si formino le future classi dirigenti del paese, ponendo, così, fine all’era della cooptazione e dell’assenza di competizione politica ed economica.
Oggi la “generazione Tuareg” vaga ancora in un «mare senz’acqua», proprio come i sedicenti nomadi del deserto, «figli del vento e delle stelle», vivendo «in bilico tra passato e presente, tra modernità e tradizioni, con l’impossibilità di tornare indietro nel tempo e la difficoltà oggettiva di assimilare nuovi modelli culturali».
Un giovane che “ce l’ha fatta”
In uno stile asciutto, fluido e scorrevole, dal taglio giornalistico, e con un linguaggio semplice e piacevole alla lettura, ma sempre sostenuto e mai banale, Delzìo (33 anni, giornalista professionista, direttore dei “Giovani imprenditori di Confindustria”, presidente dell’associazione “Laureati Luiss” e consigliere d’amministrazione della stessa università, direttore editoriale della rivista Quale impresa, fondatore e animatore dei più innovativi network generazionali degli ultimi anni, da Vedrò a Trenta, nonché membro dei comitati scientifici di “Glocus” e di “Symbola – Fondazione per le qualità italiane”), splendido esempio di giovane che “ce l’ha fatta” (egli ha, infatti, assunto l’attuale incarico in Confindustria a soli 26 anni, diventando il più giovane nella storia dell’organizzazione imprenditoriale e guadagnandosi il meritato titolo di “Italian young leader”, attribuitogli dal Dipartimento di stato Usa), tratteggia le difficoltà del mondo giovanile odierno, senza mai scivolare nel vittimismo, nello scoramento facile, o nelle lamentele fini a se stesse.
L’unione, unica forza di cambiamento
L’autore preconizza un futuro alquanto roseo per la “generazione Tuareg”: i giovani che, oggi, sono privi delle bussole che hanno guidato i loro padri e i loro nonni, a causa del dissolvimento delle ideologie, dei luoghi di aggregazione, dei punti di riferimento e delle principali certezze, che hanno caratterizzato il Novecento, possono e devono risollevarsi dalla sfiducia che li assale, in modo tale da essere pronti ad affrontare le innumerevoli sfide che li attendono sulla strada dell’innovazione del paese. In questa avventura dovranno essere sostenuti dalle élite attuali, le quali hanno il compito di incentivare le nascite con un sistema di welfare che aiuti le giovani donne; promuovere una selezione lavorativa basata sul merito, sulla flessibilità e sulla competitività; attrarre nel paese l’immigrazione di qualità, quella che va alla ricerca della migliore collocazione nel mondo, offrendo i profili professionali più utili alla nostra economia e alla nostra società; puntare al ritorno dei “cervelli”, giovani intraprendenti e talentuosi che, ogni anno, abbandonano l’Italia per mettere a frutto le loro abilità all’estero; aiutare i ragazzi più brillanti e competenti del Mezzogiorno a promuovere lo sviluppo delle loro regioni, anziché a emigrare al Nord; spingere le aziende maggiormente creative a diffondere i migliori prodotti italiani nel mondo. Solo così sarà possibile porre fine alla gerontocrazia, che regna sovrana in Italia, e determinare il tanto auspicato ricambio generazionale in una classe dirigente che è la più vecchia tra i paesi avanzati, «nata e cresciuta in un mondo che non esiste più, con la sua resistibile carica ideologica, con i suoi schemi antiquati, con le sue liturgie che il tempo non scalfisce», impossibilitata a detenere interessi di ampio respiro e di lunga gittata. Ma, proprio come i Tuareg, i giovani d’oggi «hanno una sola chance per sopravvivere: affrontare il deserto in gruppo, abbandonare l’iper-individualismo di fine Novecento per costruire un nuovo “pensiero comune”». Perché, ancora una volta, l’unione fa la forza.
Annalice Furfari
(www.bottegascriptamanent.it, anno II, n. 9, maggio 2008)