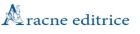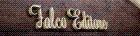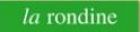Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
A. XV, n, 166, luglio 2021
 Nove racconti scandagliano
Nove racconti scandaglianoi recessi dell’animo umano
di Guglielmo Colombero
Angoscia, conflitti irrisolti ma anche amore e ricongiungimenti:
Vincenzo Ziparo nella sua raccolta per Armando è realistico e crudo
Recensire una raccolta non si rivela sempre facile, anzi a volte potrebbe apparire azzardato: nel caso dei nove racconti di Al di là dell’isola (Armando editore, pp. 240, € 16,00) firmati da Vincenzo Ziparo l’operazione è pienamente giustificata dall’indiscutibile pregio letterario del testo, che fa parte della “Scuderia letteraria” di Bottega editoriale.
Lucido e impietoso indagatore dei corpi e delle menti, l’autore affila la sua scrittura come il bisturi di un chirurgo o, ancora meglio, di un vivisezionista della più profonda interiorità dei suoi personaggi: come ha affermato lui stesso «combinando i punti di vista di tutti i personaggi si capisce che la loro realtà, come del resto per l’intero genere umano e a mio parere anche animale, è forgiata dai sogni, dagli incubi e pure dall’ordinario. L’agire dei personaggi varia col variare della percentuale dei suddetti tre elementi nella miscela che diventa la realtà in cui sono calati e che a loro volta plasmano nel bene e nel male».
Lo stile di Ziparo, eclettico, imprevedibile, a tratti iperbolico (la carneficina bestiale in La fuga, il raptus omicida innescato dalla gelosia in La notte, lo sgozzamento dello stupratore in Sogni) e magari subito dopo minimalista (la family life quotidiana in Nel sole), serpeggia tra svariati registri narrativi: a ogni curva slitta in crepacci emozionali che lasciano evaporare gli eventuali messaggi significanti in nicchie enigmatiche, criptiche, oscure. Sfumature kafkiane, labirinti alla Borges, echi decadenti di Musil: tanto per citare alcuni filamenti rintracciabili nelle sue pagine, e potremmo anche scomodare, in certi passaggi, il furore delirante e dissacratorio di Faulkner o di Bataille. La cronaca di una coppia in disfacimento (La terrazza), l’anelito alla musica come antidoto al male di vivere (Lucciole, Asimmetria), l’incubo ricorrente degli orologi dispensatori di nostalgia del passato, frustrazione del presente e paura del futuro (Orologi), la fusione panteistica con la natura all’interno di una favola adulta (Mandley): tutte sfaccettature di un prisma iridescente che Ziparo dissemina di allegorie squisitamente ambigue, talvolta segrete, o volutamente indistinte.
Il percorso narrativo si addensa di una pluralità di significati, dove l’evidenza si alterna (e spesso si confonde) con il mistero, e l’illusionismo visionario di trame solo in apparenza complicate finisce per confluire in tragedie dell’assurdo (il ridicolo di una gelosia morbosa in La notte), in fiammate di irridente sarcasmo (il feticismo grottesco di quadranti e lancette in Orologi), in bagliori di creatività svincolata da qualsiasi logica frenante che ne sminuisca il pathos spasmodico (l’odissea del Solitario che sfocia nel parossistico omicidio-suicidio finale in La fuga). Traghettatore disinvolto da suggestioni fiabesche a drammi borghesi, dalla gangster story alla commedia sofisticata, dal noir alla pochade, dal postmoderno al barocco, Ziparo è cerebrale e viscerale al medesimo tempo, alterna la lentezza alla frenesia, l’istinto alla riflessione, la brutalità alla tenerezza. I suoi meccanismi narrativi sono oliati da una padronanza lessicale che non risulta mai stucchevole, ma imprime invece ritmi mutevoli alla narrazione e tonalità cangianti alle descrizioni di personaggi e ambienti.
Bergmaniano nei ritratti femminili e misantropo nel senso letterale della parola, Ziparo fustiga spesso e volentieri le figure maschili, in quanto detesta la protervia patriarcale: ributtante, a questo proposito, la figura del feroce padre-padrone evocato dal Solitario in La fuga. L’eterno femminino, invece, pervade quasi tutti i racconti (tranne in La fuga, dove le donne sono relegate ai margini di un efferato e truculento inferno maschile). Emblematiche, a questo proposito, la carnosa e spavalda Melanie in La terrazza e sempre nello stesso racconto la giunonica e sfrontata Julienne.
Speculare alle presenze femminili (che si esprimono come voci narranti del loro punto di vista in tre dei racconti: Lucciole, Nel sole e Asimmetria) è anche il tema della coesistenza tra Eros e Thánatos. Ziparo elabora un teorema in cui la morte è vista come propaggine esistenziale dell’amore (il fantasma erotico di Julienne annidato nella memoria di Manuel in La terrazza, le lettere e le poesie di Roland in Lucciole): cerchi concentrici che si espandono nel tessuto narrativo come la risonanza di un diapason, talvolta carnali e romantici, altre volte evanescenti e quasi indefiniti. Infine, in quasi tutti i racconti riecheggia il leitmotiv dell’inseguimento, reale o simbolico che sia: in La fuga il Solitario è braccato dai suoi antagonisti; in La notte il marito geloso insegue i fantasmi della sua paranoia; in Nel sole Juliette il passato di suo padre; in Lucciole Sophie insegue il ricordo del suo amore tragicamente perduto, come pure Manuel in La terrazza fa lo stesso con il fantasma di Julienne e in Sogni Vincent con quello di una misteriosa creatura; in Mandley e in Asimmetria l’inseguimento coincide con la ricerca di una vera identità; in Orologi tutti inseguono inutilmente il tempo che scorre. Compreso l’autore, il quale, non a caso, nel Prologo che precede i racconti, fa spiccare il volo a una creatura alata che «vola lontano, al di fuori del tempo, per dare comunque un tempo, lei che non ne ha, agli uomini, alle loro esistenze».
Quando la coppia rispecchia il male di vivere
Il primo racconto di Ziparo, La terrazza, si avvale di dialoghi fitti che arieggiano il testo, di un’atmosfera intrigante nel brano del sogno, della descrizione cruda e realistica della crisi coniugale del personaggio. Traspare un erotismo raffinato e stuzzicante, dove affiorano echi del realismo sessuale di Moravia e di Henry Miller. Non mancano ingredienti pepati come il feticismo, il voyeurismo, l’elegante ossessione per la peluria pubica e ascellare femminile.
Ziparo è caustico e corrosivo nel tratteggiare un contesto sociale degradato, nello stigmatizzare una borghesia ipocrita con un rancore sotterraneo che ricorda certe pagine rabbiose di Pasolini («Mi guardano, impossibilitati a vedermi, a capirmi. Succinti nei vestiti di buon taglio, nei colletti rigidi delle camicie, nelle loro vite comodamente rivestite da un duro guscio di formalità»).
Suggestiva la descrizione di un delirio dei sensi come evasione da una realtà opprimente («La realtà è tale solo nei nostri occhi. Personale. Occhi privi di pupille o di cornee. Gli occhi del mondo sono nelle nostre budella, nel nostro ventre. L’indigestione è l’incomprensione, il rigurgito un aborto. Assaporando a pieno ciò che desideriamo, lo uniamo al nostro sangue. Divoriamo da divorati. L’amore è fame, a bocca aperta, con la lingua di fuori, istinto animale che trasuda dalla schiena e di rimando secca le labbra»). Sarcasmo e disincanto affiorano dalle pagine del racconto, che si addentra nella crisi esistenziale del protagonista tratteggiandone il carattere di “uomo senza qualità”.
La filosofia del racconto è mirabilmente sintetizzata da questo passaggio, che sembra scaturito da Viaggio al termine della notte di Céline: «Immobili su questi tetti infuocati, su queste stradine strette, rigagnoli di vita in agrodolce, che confluiscono al mare, con i loro flussi di ricordi, di sangue, di dolci amori, di carichi nauseabondi, di vite guaste, di assassini, di ubriachi distesi per terra sul lastricato unto, levigato, leccati da un cane randagio. Abbracciati alla nostra carne, ai pensieri, alle nostre profonde e affusolate infelicità, a noi. A noi che nonostante tutto troviamo la forza di amarci e di odiarci, che abbiamo il coraggio di sognare, di guardarci negli occhi e di non piangere, che abbiamo percorso i capillari sentieri della irragionevolezza, che abbiamo sondato i suoi meandri più oscuri. Immersi nel bruciore dei nostri pensieri, a noi che cerchiamo la verità, ovunque: all’inferno, al paradiso».
Il ragazzo che dipingeva l’arcobaleno del Creato
In Mandley, inconsueta parabola fiabesca dalla dimensione atemporale del mito (la leggenda della dea Tealinka), emerge la figura del ragazzo al quale viene attribuito il nome dell’uragano. La struttura narrativa è circolare: Mandley scomparirà nel medesimo modo misterioso con cui è apparso, come se fosse il figlio perduto di Tealinka (in fondo l’uragano è il suo effettivo padre).
La narrazione resta sempre in bilico tra sogno e realtà, e culmina nel dono “divino” che Mandley riceve quando inizia a dipingere, immedesimandosi totalmente nella natura («Faceva progressivamente scoprire un cielo con nuvole in movimento, cupe, dalle forme cangianti, quasi palpabili. Un cielo avvolgente, così come appare guardandolo con gli occhi appena sopra il livello del mare, sfiorando la superficie. Giusto in tempo prima che il mare si travasi al contrario, in un’irreale ed enorme colonna protesa verso l’alto, frastagliata da ciclopici spruzzi, che paiono legare, confondere nella trasparenza, l’acqua e lo spazio. Un mare vivo, furente, unito al cielo»); una vera e propria immersione mentale in un “altrove” che coincide non solo con un mito senza tempo, ma anche con l’immensa profondità del mare, con la forza tellurica del Creato. E i pensieri diventano colori: «Un’eterna primavera intrappolata nei riflessi, nelle sfumature, nei giochi di luce che Mandley dosava sapientemente, regalando un falso movimento all’intero paesaggio». Qui l’autore percorre un itinerario narrativo che si ramifica in più direzioni per poi riapprodare da dove era cominciato.
Il personaggio di Mandley è un tramite tra uomo e natura, e quando dipinge si trasforma in una specie di demiurgo, come si evince da questa lettura: «Mandley voleva fare qualcosa di straordinario. Voleva far vivere la piazza, il dipinto, di vita vera. Liberarsi oltre ogni rigidità di tempo, di spazio, percorrere l’illimitato alla ricerca degli inesistenti apici. Eventuali estremità da riunire in un perfetto cerchio».
Armonie musicali e silenzi assordanti
In Lucciole, Sophie è protagonista e voce narrante. Una violinista che placa le sue angosce esistenziali nei suoni del suo strumento («Affidandomi alle note, per ondeggiare nell’aria. Ritrovando l’oblio del distacco»). L’approccio sentimentale con Mathias, un pittore conosciuto durante una cena tra amici, avviene in una cornice naturale che inebria i sensi e la mente: «Un silenzio dipinto, poi incastonato come se fosse materia sul promontorio, tra le lucciole, in mezzo all’erba, sotto le stelle; nient’altro che lucciole in cielo, esploso nei pensieri di entrambi, insieme all’odore del mare, al di sopra del silenzio stesso, fin dove si perde lo sguardo. Il mare, distesa placida».
Qui l’autore oscilla tra varie ispirazioni letterarie (la teatralità dei dialoghi, l’introspezione psicologica, il mormorio interiore) e riesce a creare un impasto suggestivo: sfumature romantiche che evaporano in echi postmoderni (la rivelazione che nel petto di Mathias batte un cuore trapiantato). E l’epilogo in cui, come in una favola arcaica, Eros sconfigge Thánatos; quel cuore potrebbe appartenere a Roland, l’uomo amato da Sophie e morto in un incidente: «Di chiunque sia questo cuore custodisce la stessa essenza di quello di Roland. L’amore del donare».
Presentimento di un delitto
In Sogni, Ziparo viviseziona nuovamente una coppia, come in La terrazza: Luise e Vincent godono di un affiatamento sessuale invidiabile, pilotato dalla sensualità felina di lei, che ingoia il maschio passivo (in questo caso afflitto da una sindrome psicotica) come una pianta carnivora. Ma il sesso ormai si sta svuotando di ogni pulsione vitale, diventa un rito quasi sepolcrale, un cupio dissolvi che rispecchia la letargia necrotica di una società imbalsamata, come emerge dal raggelante brano ambientato nel ristorante, dove una statua appare agli occhi della coppia più vivente delle persone in carne e ossa: «La osservano come se i suoi movimenti non fossero immagini scolpite, come se la statua fosse l’unica creatura, insieme a loro, a respirare. Tutte le altre persone, sedute ai tavoli, sono invece statue in dimensioni reali di spettatori assenti».
L’incontro casuale con un’altra coppia in un ristorante (un fotografo ciarliero e la sua modella annoiata, emblematici della deriva consumistica fondata non sull’essere ma sull’apparire) diventa una cartina al tornasole di una tensione sotterranea che sta dilaniando la convivenza tra i due protagonisti.
Quando le loro strade si separano, almeno temporaneamente, Luise adesca a scopo di lucro un bavoso grassone «panciuto e quasi senza collo» mentre Vincent insegue il fantasma di una bambina (proiezione allucinatoria del suo subconscio) per poi piombare, come attraverso un varco dimensionale, nella stanza dove Luise sta per essere violentata da quell’essere repellente che Vincent sgozza con sadica, estatica voluttà: «Stringe chiuso nel pugno il coltello a serramanico e colpisce con violenza in faccia l’uomo. Questi stordito cade a pancia in giù. Lui lo afferra per il collo da dietro e mantenendolo fermo in ginocchio, gli taglia la gola. A fondo. Da parte a parte».
Sogni è un mosaico complesso e intrigante sul tema del disagio. Un disagio che non è solo esistenziale, ma anche sintomatico del tracollo di una generazione, quella degli intellettuali postsessantotteschi, ormai smarriti nel labirinto delle ideologie tramontate, del rifugio in una dimensione uterina della coppia, della fuga da qualsiasi presa di posizione che risulti scomoda, costosa: fino al delirio del delitto. La chiave interpretativa risiede nelle parole dello psicoterapeuta di Vincent: «suo marito non sogna in maniera comune, con delle visioni più o meno reali, o in maniera adeguata alla circostanza, cioè in un modo che può essere accettabile solo in sogno. I suoi sogni invece, se tali si possono chiamare, sono molto vicini alla vita quotidiana, ne sostituiscono i possibili percorsi, le alternative mai avvenute».
La lama del coltello di Vincent non rappresenta altro che lo spartiacque che separa il quotidiano dall’incubo, il sogno dalla realtà: fine cesellatore di paranoie, l’autore costella la narrazione di frammenti di paura, di iperboli deliranti, di iperrealismo crudo e nel medesimo tempo attonito.
Cosa si nasconde dietro le lancette dell’orologio?
In Orologi, Ziparo utilizza ancora l’efficace espediente della narrazione in prima persona, costruendo un perfetto congegno narrativo… a orologeria. L’oggetto-feticcio per eccellenza, il totem inanimato ma al contempo divorante, l’orologio che non rappresenta solo l’inesorabile scansione temporale, il progressivo avvicinamento alla morte, ma reifica addirittura i personaggi invece di essere reificato da loro.
Paragonabili a piani sequenza cinematografici, i brani che Ziparo distilla sull’immanenza ossessiva di lancette e quadranti sono raffinate variazioni sul tema della “poetica degli oggetti”. L’orologio come simbolo del microcosmo famigliare e borghese, come status symbol del rapace dentista di alto bordo, come strumento mistificatorio al polso del perfido concorrente sleale, come inerte oggetto di adorazione, in cui il tempo si è cristallizzato, al polso dell’amico che non riesce a liberarsi dalla nostalgia struggente di un perduto amore, e così via.
La filosofia del racconto è condensata in una chiusura che rispecchia la più affascinante tradizione letteraria del Novecento (cinica e sconsolata come il finale de La coscienza di Zeno di Svevo: la terra polverizzata e tornata allo stato gassoso senza più guerre e malattie): «Il ticchettio che scandisce il ritmo. Bisogna rallentare i colpi, l’altalena su cui ci dondola la vita. Bisogna rallentare le ore, i giorni, i mesi, gli anni, e poi fermarsi. Ignorando il tempo, gli orologi, gli uomini e le loro ossessioni. Ignorare quelli che credono di limitare il tutto a delle misure, le loro innumerevoli lunghezze. Rimuovendo gradualmente ogni misura eccedente, poiché là dove diminuiscono le misure là diminuisce anche la morsa del tempo. Come l’orizzonte degli eventi racchiude l’universo di un buco nero, il nostro orizzonte degli eventi, il tempo, racchiude il nostro universo. Nel suo divenire sfumiamo come banali ombre, soltanto una giusta consapevolezza di questo stato delle cose può attenuare l’incessante scorrere temporale, facendoci capire che ciò che ora è, nella realtà dei fatti, è già stato, e noi ne facciamo parte».
Traumi del passato e incubi del presente
La fuga procede lungo un sentiero insanguinato, percorso dal protagonista e narratore, chiamato Solitario. L’autore dissemina faide disumane, vendette cannibalesche, flashback lancinanti, in ogni pagina, in ogni snodo narrativo. Se questo racconto fosse un film, porterebbe sicuramente la firma di Sam Peckinpah (il delirio autodistruttivo di Warren Oates in Voglio la testa di Garcia) o di Quentin Tarantino (la bestiale ferocia degli assassini in Le iene) riguardo alla violenza compulsiva che lo pervade dalla prima all’ultima riga, descritta al rallentatore in una dimensione allucinatoria. Ma nel tormento interiore di Solitario, prigioniero di una spirale perversa che affonda le sue radici nella ripugnante figura paterna, troviamo sedimenti letterari di Georges Bernanos (la lotta tra Bene e Male nella natura umana) e cinematografici del Robert Bresson di Mouchette e di Au hasard Balthazar (l’innocenza violata del bambino costretto dal genitore sadico a sparare al cagnolino suo compagno di giochi come iniziazione alla brutalità tribale).
La fuga di Solitario, braccato dal clan rivale, è ormai un inabissarsi nel nulla. Dopo l’ennesima carneficina, ecco finalmente il faccia a faccia del Solitario con lo Sfregiato, capo dei suoi implacabili nemici. Solitario lo provoca, se lo attira addosso per trascinarlo dentro il baratro in cui, consapevolmente, sta per precipitare. E il volo dei duellanti avvinghiati in una stretta mortale è in realtà l’ascesa liberatoria verso una dimensione depurata dalla malvagità e dal dolore: «Vola Sfregiato vola. Si aggrappa a me in un abbraccio penoso, infantile. Ma di che hai paura? Io sono l’unico ad averti fatto del bene, ti sto salvando Sfregiato. Sì è così, ti sto salvando, e quando la tue ossa si spezzeranno sulle rocce sarai libero. Non ci credi? Vedrai. Non sei mai stato libero, o vivo, Sfregiato. Lo so perché anch’io ho vissuto della tua stessa miseria».
Il suicidio di Solitario è la fuga definitiva da un inferno sulla terra verso un paradiso asettico dove la lordura della condizione umana si dissolve in una luminosa e incandescente purificazione. Spaventosa traiettoria autodistruttiva in cui non esistono speranze di riscatto, la parabola del Solitario rispecchia un trauma irrisolto che, germinato nel substrato malsano del clan famigliare, genera inevitabilmente altra violenza. Come un virus, un contagio. Il Solitario è in fuga soprattutto da se stesso, e quando precipita nel vuoto avvinto al suo nemico come un crocifisso alla sua croce, in realtà uccide il proprio sinistro alter ego.
Il morbo insano della gelosia
Il protagonista de La notte è in preda a una gelosia ossessiva e le sue morbose elucubrazioni acquistano ben presto la valenza patologica di paranoie in cui si confondono realtà e fantasia. Un impasto devastante di pedinamenti, congetture, farneticazioni. Come l’Otello shakespeariano, il protagonista slitta lentamente dentro il baratro della gelosia compulsiva. L’impulso omicida scaturisce dallo spossessamento, è una vendetta di chi si considera derubato di un qualcosa che si illudeva di possedere irreversibilmente: «Ucciderò il suo amante. Lei mi ha donato tutto ciò che ora ho, poi insieme al suo amante mi hanno privato di tutto ciò che amo. Io ucciderò l’uomo che me l’ha portata via».
La smania di possesso è ribadita nella spietata anatomia del desiderio, una pulsione maniacale che, in realtà, possiede il presunto possessore. La gelosia degenera ben presto in una catastrofica crisi di identità, simboleggiata dallo specchio infranto: la domanda finale del protagonista è «Chi sono io?».
Il presunto tradimento dell’oggetto del desiderio coincide con lo spossessamento della propria identità: una privazione che lascia lo spossessato come un guscio vuoto, un corpo senza più anima, un cadavere vivente.
La luce impalpabile del ricordo
In Nel sole, i pensieri di Juliette, voce narrante e protagonista della vicenda, affollano un percorso a ritroso, quasi proustiano nella ricerca del tempo perduto: tre anni dopo la morte della madre, su di lei incombe lo spettro di un precoce invecchiamento. Spicca il valore emblematico delle rughe, segno inesorabile del tempo che avanza: ma non solo, anche una mappa in cui affiorano inquietudini interiori. Anche nella figura della madre l’epidermide assume una valenza simbolica, di calendario vivente.
Il sole che dà il titolo al racconto è invece la fosforescenza vitale che avvolge il ricordo della figura paterna, mentre Juliette intraprende la ricerca della donna che il padre ha amato nel crepuscolo della sua esistenza. Juliette non si accontenta dei ricordi, vuole frugare nel passato, scoperchiare tutto quello che c’è stato di non detto, di non rivelato, e come il capitano Willard nel film Apocalypse Now ricostruisce la figura del colonnello Kurtz attraverso verbali e fotografie, Juliette ricompone pazientemente i tasselli di un complicato mosaico esistenziale: la sua indagine non si limita a svelare i retroscena della relazione sentimentale paterna, ma è anche il tentativo angoscioso di ricostruire una sua identità.
«Il passato arriva di traverso, come un vento gelido che mi colpisce di lato, che gela il sudore lungo la schiena. Ora però a differenza di prima sono pronta a riconoscerlo, forse anche ad affrontarlo. In ogni caso focalizzo il suo venirmi incontro mentre mi allontano dal promontorio. In questa discesa la cui fine può equivalere all’inizio di una salita, un’ascesa di libertà».
Approdata al capolinea della sua ricerca, Juliette incontra la giovane donna amata dal padre, e in un colloquio doloroso e toccante esorcizza finalmente i fantasmi del passato e ritrova, forse, la speranza in un orizzonte futuro.
Una continua oscillazione tra passato e presente, che sfocia infine in uno sguardo struggente sul futuro, è il sedimento che pervade l’intero racconto. Una costante evocazione di sensazioni e sentimenti, un mosaico di vite intrecciate e di conflitti irrisolti, spesso racchiusa nella dimensione claustrofobica della famiglia come prigione da cui è impossibile evadere.
L’aspetto esteriore come mappa dei sentimenti
Anche in Asimmetria, una voce narrante femminile, Isabelle, contemplando il proprio aspetto esteriore allo specchio, scopre alcune inquietanti asimmetrie.
Isabelle aspira al canto, la sua insegnante morfinomane, Eleanora, sprigiona un fascino ombroso. Isabelle realizza la sua aspirazione, e la catarsi sonora che le procura il canto placa le sue angosce e le apre il sentiero di una nuova vita: «Gli occhi della gente nei miei provocano commozione per l’incanto sprecato, per i momenti d’appagamento trascorsi e irripetibili. Di quel che rimane poi, dopo un poi insondabile, in una soglia recondita, non sono altro che note, soffici note nella calda sera. Note che cadono sui capelli, sulla pelle, sulla totalità del mio essere, scosso dai brividi di una febbre che lo consuma».
La musica come medicina dell’anima si fonde con una suggestiva cornice ambientale, che riporta alla memoria certe atmosfere esistenzialiste degli anni Cinquanta. Isabelle incarna le tormentose inquietudini di un’intera generazione, smarrita, disorientata, e la sua immagine “asimmetrica” allo specchio rappresenta l’emblema di questo profondo disagio interiore, la faticosa ricerca di un equilibrio.
Quando i dormienti si risvegliano
Nell’Epilogo, l’autore raduna tutti i suoi personaggi su una spiaggia, attorno alla figura riemersa di Mandley, e annuncia: «Da lì a breve tutti i partecipanti a questa strana riunione si sarebbero risvegliati. Nei loro letti, nelle loro case, ignorando il risveglio degli altri partecipanti al comune sogno. Nelle loro case, nei loro letti. Ognuno con la propria univocità. Ognuno ignorando l’altro. Tutti si sarebbero risvegliati. Tutti tranne alcuni».
Un fitto caleidoscopio emozionale, in cui convivono echi romantici e umori corrosivi, slanci di tenerezza e sussulti di violenza, sogni seducenti e incubi tormentosi, presenze sensuali e fantasmi del subconscio. Una mappa labirintica, pulsante di essenze vitali e talvolta di agonie, che vale la pena di percorrere e di esplorare in tutte le sue suggestive sfumature.
Guglielmo Colombero
(www.bottegascriptamanent.it, anno XIV, n. 166, luglio 2021)