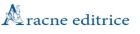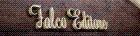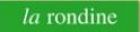Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
A. XIV, n.157, ottobre 2020
 A volte si dice “addio”
A volte si dice “addio”invece di “per sempre”
di Massimiliano Bellavista
Per Rubbettino un misto di romanzo e memoriale,
un corrosivo testamento e un doloroso epitaffio
È come caricare uno di quei vecchi pendoli a catena. Apri con cura lo sportellino che protegge i lunghi pesi all’interno della cassa dell’orologio. Poi tiri la catena accanto al peso, non quella alla quale il peso è connesso.
L’ordine dei pesi da caricare non ha alcuna importanza. L’orologio riparte, il pendolo oscilla. È così che spesso si scrive quando si vuol narrare una vita intensamente vissuta. Si apre un pertugio nella memoria, un punto di vista su una vita ormai quasi immobile, se ne osservano pesi e contrappesi, si cerca di riavvolgere il filo del tempo e non è tanto importante l’ordine ma il senso che se ne afferra. E la vita, nello spazio di quella lettura, si rimette in moto. Per questa precisa ragione il volume merita da essere letto.
«Vorrei sparare agli orologi come i comunardi per azzerare il tempo» dice Andrea Frezza, l’autore di Così viviamo per dire sempre addio (Rubbettino Editore, pp. 280, € 15,00), un suggestivo e chimerico incrocio tra romanzo, sceneggiatura e memoriale. Sapeva che il tempo gli stava sfuggendo, proprio come sta spesso scritto sui vecchi orologi a pendolo.
Il Consiglio dei Ministri nel 2009, quando già il settantunenne scrittore, regista e sceneggiatore viveva da tempo in precarie condizioni economiche ed era gravemente malato deliberò di concedergli il vitalizio previsto dalla legge n. 440 del 1985, la cosiddetta “legge Bacchelli”.
Il suo libro esce poco più tardi, nel 2011, e nel 2012 l’autore scompare. Nel 2005 aveva lasciato Los Angeles, dove aveva insegnato Sceneggiatura, per tornare definitivamente in Italia a girare un film molto importante per lui. Non ci riesce purtroppo, a causa di mancati finanziamenti e così scrive questo libro.
Sono molti i pesi e le angosce che gravano sulla sua vita, come quelli che opprimono il protagonista della storia, Matteo, nato nel 1937 come Frezza, nome da evangelista e cognome glorioso che lo qualifica come ultimo della dinastia dei Santavelica, il quale a un certo punto della sua vita decide di tornare in Calabria negli aviti luoghi e abita in una piccola casa accanto alla più grande villa settecentesca di famiglia, la “casa dei ciliegi”, «costruita nel 1756, su disegno di Luigi Vanvitelli, e abbandonata ai vandali e alle intemperie due secoli dopo».
Il suo racconto, tuttavia, non ha niente di evangelico, è qualcosa a metà tra un corrosivo testamento e un doloroso epitaffio. «È il momento di scaricarmi l’anima con le parole come una puttana e bestemmiare come una baldracca. Parole di Amleto, che faccio mie in questa mattina di quiete apparente.
Perché la memoria m’impone questa tortura, questo ripassare il film della trascorsa felicità, delle vele gonfie di speranze e di sogni afflosciate dalla superficiale bonaccia che nasconde la devastante bufera della coscienza disintegrata?».
Lo stile e l’uso del linguaggio
Anche lo stile, diretto fino alla sfacciataggine, afferra il lettore perché si avverte l’essenzialità ma anche la sincerità della narrazione. Nel volume non c’è niente di superfluo, niente che non dovrebbe stare dove è, in un salto temporale e geografico continuo, sfidando tempo e memoria.
Ci sono incipit degni di memoria come questo: «Mi sveglio presto, nell’ora che precede l’alba, quando anche le persone forti si sentono deboli, gli ammalati muoiono e i nemici sbarcano sulle spiagge».
In generale, si percepisce la genesi del testo quale sceneggiatura di un film, perché quasi ogni capitolo ha una forte resa visiva e scenica, l’immaginaria macchina da presa si muove fedelmente dietro alle parole del narratore. Un esempio sono le descrizioni e i dialoghi contenuti nel capitolo che si intitola Boogie Woogie, proprio il nome che Frezza avrebbe voluto dare al suo film.
Anche le immagini sono importanti. Certi oggetti e certe immagini sono simboli, perlopiù metafore di una vita che non scorre più e di una memoria intermittente e ingannevole che spesso la sovrascrive e la cancella come un nastro magnetico. Le tombe su tutti. Per uno come Matteo, che ha perso Stella, anzi «la mia diletta Stella, il mio amore ultimo, con cui ho vissuto gli anni migliori» e ha perso tutti i suoi amici, le tombe, nella loro grigia materialità, rappresentano anche le pietre sicure di un molo immaginario, un porto sicuro cui approdare nei frequenti momenti di smarrimento.
«Ritrovo le loro tombe al cimitero, nomi, date di nascita e morte, elogi della loro vita affidati alle lapidi per la memoria di chi ha voglia di leggere e visitare cimiteri. La visita ai morti è un rito molto praticato dalle mie parti, non soltanto il due novembre celebrato con le ossa di morto, dolci che riproducono tibie, femori, clavicole, teschi, alcuni talmente duri da rompere i denti, altri di pasta martorana, morbidi, colorati, zuccherini mia vita».
Per Frezza e per il protagonista del libro queste lapidi svolgono la funzione di tetre madeleine. E ricorrono continuamente: nel ricordo delle vittime dell’Olocausto, nella primavera del 1953 al cimitero di guerra di Colleville Sur Mer dove sono sepolti i morti di Omaha Beach, nei viaggi del protagonista.
«Visitavo tombe quando potevo... Andai a cercare la tomba di Raymond Chandler al Mount Hope Cemetery di San Diego, California. Quella di Truman Capote e di Marilyn al Westwood Memorial Park Cemetery, Los Angeles, California. E poi al cimitero nazionale di Arlington dov’è sepolto Dashiel Hammett. In uno dei periodici viaggi romani mi fermai in Inghilterra e andai a cercare nel giardino della chiesa di Heptonstall la tomba di Sylvia Plath. A tutti ho portato un fiore per ringraziarli della felicità che mi hanno dato leggendo, vedendo e sentendo le loro opere».
La pensa così anche Cees Nootebom. Il celebre scrittore olandese, nel suo Tumbas dice che «La maggior parte dei morti tace. Per i poeti non è così. I poeti continuano a parlare». Si vede che anche Matteo deve essere alla fine un poeta, perché proprio per questo come Nooteboom nel corso della sua vita ha sentito il bisogno di visitare tutte le tombe dei grandi scrittori e filosofi che lo hanno segnato.
Non si impara a dire addio
«Ancora non so come dire addio ma sento che imparerò presto» è la frase che conclude il romanzo, che può essere letto anche come l’inquietante messa in scena di un presagio che evidentemente nella mente dell’autore rappresentava quasi una certezza. Ma si avverte che questa certezza non è affatto granitica, e non è affatto certo che con quell’addio, anche se si imparasse a darlo, tutto davvero finisca.
«Il viaggio della memoria è un addio a quel che s’abbandona» e ancora «Se i ricordi sono un dolore la loro assenza è una fonte di sofferenza ancor più grande». Matteo non è certo e nelle ultime pagine sembra centellinare il ritmo della narrazione, quasi indugiare, Forse per questo l’autore, altrettanto dubbioso, si affida a Rilke e alle Elegie duinesi, da un passo delle quali l’autore ha ricavato il titolo di questo romanzo: «Ma chi ci ha rigirati così/che qualsia quel che facciamo/è sempre come fossimo nell'atto di partire? Come/colui che sull'ultimo colle che gli prospetta per una/volta ancora/tutta la valle, si volta, si ferma, indugia /così viviamo per dir sempre addio...».
Se si legge l’addio di Florindo Rubbettino ad Andrea Frezza pubblicato ne Il Quotidiano della Calabria del 30 marzo 2012, si conclude riflettendo su come forse il tema del libro è tutta un’illusione, un miraggio, dove Matteo e Frezza, ora uniti, in realtà non vogliono dire addio, ma restare vivi e presenti alla nostra memoria. Ricorda Rubbettino a proposito di Frezza «Di quando giovane studente universitario bussasti a casa Moravia e di fronte al celebre scrittore, un po’ sbalordito e un po’ incuriosito da quel giovanotto temerario, chiedesti tutto d’un fiato: “come si fa a fare lo scrittore?”, o di quando Orson Welles che avresti dovuto sollecitare per affrettarsi a recarsi sul set ti fece sedere a tavola insieme a lui cercando di insegnarti come si prepara un’ottima insalata».
Curioso, proprio il piatto preferito del suo protagonista, unico compagno delle sue lunghe di solitudine. «Cipolle rosse, pomodori, cetrioli, olive nere, tonno, capperi, origano, olio e pane biscotto giallo di mais. Un calice di prosecco, ciliegie».
Massimiliano Bellavista
(www.bottegascriptamanent.it, anno XIV, n. 157, ottobre 2020)