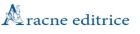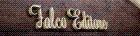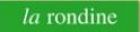Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
A. XIV, n.150, marzo 2020
Un teorema
da dimostrare
di Massimiliano Bellavista
Una serie di ipotesi:
chi è uno scrittore?
Del Giudice di certo
Questo articolo è un teorema.
La sua ipotesi è che in un’Italia dove ogni occasione è buona per rievocazioni e primi letterari (se ne contano più di 1.800) i settant’anni di Daniele Del Giudice passeranno sostanzialmente inosservati. Forse dopo tutto è un bene, avremo maggior tempo di pentircene in futuro. Del resto sulla quarta di copertina de I racconti (Einaudi, 2016), è scritto che «negli anni Ottanta e Novanta quando usciva un libro di Daniele Del Giudice era un evento per critici e lettori, in Italia e all’estero» cosa che adesso è vera solo all’estero dove viene ripubblicato con regolarità e apprezzato da autori quali Carrère, McEwan (di cui fu a sua volta primo recensore) o più recentemente Patrick Deville.
La tesi è che non si parla di aver sommerso uno scrittore, ma un maestro sommerso. Dal bacino di San Marco si vede l’isola della Giudecca, dove lui è ricoverato malato da tanti, troppi anni: dentro i suoi libri, si vede tutta un’Atlantide di pensieri e grande letteratura.
Quanto alla dimostrazione, da cosa si riconosce uno scrittore vero? Ci sono vari indicatori, ognuno ha i suoi e qui cercheremo di elencarli.
La dimostrazione del teorema. Alcuni criteri.
Uno potrebbe essere la sua imprevedibilità, la difficoltà di classificare quello scrittore, di incasellarlo in questo o quel movimento, in questo o in quell’ordine temporale. Allora ci siamo: Del Giudice è una Cenerentola nelle antologie scolastiche perché non è collocabile in alcun specifico movimento e, letto ora a distanza di trent’anni dai suoi primi scritti, si avvicina sempre più alle cadenze sempreverdi di un classico. Ciò risponde al suo essere artigiano della parola e poi della frase, attraverso un lavorio costante e una costante ed esigentissima selezione, un «nulla dies sine linea» praticato con disciplina, quella disciplina che lo ha portato a pubblicare assai poco. Ma quel poco è di altissima qualità e d’intorno vi è tutto un mondo sommerso, fatto di scritti, articoli, saggi che sarebbe bello poter vedere finalmente raccolti (il che è un paradosso nel paradosso, visto che in un recente pezzo si esortava a rileggerlo a cominciare da un suo pezzo riguardo il concerto dei Pink Floyd del 15 luglio 1989 organizzato su un palco ancorato nel mezzo del bacino San Marco, ma di questo articolo non esisteva nemmeno un link). Del resto il motto “nessun giorno senza una riga” rimanda ad un libro omonimo, ancora più sommerso, scritto da Jurij Oleša che pare proprio Del Giudice raccomandasse caldamente di leggere. Questo essere artigiano e non industriale in serie della parola (morbo che affligge molta scrittura contemporanea) è evidente quanto è evidente in Calvino, suo scopritore: per entrambi ogni libro è un progetto e una bussola, che può portare in direzioni diverse e anche opposte a quelle da cui si erano prese le mosse, ovvero dove si era conclusa l’opera precedente.
Un secondo criterio potrebbe essere rappresentato dalla brillantezza delle visioni e intuizioni che caratterizzano i testi di uno scrittore: in questo caso non c’è partita. In Evil Life, racconto pubblicato in Mania del 1997 si gioca di anticipo con tanta letteratura successiva, descrivendo una Rete che forse è quella di oggi, non certo quella di allora, dove due entità, Evillife e Timetolose, dialogano. «Mediamente a quell’ora ogni sera torna a casa attraversando lo spazio – prima strutturato poi meno strutturato e poi sfibrato – di quel che un secolo fa erano le metropoli e ora sono la caricatura beffarda e disfatta di se stesse come “città”, e una volta a casa, mediamente un’ora dopo, dopo accende il macchinario, entra nella Grande Rete, si affaccia al mondo, mette piede nella piazza di un gruppo di discussione, e deposita lì, come un uovo, la sua novella. In qualche altro luogo della Terra un’altra persona rastrema il gruppo di discussione della propria ossessione, mediamente a quell’ora spazza il mare come un incrociatore… ritaglia nel mare grande dell’alternativo e dell’abuso, gorgogliante chissà dove nella Rete».
Internet è visto, già allora, in modo costruttivo e assai meno catastrofico di certe visioni attuali, come il luogo che «ha reintrodotto paradossalmente la scrittura. Intanto la scrittura epistolare, che sembrava del tutto eliminata dal telefono, quindi un diverso uso del telefono, dato che la Rete al momento significa cavi, cioè cablature telefoniche che non portano più parole ma lettere, scambi epistolari. Grazie a ciò siamo ritornati di nuovo alla scrittura. E poi in rete si trovano molti racconti, molta narrazione, cosa che mi ha incuriosito da subito… È una cosa di cui non so in nessun modo valutare gli effetti, però all'improvviso, dopo molti anni di consumo di immagini, una forma di comunicazione fra le più antiche, cioè la scrittura, trova posto all'interno della comunicazione più moderna che ci sia. Questo forse può aiutarci a capire quanto sia ridicolo distinguere ancora fra nuovo e vecchio, tra antico e modernissimo, e ci dice anche come lo sviluppo dei fatti non sia mai unilaterale, ma sia invece pieno di continui ritorni, di continue negazioni, di sorprese, di meticciamenti inattesi»[1].
Allo stesso modo come non stupirsi di un libro come Atlante occidentale (Einaudi, 1985) dove Ira Epstein, il protagonista, scrittore in odore di Nobel fa amicizia con Pietro Brahe, fisico impegnato nel progetto dei laboratori Cern di Ginevra, laboratori e acceleratore di particelle che Del Giudice vede già realizzati, proprio come sono ora.
Fisica delle particelle: forse Del Giudice, anche volendo non avrebbe potuto scrivere di altro. E poi la fisica era in debito con la letteratura e qualcosa doveva restituirle (ad esempio i quark traggono il loro nome da un romanzo di James Joyce, Finnegans Wake). Se la fisica delle particelle è la branca sperimentale della fisica moderna che studia i costituenti e le interazioni fondamentali della materia e della radiazione, seguendo i principi della meccanica quantistica e facendo riferimento agli studi delle particelle create negli acceleratori ad altissima energia e non presenti in natura in condizioni ordinarie, questa sembra la descrizione dello stile che lo caratterizza più profondamente.
Invisibilità, fasci collimati di luce e altissima energia, tempo e condizioni non presenti in natura, questo è Del Giudice. Nelle sue pagine c’è una costante tensione verso l’oltre, l’altrove, l’invisibile come quando fa dire ad Esptein, rivolto a Brahe: «Non vede come le cose che cominciano ad esserci, che ci saranno, sono pura energia, pura luce, pura immaginazione? non vede come le cose ormai cominciano ad essere non-cose?».
La narrazione come illuminazione
Ma c’è anche la luce, nelle sue righe: basti pensare a Nel Museo di Reims (Einaudi, 1988) il cui protagonista sta perdendo la vista per una malattia mal curata e così stabilisce di conservare nella sua mente come ultime immagini quelle di alcuni quadri sparsi nei musei d’Europa, di cui lo stesso scrittore stesso ebbe a dire: «Ho sempre pensato che ogni parola che scriviamo fa un cono di luce e questo cono di luce crea una zona d’ombra. Io fin qui ho cercato di avere cura di questa zona d’ombra senza renderla esplicita, perché mi auguravo che proprio in quell’ombra passasse il mistero, passasse la zona notturna di una scrittura, la mia, che è apparentemente molto luminosa, molto nitida, netta». Quindi la narrazione ha il compito di illuminare il mistero, ma non troppo; quanto basta per intuirne, a volte illusoriamente, quantomeno le radici se non i confini. Su questo proprio Jurij Oleša concludeva: «Cos’è il sole? Nulla della mia vita si sarebbe potuto realizzare senza l’aiuto del sole, libero o nascosto, reale o metaforico. Qualunque cosa che io abbia fatto, qualunque luogo io abbia visitato, in sogno, vegliando, nell’oscurità, da giovane come da vecchio, sono sempre stato sull’estremità di un raggio di sole».
E per ultimo il tempo, tempo che seguendo regole quantistiche si fa luogo altro e diverso, quel tempo su cui, sempre in Atlante Occidentale, il protagonista si domanda, in un passo dove c’è tutto il senso della letteratura e del narrare «e quant’era questo tempo, dato che il tempo esterno restava fermo, tempo zero, e il tempo interno alla visione di una storia non andava né avanti né di lato, ma ovunque nello spazio, determinato dalla storia stessa?». Tempo che in Del Giudice, ci dice Tiziano Scarpa «è il sostantivo più ripetuto. Ricorre quasi duecento volte» in quanto alla fine tutta la sua letteratura non sarebbe altro che un unico tentativo di mettere in evidenza «ciò che scorre sotto la crosta terrestre dell’epoca […] la cosa gratuita, indisponibile, irreparabile: il tempo». Bellissimo in questo senso l’incipit di Mercanti del Tempo (contenuto ne I racconti): «Rabat. Marocco, seconda settimana d’Autunno. Ieri per la prima volta ho assistito ad una transazione commerciale riguardante il tempo».
Da questo non luogo e non tempo, da questo multiverso, c’è sempre un io narrante che dialoga con l’altro e con il lettore, come accade nel fortunato Staccando l’ombra da terra (Einaudi, 1994). Qui gli aeroplani non li osserviamo da fuori, come accadeva a Brahe e ad Epstein, ma dal di dentro e ci sentiamo e pensiamo come novelli Saint-Exupéry. E di nuovo riaffiora la suggestione del non essere, del rendersi invisibili. «Antoine, che era soldato, staccò l’ombra/ da terra a luglio, lasciando sull’erba/ se stesso e un acre sapore di fulmine;/ qualcuno, perplesso, forse lo vide/ farsi nera incrunatura nel cielo/ e sparire, dimenticarsi in esso» ha scritto Pierluigi Cappello in una poesia dedicata proprio a Del Giudice.
Una sapiente gestione degli incipit e delle chiuse
E per terzo criterio di valutazione e dimostrazione, tornando all’inizio di questo teorema, cosa si potrebbe citare? Per esempio la capacità di uno scrittore di dominare inizio e fine di un’opera. Confessatelo, non è quello che ogni lettore consumato fa sempre, curiosando in libreria? La prima e l’ultima pagina, l’incipit e la conclusione, svelano all’occhio esperto e al suo istinto tante informazioni e assai più fedelmente che i risvolti e la quarta di copertina. Dei bellissimi incipit di Del Giudice si è già parlato, perciò lasciamolo concludere con Atlante occidentale che termina con questo magistrale dialogo: «Adesso dovrebbe cominciare una storia nuova. E questa? Questa è finita. Finita finita? Finita finita. La scriverà qualcuno? Non so, penso di no. L’importante non era scriverla, l’importante era provarne un sentimento».
Vi sarebbero tanti altri criteri a sostegno dell’ipotesi, quali ad esempio la potenza delle descrizioni, come accade nelle pagine di Evil life o in quelle bellissime e dotate di un ritmo semplicemente geniale, dedicate ai fuochi di artificio in Atlante Occidentale.
Crediamo che il teorema sia più che dimostrato, sperando di aver favorito la “riemersione” e soprattutto la diffusa lettura, di uno scrittore vittima di una sorta di paradosso che oppone in modo inversamente proporzionale la sua grandezza alla sua popolarità presso il grande pubblico.
Ma Del Giudice i paradossi certo doveva ben tollerarli e addirittura amarli, dato che ha scritto di coloro che potevano scrivere e non hanno mai voluto, come Roberto Bazlen, intellettuale triestino la cui vita è al centro del romanzo Lo stadio di Wimbledon (Einaudi, 1983), ma ha trattato anche di quelli che scrivere non volevano e non potevano, essendo immaginari, come successe quando pubblicò una recensione del romanzo di un autore mitteleuropeo inesistente Anton Ganzfalsch (ganz falsch in tedesco vuol dire “tutto falso”) e il libro fu insistentemente cercato in libreria anche dagli intellettuali addetti ai lavori. Infine lui che certo invece apparteneva ad una terza categoria, quella di chi molto altro voleva scrivere ma che purtroppo non riesce più.
[1] Tratto da un’intervista a Del Giudice per Telecapodistria nel 1997.
Massimiliano Bellavista
(www.bottegascriptamanent.it, anno XIV, n. 150, marzo 2020)