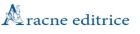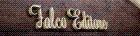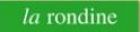Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Mario Saccomanno
A. XIX, n. 210, apr. 2025
Gian Corrado Stucchi, scrittura
fra passato e utopie futuribili
di Guglielmo Colombero
L’Analisi letteraria di un autore eclettico e dallo stile seducente,
un viaggio che conduce verso percorsi narrativi fra realtà e finzione
Continua l’attività di Bottega editoriale relativa ai Saggi critici sulla migliore Letteratura contemporanea.
In precedenza sono state pubblicate altre analisi critiche, dedicate alle figure di Mimmo Gangemi (Mimmo Gangemi: poesia e narrazione tra natura, morte, vita e appartenenza, in: www.bottegaeditoriale.it/primopiano.asp?id=235
) e di Massimiliano Bellavista, facente parte del “Portafoglio Scrittori contemporanei di Bottega editoriale” (I labirinti poetici e narrativi di un autore coinvolgente: Massimiliano Bellavista in: www.bottegaeditoriale.it/primopiano.asp?id=236). Autore dei due saggi è il critico letterario torinese Guglielmo Colombero.
Analogamente per l’analisi critica su un altro autorevole autore facente parte del “Portafoglio Scrittori contemporanei di Bottega editoriale”, nonché emblematico rappresentante della Letteratura contemporanea: Fabio Bacile di Castiglione ( www.bottegascriptamanent.it/?modulo=Home&id=152&ricerca=). Autore dell’analisi dal titolo Un vitalismo e un’analisi del senso: le opere di Fabio Bacile di Castiglione è il docente universitario calabrese Marco Gatto, docente universitario di Teoria della Letteratura.
In seguito è sopravvenuta alla nostra attenzione una personalità non facente parte del nostro “Portafoglio”, non vivente, ma sempre coeva: Albert Caraco. Autore di tale saggio, (Lo scrittore più cupo del mondo:
la figura del particolare Albert Caraco , in www.bottegaeditoriale.it/primopiano.asp?id=237) è il critico letterario bolognese Rino Tripodi.
Qui di seguito un’analisi, sempre per mano di Guglielmo Colombero, su un altro rappresentante della Letteratura contemporanea, squisitamente eclettico e amante della sperimentazione, facente anche lui parte del “Portafoglio Scrittori contemporanei di Bottega editoriale”: Gian Corrado Stucchi.
Se è vero che il gusto per l’enigma è uno dei fertilizzanti più efficaci dell’ispirazione letteraria, non c’è dubbio che nelle pagine scritte da Gian Corrado Stucchi questo prezioso concime sia stato sparso in abbondanza. La struttura della sua narrazione è labirintica, sfaccettata in un continuo gioco di specchi e rimandi, in incessanti mutamenti di prospettiva che comunque racchiudono, sotto una patina di ambiguità e di mistero, una logica ferrea, implacabile, addirittura “quantica”, come vedremo in uno dei suoi romanzi più inquietanti. La disinvoltura con cui l’autore naviga in un arcipelago di intriganti contaminazioni culturali non smette mai di stupire anche il lettore più smaliziato: si passa dallo scenario postapocalittico di una futura utopia regressiva alla cruda e violenta realtà, tristemente attuale, dell’Africa devastata da insanabili conflitti etnici; dalla contemplazione delle radici ancestrali dell’aggressività umana vista attraverso lo sguardo di una quercia millenaria alla catena di morti misteriose in un immediato futuro dai connotati angosciosi; dall’apologo fiabesco sull’emarginazione dei diversi alla rievocazione nostalgica di un mondo contadino destinato a scomparire.
Gian Corrado Stucchi è nato nel 1953 a Muggiò, una cittadina brianzola distante pochi chilometri da Monza, punto di contatto sui generis fra le antiche tradizioni medievali da un lato – testimoniate dai nomi delle tre contrade principali: Barus, Bourghett e San Roch – e, dall’altro, i moderni insediamenti industriali – come Star e il panificio Panem, nonché le innumerevoli cooperative che le fecero guadagnare l’appellativo di “città rossa” della Brianza.
Notevole il patrimonio naturale rappresentato dal parco naturale della Collina di Superga, nell’ambito dell’oasi di parco Grugnotorto: il canale Villoresi, nella quiete del crepuscolo, appare come un limpido specchio d’acqua arancione increspato da riverberi fiammeggianti.
Laureato in economia, Stucchi ha ricevuto numerose assegnazioni di lavoro all’estero: Arabia Saudita, India, Libia, Marocco, Messico, Nigeria, Gran Bretagna, Romania e Svizzera; è da queste peregrinazioni che ha attinto sicuramente non pochi spunti per la sua narrativa (soprattutto nell’Africa evocata in Nero Opaco). Attualmente è in pensione, e risiede a Bergamo. Finora ha all’attivo cinque opere narrative: Deywoss (Kimerik, 2017, pp. 288, romanzo che sarà tradotto e pubblicato anche in Francia da Èditions Laborintus); Nero Opaco (Kimerik, 2017, pp. 274); I dialoghi della quercia (Il Seme Bianco, 2018, pp. 168); Le straordinarie avventure di Nerina e dei suoi numerosi amici (Kimerik, 2018, pp. 52); La puntura del bombo (Bottega editoriale, 2019, pp. 116). In procinto di pubblicazione è Ricordi lombardi, mentre ancora in cantiere Come piegati dal vento, un romanzo ucronico ambientato fra la Lombardia e il Tirolo.
Alla ricerca della Sostanza che libera la mente
«L’immensa foresta di querce sanguinolente, abitata da mille fiere, aveva coperto da tempo parte della pianura, impedendo di intravedere il mondo che era stato prima della Rivelazione, ma il sole, salendo poco a poco, riusciva come d’incanto a resuscitare labili contorni di borghi disabitati. Più in là, si poteva scorgere, lontano, il profilo dei Monti Bassi, oltre il mare liscio come uno specchio che rapidamente, in epoca recente, aveva sommerso le parti più basse della landa ed ancora non aveva un nome. Lì, in passato, viveva l’uomo in grandi comunità, sfruttando la terra per alimentarsi e soddisfare le proprie abitudini innaturali, ora proibite». Questo è lo scenario che, dinnanzi agli occhi di Garbass, uno dei personaggi chiave di Deywoss, si apre alla visione di un mutamento epocale, la scomparsa traumatica di una civiltà (quella consumistica), spazzata via e annichilita da un nuovo ordinamento decretato da una volontà suprema e assoluta: il Creatore.
Il critico letterario Renato Minore, nella sua Prefazione, scrive che il romanzo di Stucchi contiene una «variante della distopia, cioè l’antiutopia o utopia negativa attraverso cui s’intende la descrizione e la rappresentazione nei diversi aspetti umani sociali e tecnologici di un’immaginaria società o comunità proiettata nel futuro. Un futuro che può essere prossimo o remoto, dove può capitare che alcune tendenze sociali, politiche e tecnologiche del presente siano portate a estremi negativi».
L’universo dominato dal Deywoss (così si fa chiamare il Creatore) è totalitario, oppressivo, regolato da leggi inflessibili che restringono i bisogni umani all’essenziale: un allucinante (e allucinato) riferimento alla Cambogia dei Khmer rossi, regredita a uno stadio primordiale impregnato di terrore.
Affiorano dal testo illustri reminescenze letterarie: 1984 di George Orwell (la Sphyx come ipnotica Grande Sorella); Il mondo nuovo di Aldous Huxley (la procreazione pianificata attraverso una somministrazione controllata del piacere sessuale); Noi di Evgenij Zamjatin (l’omologazione sociale scandita da minuziose direttive che non ammettono trasgressioni). Ma sono rintracciabili anche angosce kafkiane (un senso incombente di catastrofe che aleggia sui protagonisti, spesso sperduti in una natura minacciosa e ostile) e suggestioni millenariste da Il nome della rosa di Umberto Eco (il fanatismo dell’Inquisizione, l’efferata ritualità delle torture inflitte agli eretici o presunti tali).
Sin dalle prime battute, il romanzo di Stucchi ci immerge in un clima delirante di misticismo medievale: quasi una trasposizione letteraria di alcune indimenticabili sequenze de Il settimo sigillo di Bergman. Lacere moltitudini di disperati in fuga dalla carestia, tallonati da branchi di bestie feroci; il commercio degradato a forme ataviche di baratto; la setta ereticale della Cricca dei Dieci incalzata senza tregua dal sadico, implacabile Inquisitore Dablass, che si lascia dietro una scia di cadaveri orribilmente seviziati con il ferro e con il fuoco.
Garbass è un Trasportatore Autorizzato che viaggia a dorso di un mulo, e il suo possente aspetto fisico, accuratamente tratteggiato dall’autore come nelle incisioni di Dürer, rispecchia la sua attitudine alla fatica quotidiana: «Il cranio rasato ogni settimana, come stabilito dalla Regola, lasciava intravedere una calvizie quasi completa. I modi erano soavi, la voce metallica, vibrante, penetrante, precisa, come quella di un rumore lontano, se greve, che passa inascoltato; forse è monotono, non ha niente da rivelare, mentre i sensi ben si allertano al suono acuto che risveglia l’attenzione e ci si domanda cos’è: così era la voce di Garbass. Aveva una statura inferiore alla media, gambe leggermente arcuate e muscolose come lontre di fiume che denotavano antiche, ma certe, origini contadine. Le braccia erano tozze e forti con grossi bicipiti che si gonfiavano a dismisura quando, sollevando dei pesi, li mostrava con orgoglio per impressionare Nepo, sua ultima discendenza».
Sprigiona una selvaggia vitalità anche il ritratto di Zeyp, ragazza sensuale e ribelle che pagherà duramente il rifiuto di sottostare alla tirannide del Deywoss. Non a caso il suo sguardo è rivolto verso il volo libero dei gabbiani, le sole creature in grado di sottrarsi al potere opprimente che invece stringe in una morsa spietata quel che rimane del genere umano: «Splendida nelle sembianze ma acuta nello spirito, Zeyp si stava pettinando i lunghi capelli neri, nuda davanti allo specchio. Sulla sua destra, al di là dell’ampia vetrata che dava sulla terrazza, si apriva un’immensa vista sul golfo placido. I gabbiani galleggiavano molli nell’aria del mattino, aspettando pazienti che si formasse sulla superficie del mare una palla di pesci azzurri per poi, a turno, precipitarsi come dardi nell’acqua per risalire al cielo con una piccola alice guizzante nel becco. Il disco del sole si intravedeva appena tra le nebbie lontane dell’alba».
Anche Nepo, il giovane e irrequieto nipote di Garbass, si mostra insofferente verso lo steccato concentrazionario in cui si sente confinato, e ricorre a un rito detto “Apanu”, una specie di seduta erotica virtuale che attraverso sostanze allucinogene placa la sua tempesta ormonale (e anche qui la simbologia del volo dei gabbiani sottolinea l’anelito di libertà che pervade l’intera visione): «Si trovava vicino ad un grande lago plumbeo, increspato di piccole onde nervose, il cielo terso emanava una luce abbagliante, fastidiosa, da far socchiudere gli occhi. Sulle montagne lontane si intravedeva, stagnante, una nebbia grigia e faceva freddo, molto freddo. Il vento gelido sollevava dallo specchio d’acqua brevi flutti che si infrangevano di continuo contro i platani spogli della riva, coprendoli con un sottile strato di ghiaccio e formando immagini bizzarre. La città alle sue spalle sembrava animata di un andirivieni di persone, guardò intorno a sé: si trovava su un’ampia passeggiata lungolago. Quand’ecco, intravide in lontananza una figura femminile che si stava avvicinando mentre due gabbiani bianchi la sfioravano, volando sopra di lei. Di certo, si disse, quella ragazza stava cercando lui. Mentre si approssimava, scorse meglio i particolari della giovane: alta, slanciata, portava un ampio cappello di feltro e un lungo pastrano nero».
Nei caratteri dell’Eretica e della Cricca dei Dieci – guerriglieri montanari in possesso di una misteriosa Sostanza (ricavata dalle lumache) in grado di svincolare le menti dal controllo del Deywoss –, rivive un vero e proprio flashback delle scorrerie e delle peregrinazioni della setta dei dolciniani, riportata alla luce nel già citato capolavoro di Umberto Eco: «Stanno cercando l’Eretica e la Cricca dei Dieci che vivono spostandosi continuamente sui Monti Alti. Non sono persone normali: Dicono che siano comandati da una Signora e formino una comunità mista di uomini e donne. Come sfuggano alla Regola e non sono ancora stati levitati nessuno lo sa. L’unica cosa certa è che si sostentano cacciando animali di cui si nutrono insieme ai frutti della foresta, non disdegnando all’occasione d’appropriarsi di cose non loro. Le sottraggono a chi incontrano per i monti. Vivono armati e, a quanto pare, uccidono le persone. Di più non so».
Residui di mitologia arcaica e suggestioni fortemente psichedeliche scaturiscono, in un crescendo febbricitante, dall’incontro fra Garbass e la Sphyx, che si presenta «completamente nuda e senza capelli, una nudità semplice che non trasmetteva alcuna sensazione legata all’istinto riproduttivo, il pube liscio senza i segni del sesso, i seni appena accennati, un sorriso mite e benevolo. Una particolarità saltava però all’occhio: non aveva unghie, né alle mani né ai piedi, le dita affusolate e lisce fin sulle punte! Raggiunto Garbass, la Sphyx lo prese per mano e, senza dire una parola, lo condusse verso il masso che, visto da vicino, aveva un colore blu come quello del cielo nelle notti limpide senza luna». Di fronte a questa ammaliante apparizione, Garbass avverte dapprima di perdere i sensi, «una leggera vibrazione e una lieve sensazione di fragranza sconosciuta»: distillando abilmente ogni sfumatura sensoriale, Stucchi rappresenta l’involucro seduttivo del Potere, ingannevole e insinuante come la carezza di una Sirena, ma che dietro un sorriso mellifluo nasconde il ghigno letale della Medusa.
Il lato oscuro del Deywoss si incarna atrocemente nella figura di Dablass, l’Inquisitore, la cui deformità fisica (degna di un letamaio) rispecchia la sua indole perversa: «La sua corporatura massiccia e un grande ventre facevano sospettare una vita privilegiata con accesso a cibi di cui tutto il resto della popolazione ignorava l’esistenza. Il cranio grande e tondo, evidenziato dalla rasatura della Regola, metteva in risalto un viso gioviale e sempre sorridente con enormi occhi porcini color verde scuro, i bulbi segnati da sottili capillari rossi. Non si poteva fare a meno di notare la sua grossa protuberanza sul collo che, non avendo avuto origine da malattia, doveva per forza essere una tara ereditaria. Le mani suine erano particolari per la mancanza di due dita a causa di un incidente accadutogli manovrando le macine di pietra del suo mulino».
Un sentore animalesco, che emana miasmi malsani, caratterizza anche gli sgherri al seguito dell’Inquisitore, un vero e proprio branco di lupi assetati di sangue, sinistra prefigurazione metastorica delle SS hitleriane che insieme alle Brigate nere fasciste terrorizzavano le valli del Nord Italia dando la caccia ai partigiani: «Gli sparuti abitanti della Val Brumana scorsero un giorno risalire per la Via Cexana un gruppo di persone mai visto. Un uomo di circa cinquanta cicli conduceva per il morso un grande cavallo nero sul quale erano sistemati alcuni contenitori, come borse metalliche color argento, di fattura sconosciuta. Si chiedevano cosa potessero trasportare, però, alla domanda, il pensiero subito si fermava, perché l’anomalia del gruppo non era data dai recipienti, ma dalle sei persone armate che seguivano il destriero senza portare alcuna merce, se non le vettovaglie per sopravvivere all’addiaccio. Una stirpe mai vista, si dissero, e tutti uguali da sembrar fratelli per come andavano agghindati nei panni e negli accessori ma, soprattutto, per i tratti brutali dei visi. “Gente di fuori” meditava chi li incontrava, scorgendo gli occhi chiari e le fattezze selvatiche che emanavano una scia aromatica di urina animale. Le corporature agili, come fatte di soli nervi, senza grasso o muscoli superflui, avevano movenze da felino».
L’epilogo di Deywoss è tutt’altro che consolatorio: nonostante una momentanea sconfitta dell’Inquisitore Dablass (comunque costata un prezzo altissimo di sangue innocente), l’autore inscena le minacciose avvisaglie di una futura e ancora più cruenta repressione pianificata dal Deywoss. I presagi di sciagura divampano dalla natura stessa che circonda i montanari e i valligiani, attraverso alcuni fenomeni inspiegabili da loro interpretati come manifestazioni della collera divina, mentre altre colonne di mercenari già sono in marcia, armate con nuovi e più distruttivi congegni di morte: «In direzione del Picco, quel mattino, gli abitanti dei Monti Alti videro al loro risveglio strani bagliori che apparivano e sparivano nel cielo, roteando come polvere alzata dal vento sul terreno arso. Il fenomeno durò una mezza giornata e paralizzò tutte le attività di uomini e donne che, presi dall’ansia, si posero grandi interrogativi per quell’inaspettato spettacolo della natura. Le nevi eterne sotto le cime più alte riflettevano una vivida luce color dello smeraldo che si divideva poi in tutte le sfumature dell’iride, dando vita a molteplici arcobaleni che non curvavano però in un caratteristico aspetto naturale, ma si innalzavano irti e numerosi verso lo zenit della volta celeste. Le genti della Valle Ittira, in particolare, si chiesero più di altri il motivo di quei segnali di certa sventura, essendo ancora evidente in più punti l’impronta della tempesta paglierina che aveva coperto le loro case. Si risvegliò in tutti loro un senso mistico, ormai assopito dallo scorrere delle generazioni, narcotizzate dalle certezze di una vita senza segreti o cose nuove da scoprire. Deywoss e la Regola era tutto quello di cui le loro menti avevano da sempre bisogno per soddisfare eventuali esigenze per il divino ed erano certezze che non ammettevano altri credo».
Sangue e diamanti nel cuore di tenebra africano
Nel suo secondo romanzo, Nero Opaco, Stucchi compie un brusco salto di qualità: la rarefatta dimensione fiabesca in cui si muovevano quasi al ralenti i personaggi di Deywoss deflagra di colpo in una cronaca cruda, serrata, incalzante, dal ritmo convulso, quasi parossistico. Il suo sguardo è quello del corrispondente di guerra catapultato nel bel mezzo di un’orrenda carneficina, che registra gli eventi con freddo distacco professionale soffermandosi, con il suo impassibile obbiettivo, sui dettagli più raccapriccianti.
Siamo in Nigeria, ai giorni nostri. Due italiani piuttosto corrotti se la spassano alla grande nella capitale: Paolo, faccendiere e tangentista, nonché accanito erotomane, che nel tempo libero scrive, guardacaso, un romanzo dalla trama molto simile a quella di Deywoss, e il suo amico Luca, consigliere del governo e losco tessitore di transazioni poco pulite: «i barconi cisterna che lasciano il delta del Niger carichi di oro nero spacciato con la connivenza di politici e dirigenti di turno, e via a trasbordarlo sulle petroliere in attesa al largo». Entrambi amano Julia, giovane e disinibita rampolla di un ricco imprenditore messicano, che possiede una «predisposizione naturale per gli uomini maturi ai quali lanciava, alla prima occasione, sguardi intriganti anche in presenza delle consorti». Paolo e Luca sono immersi nel vizioso lusso mondano che offre la complicità affaristica con le élites locali: «Ci si spostava a fatica tra i tavoli da gioco, in un ambiente saturo della più variegata umanità della capitale: puttane nere ma anche asiatiche, quest’ultime molto avvenenti e avvolte in effluvi quasi visibili di profumi contraffatti, giravano a caccia sfrontata di clienti; curiosi perditempo spendevano qualche spicciolo alle slot machine solo per avere l’opportunità di guardarsi intorno; camerieri grondanti di sudore portavano vassoi con bicchieri di birra che tracimava a ogni passo sulla lurida moquette damascata. Ovunque c’era odore d’Africa, un sentore unico, un misto di sudore ed essenza di legno pregiato, destinato a rimanere nelle narici per tutta la vita».
La “dolce vita” dei due italiani viene sconvolta da un improvviso colpo di stato militare, che abbatte il regime con cui loro avevano intrecciato una fitta rete di connivenze, e lo scenario godereccio del casinò dell’Eko degenera all’istante in un paesaggio da incubo, dove il paradiso del piacere sprofonda repentinamente in una spaventosa bolgia infernale: «Escludendo i numerosi cadaveri per le strade, lasciati giorni e giorni alla mercé delle mosche, con l’intenzione di dare esempi truci a tutti su quello che poteva accadere, in quel golpe non ci fu eccessivo spargimento di sangue. I conti venivano regolati con una semplice cerimonia, uguale in tutto il paese e conosciuta a Victoria Island come “spettacolo del sabato mattina”. Quel giorno, sul viale in direzione del Bar Beach, si poteva vedere sfrecciare verso mezzodì una colonna di camionette militari. La gente accorreva numerosa sulla spiaggia per la festa. Si scaricavano barili vuoti di petrolio e con essi le vittime da giustiziare, non più di dieci persone, che venivano legate ai bidoni e poi fucilate con disinvoltura, come se si trattasse del tiro a segno in una sagra di paese».
Braccati dai nuovi padroni locali, che intendono processarli per corruzione, i due italiani trovano asilo presso l’etnia ribelle dei kotoko, guidata da un capo carismatico, Sylvester Onopeya, e indottrinata da una specie di santone, l’eremita Nalut, che «possiede l’accesso al sapere assoluto, una prerogativa rara, che nessuno può insegnare, perché nasce e matura con la solitudine». In quest’ultimo personaggio Stucchi infonde un fascino primitivo e barbarico che sembra scaturire dalle pagine più suggestive del Joseph Conrad di Cuore di tenebra (in particolare quelle che descrivono la nera compagna sciamana del folle Kurtz): Nalut sembra non appartenere «a nessuna razza conosciuta. Statura bassa con arti sottili, pelle chiara dal colorito giallastro e un viso che riuniva tutte le caratteristiche somatiche dell’umanità: zigomi alti, occhi vagamente orientali, naso camuso, bocca tumida, capelli a grano di pepe e bizzarre orecchie accartocciate senza lobuli. La corporatura esile, essenziale, metteva in bella mostra il glande del pene, tenuto scoperto da un anello d’oro».
La fusione interiore di Nalut con il paesaggio della giungla e con tutte le creature viventi che la popolano è totale, indissolubile, panica, radicata in una natura inaccessibile e violenta nella stessa misura dei bellicosi clan tribali che ospita e nasconde: «se ne stava seduto, immobile su una lastra di pietra, ad assistere al sorgere del sole, mentre lì accanto, la misteriosa colonna proiettava un’ombra tanto lunga e sottile da sembrare una gigantesca biscia viscida che strisciava tra le pietre del vulcano. Le prime grida dei babbuini iniziavano a levarsi dalla città abbandonata, echeggiando fino all’eremo dove il fumo del piccolo focolare saliva dritto nel cielo, indisturbato dal benché minimo alito di vento. Ai piedi della montagna, la massa scura della giungla si estendeva in ogni direzione fino all’orizzonte, avvolta da una nebbia azzurrognola che assopiva ancora tutte le creature».
Singolare controparte bianca di Nalut, in quanto anch’egli solitario e votato a una causa umanitaria cui consacrerà la sua stessa vita, è un maturo mercenario idealista, il conte Von Soren, affiancato da una assai più giovane moglie, la seducente quanto tormentata Zeynep, che irradia da tutto il suo corpo il richiamo erotico di una dea levantina: «Il grande incanto del viso derivava da un delizioso e inusuale nasino impercettibilmente incurvato all’ingiù che tradiva le sue origini turche e dagli ammalianti occhi, di un colore indefinibile tra il blu e il viola, da cui traspariva a volte, secondo l’umore, la leggera ombra della sua struggente tristezza».
In questo complicato mosaico di personaggi e situazioni irrompe la bestiale figura di Kudinge, il capo dei banditi congolesi, nel quale Stucchi concentra una summa quasi insostenibile di perfidia, infamia e sadismo: «ossuto come un cane randagio, una folta capigliatura arricciata a mo’ di turbante, tutto agghindato con collane di conchiglie e in mano un massiccio revolver».
L’odio tribale esplode in tutto il suo orrore, e una pioggia di sangue inonda le pagine del romanzo, colpendo il lettore come una scarica di pugni nello stomaco: «Il capo gli si avvicinò spalancando gli occhi iniettati di sangue, una maschera mostruosa tra le ombre proiettate dalle fiamme. Non disse una parola ma lo fissò̀ con morbosa curiosità, poi comandò qualcosa ai compagni che afferrarono un altro kotoko, gli appoggiarono prima una gamba e poi l’altra al ceppo, amputandogliele entrambe con diversi colpi sotto il ginocchio, ma contrariamente alla prima vittima, anziché fermare il sangue con la pece, tagliarono anche le braccia e lasciarono il dorso a dimenarsi urlante nella polvere finché perse i sensi in un lago di sangue».
Avidi dei diamanti che, celati all’interno di un giacimento segreto, costituiscono la risorsa essenziale per i kotoko, i congolesi non si fermano di fronte a nulla pur di scovare il nascondiglio delle pietre preziose: «un bandito estrasse da una tasca un rasoio arrugginito, si avvicinò e con precisione chirurgica incise un taglio sottile, aprendo con non poco spargimento di sangue l’addome del malcapitato dal pube allo sterno, e mettendo in mostra le viscere che iniziarono a traboccare».
L’essenza più mostruosa del Male è incarnata in un altro personaggio memorabile, Alawi, il maestro torturatore al servizio di Kudinge, «un gigante alto due metri, grondante di sudore e con un ventre talmente gonfio da far apparire le sue dimensioni quasi disumane», e con «occhi dai bulbi giallo sporco, sicuro indizio di una grave malattia infettiva. Tra le mani teneva due affilati coltelli da macellaio che mostrò agli europei, mimando il taglio della carne». Il suo padrone lo definisce «un artista unico, un impareggiabile professionista del dolore altrui».
Il lento e metodico smembramento dello sventurato Luca da parte di Alawi acquisisce poco a poco la valenza terribilmente emblematica di una nemesi vendicativa: l’Africa spartita e saccheggiata dal colonialismo europeo applica la legge del taglione sul corpo di un ostaggio bianco in un rigurgito di selvaggio furore cannibalesco. Il messaggio è analogo a quello di un velenoso film di Marco Ferreri del 1988, Come sono buoni i bianchi, dove svanisce ogni speranza di dialogo fra due culture separate da un abisso di storiche efferatezze, che, fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, culminarono nei famigerati “orrori del Congo”, perpetrati dai colonizzatori belgi e denunciati dallo stesso Conrad in Cuore di tenebra.
Come in Deywoss, Stucchi scansa qualsiasi tentazione di lieto fine, e non concede ai suoi protagonisti nessuna possibilità di riscatto: persino il doppio matrimonio tribale che il capoclan Sylvester impone a Paolo (il quale sposerà sia Zeynep, rimasta vedova e invaghita di lui, che una ragazzina bantù di nome Azeb, con un rito officiato da Nalut) lascia l’italiano smarrito e angosciato, in una lussureggiante cornice naturale che l’autore pervade di accese tonalità cromatiche. «Non passò molto tempo dall’annuncio fatto ai promessi sposi quando, improvvisamente, nel giardino di baobab esplose l’unica fioritura dell’anno. I carnosi petali vermigli sbocciarono tutti insieme, scoprendo lunghi e gracili pistilli, l’apice sormontato da gustosi capolini che divennero leccornia per nugoli di falene giganti, i dorsi decorati con teschi umani, che presero a succhiare avidamente il nettare buono, librandosi nell’aria come colibrì. All’alba fu il turno di vorticosi sciami di bombi che avvolsero le fronde finché i fiori caddero esausti, ricoprendo di un manto soffice l’erba cocuyo del prato sottostante. Si trattava chiaramente dell’evento tanto atteso per il matrimonio».
L’epilogo cinico e amaro di Nero Opaco coincide con l’apocalittico olocausto finale dei kotoko e con la prigionia di Paolo e di Zeynep, senza via di scampo, all’interno del serraglio di un emiro nero rintanato in una fatiscente reggia di fango giallognolo: stavolta è Thánatos a trionfare su Eros, e il faccendiere italiano salva la pelle, ma al prezzo della propria dignità, restando vivo ma al pari di un sughero che galleggia in un cratere colmo di sangue.
L’Africa narrata da Stucchi è percorsa da bagliori sinistri, immersa in abissali oscurità, cavità echeggiante di minacciose dissonanze, di assordanti silenzi, di tremende urla di agonia: scrigno di verità inconfessabili, il Continente nero appare costellato di inguaribili cicatrici storiche che in Nero Opaco continuano dolorosamente a sanguinare.
La quercia millenaria spettatrice della Storia
Esiste, nella multiforme mitologia irlandese, una leggenda particolarmente suggestiva: ne è protagonista Fintan, uomo e druida primordiale, che visse dall’epoca del Diluvio fino alla conversione dell’Irlanda al cristianesimo, passando per metempsicosi attraverso diversi stati ferini, allo scopo di tramandare il patrimonio del sapere e della conoscenza della Storia. I dialoghi della quercia, terza opera letteraria di Stucchi, si innesta nel solco di questa antica tradizione fiabesca: qui è la quercia, pianta monumentale trasfigurata in entità pensante, a solcare i secoli per assistere all’evoluzione della razza umana.
Il soliloquio della quercia inizia sin dal momento della sua nascita, nello stadio embrionale di ghianda che continuerà a crescere penetrando con le sue radici l’humus fertile del bosco: «La buona stagione sta lasciando il passo al tempo delle nebbie e il sottile peduncolo che mi lega a mia madre alfine si spezza, lasciandomi cadere nell’aria satura di fragranze del sottobosco. Un tuffo sulle foglie accartocciate e, rimbalzando, perdo la cupoletta rugosa che mi ha protetta durante la mia breve infanzia, passata in compagnia di fronde allegre che, mosse dal vento, conversavano incessantemente tutto il santo giorno, per poi ammutolire nello stesso istante, al calar del sole».
Stucchi imprime al racconto un andamento ieratico, quasi sacrale, in grado di cristallizzare lo scorrere del tempo narrativo: il susseguirsi di eventi strani, crudeli o gioiosi, filtrati attraverso lo sguardo sereno – spesso stupito, talvolta attonito – della quercia intelligente, acquista via via le cadenze di una saga epocale. Il primo approccio con il genere umano suscita in lei una curiosità dubbiosa: «Non riesco a crederlo, due animali bipedi, mai visti prima, stanno risalendo il pendio, portando sulle spalle alcuni strani oggetti. Si scambiano l’un l’altro segnali tramite suoni emessi dalle bocche, come se volessero comunicare, segno evidente di menti coscienti, e ciò mi sorprende molto perché ero convinta che fosse una prerogativa della mia specie».
Ben presto la quercia scopre, inorridita, che quegli strani bipedi sono assetati di sangue, che uccidono creature indifese per poi addentarne le carni, e che spesso sono dispensatori di terrore e di morte. Il candore primordiale della pianta ne risulta fortemente turbato, quasi a presagire che, nei secoli futuri, la violenza di quegli esseri sanguinari non potrà che espandersi nell’intero creato: «Guarda là, i bipedi stanno tornando, ce l’hanno fatta, sono sfuggiti all’orsa e portano con loro il cerbiatto morto, i dolcissimi occhi spalancati e tristi, ancor segnati dall’immagine della propria morte. La vita l’avrà abbandonato in fretta con quel taglio alla gola che gronda sangue, segnando il prato di una sottile linea nera. È stato ucciso con un oggetto acuminato che gli ha aperto una vena, ah ora si vede bene uno di quei bastoncini micidiali sporgere dalla ferita... adesso ho capito! Usano lo strumento a corda per lanciarli con forza, ecco com’è successo! Ciò mi convince ancor di più che sono creature eccezionali, hanno scoperto arnesi per uccidere e li sanno usare anche molto bene».
Il sanguinario crescendo di atrocità cui la quercia assiste impotente culmina nel climax dell’uccisione di un essere umano per mano dei suoi simili, e al conseguente scempio del suo cadavere da parte dei carnefici. La quercia scopre così negli umani un’ulteriore, agghiacciante componente, per lei del tutto inspiegabile: il sadismo, il gusto di uccidere non per necessità ma per puro godimento. «La vittima mostra tutt’altra espressione, soffre, è preoccupata, ha paura, sta perdendo le forze, rantola con affanno. Sembra proprio quello che gli inseguitori stavano aspettando: lasciano il nascondiglio e si recano furtivi presso il moribondo, gli girano intorno, lo toccano con un bastone, infine uno estrae l’utensile affilato che teneva custodito in un fodero alla cintura e gli incide il collo. L’uomo sussulta per pochi attimi, quindi rimane immobile. A quel punto un assassino ritaglia dall’addome del cadavere un pezzetto di carne e se lo appoggia con la parte del grasso sulla ferita, legandolo con una striscia di pelle per tenerlo ben saldo. Infine, i due spogliano con gesti convulsi la vittima e si dileguano senza voltarsi. Tutto ciò risulta molto strano: hanno ucciso non certo per fame o difesa, ma per una ragione che al momento mi sfugge. Un’azione innaturale, mai notata in passato e di cui nemmeno riesco a comprenderne lo scopo... mah, sembrano creature veramente particolari, possiedono qualità rare, eppure hanno manifestazioni di una ferocia inaudita da cui appaiono trarre piacere».
Le riflessioni della quercia si fanno sempre più profonde e complesse: decodifica il linguaggio degli umani e lo comprende. Con un’ingegnosa iperbole narrativa, Stucchi fa intercettare dalla quercia un colloquio da cui emergono i principi fondanti della società patriarcale, dell’imperialismo e del colonialismo, enunciati e trasmessi da nonno a nipote: «Ti immagini Balthar? Durante la marcia incontrarono comunità comandate da donne che adoravano addirittura divinità femminili! Come si può pensare di progredire in quel modo? Il maschio, solo il maschio, possiede la forza necessaria per dominare il creato: lui feconda, scegliendo le madri che meglio cresceranno i propri piccoli e, sempre lui, ha inventato il ferro, ricavandolo con un fuoco tanto potente da liquefare le rocce più dure. E con questo metallo abbiamo forgiato le nostre armi, resistenti, dal taglio micidiale. La portentosa scoperta non è servita solo a fare spade, ma anche nuovi attrezzi utili per lavorare il legno o cerchi per rinforzare le ruote. Ogni aspetto della nostra esistenza ha beneficiato di tali innovazioni. Per volontà degli Dei il cavallo e il ferro ci hanno permesso di prevalere sugli altri uomini e imporre a tutti, con il tempo, la nostra lingua».
Una volta padroneggiati gli strumenti idonei a farle intendere la psicologia umana, la quercia si cimenta in ragionamenti più sofisticati, e tenta di individuare la sorgente delle pulsioni di dominio di quegli strani esseri: Stucchi ne tratteggia il sapiente filosofeggiare con qualche sfumatura di ironia, quasi a voler prefigurare, nelle riflessioni di questo vegetale pensante, le future intuizioni di un Freud o di uno Jung: «Ma da dove deriva la loro presunzione di soggiogare il mondo? Sono convinti di essere superiori e hanno capito che la forza è un modo sicuro per avere ragione degli altri. Mi sembrano disposti a tutto, rischiano le proprie vite e sono capaci, pur di prevalere, di un’aggressività inaudita. Inoltre appaiono ben organizzati, conoscono uno schema preciso di come deve essere governata una società. Poi, col tempo, come diceva il vecchio, basterà una generazione, i conquistati si adatteranno alle nuove regole».
Una spiegazione definitiva dei comportamenti umani, comunque, è ancora lontana dal pacato raziocinio della quercia, la quale si rivolge a una entità superiore, la Luce, per ottenere una risposta ai quesiti che la assillano; e la Luce così le risponde: «Sei una buona quercia, salace e saggia, come poche ho notato nella tua specie. Va bene, come desideri, comprendo la tua volontà finale: l’uomo non è stato creato in funzione dell’universo, ma l’universo in funzione dell’uomo, perché in lui è deposto il tempo futuro».
Purtroppo si profilano all’orizzonte tempi duri e dolorosi per la quercia plurisecolare: all’apparire delle legioni di Roma, il suo destino è segnato, dato che lo spirito guerrafondaio della grande potenza latina, predatore della terra e ambizioso del cielo, intende varcare anche i mari e approdare verso nuovi lidi da conquistare. «Chiunque sia la nuova gente apparsa dal nulla, sembra molto diversa da chi li ha preceduti, non solo danno l’impressione di essere ottimi guerrieri, ma anche disciplinati e dimostrano un forte spirito di attaccamento alla patria comune. Inoltre possiedono capacità tecniche mai notate prima; parlano di eseguire opere sfruttando la forza dell’acqua o le caratteristiche del terreno. Sono decisamente all’avanguardia e presumo abbiano sottomesso facilmente i cenomani divenendo i dominatori di questa parte del mondo».
Il fato dell’antica quercia si compie: viene abbattuta, scorticata, trasformata nell’albero maestro di una nave romana, ma, pur fra atroci sofferenze, conserva ancora lucida la propria coscienza: «Il freddo metallo mi lacera provocandomi un bruciore insopportabile, mentre mi tornano alla mente in rapida successione i fatti salienti della vita, da quando caddi piccola ghianda nel morbido sottobosco, al momento in cui capii di crescere, sino a raggiungere la ragguardevole altezza che mi ha permesso di assistere agli eventi, lieti e truci, della valle».
L’epilogo è struggente: la quercia diventata albero maestro si inebria nel solcare le onde marine, vivificata dal vento, ansiosa di nuove esperienze, anelante verso nuovi, infiniti orizzonti.
Ma, durante l’assedio di Siracusa nella Seconda guerra punica, la follia del combattimento finirà per divorare ineluttabilmente gli ultimi giorni di vita della quercia pensante: «Vale la pena di morire pur di provare l’intenso piacere di rinascita che pervade ogni mia fibra in questo momento. Finalmente, all’uscita dal porto, vedo il mare, a svelarmi il segreto della sua immensa vastità che si estende fino a incontrare il cielo, unendosi a lui in una sottile linea nera».
Emarginazione e riscatto fuori dal gregge anonimo
Dopo l’utopia negativa di Deywoss, dopo l’Africa divoratrice di innocenti di Nero Opaco e dopo il flusso insanguinato della Storia umana in I dialoghi della quercia, Stucchi muta registro e con Le straordinarie avventure di Nerina e dei suoi numerosi amici ci offre una parabola accattivante, depurata da qualsiasi sussulto di violenza, incentrata sui temi della diversità, della tolleranza e del pregiudizio. La cornice favolistica rende questo racconto fruibile anche per bambini e adolescenti; tuttavia, Stucchi è abile a non cedere mai all’insidiosa trappola del didascalismo nell’atto di trasmettere i suoi insegnamenti morali, giacché riesce a veicolarli impiegando un procedimento narrativo sobrio, ben calibrato negli snodi cruciali e attento a toccare le corde più sensibili del lettore mediante una raffinata tessitura di simboli e di allegorie.
Il gregge di cento pecore, tutte bianche tranne due, rappresenta la tipica comunità omologata: il colore predominante può assumere, ai nostri occhi, il valore di metafora trasparente del conformismo, delle mode imperanti, dell’appiattimento di una moltitudine nelle forme esteriori per nascondere quel vuoto esistenziale e culturale che si spalanca al di sotto.
Nerina, la pecora nera, spicca come elemento estraneo e disturbante all’interno del gregge monocolore, e solamente la vecchia e saggia pecora grigia, Grigiona, alla quale spetta il governo della comunità, manifesta verso di lei un benevolo atteggiamento protettivo. Il colore grigio, che è intermedio fra bianco e nero, simboleggia l’arte del compromesso fra tendenze conflittuali e, al tempo stesso, la scelta squisitamente politica di tutelare le minoranze, come si evince dalle parole che Grigiona rivolge a Nerina: «Non te la prendere, tu hai un pelo di colore diverso, ma sei bella comunque. Tutti i colori della natura, nella loro diversità, sono ugualmente belli, perché ognuno possiede un fascino particolare».
Una delle pecore bianche, Sciocchina, risulta particolarmente ostile e rancorosa verso Nerina. Si mostra tenace e accanita nel metterla in cattiva luce davanti alle altre amorfe e influenzabili compagne del gregge: un’efficace rappresentazione simbolica della propaganda razzista che non solo stigmatizza il colore della pelle, ma lo associa anche a una presunta malvagità innata nel diverso, che è nero non solo esteriormente ma anche nell’animo.
Fomentando paura e allarme sociale, il fine discriminatorio viene conseguito con estrema facilità. La virulenta campagna diffamatoria scatenata da Sciocchina, infatti, inventa di sana pianta (come, nella quotidianità reale, fanno certi giornali nostrani) un’aggressione che non c’è mai stata da parte della socievole e mansueta pecora nera: «Nerina oltre che brutta è sicuramente cattiva! Ne ho avuto conferma proprio ora. Mi sono avvicinata con l’intenzione di fare la pace. Bastava che lei ammettesse d’essere brutta e io l’avrei perdonata. Invece ha spalancato la bocca per mordermi! È la seconda volta che mi aggredisce, e per fortuna stavolta ho fatto in tempo a scappare!».
L’esito della denigrazione architettata da Sciocchina è l’isolamento di Nerina, la sua emarginazione sociale e culturale, e il conseguente deteriorioramento della sua qualità di vita, ora minata dallo stigma dell’esclusione: «rassegnata, si limitava a mangiare gli scarti che le sorelle bianche le lasciavano, oppure si recava ai margini della foresta per nutrirsi di erbe dure e amare che crescevano attorno ai tronchi degli alberi. Pur non essendo più oggetto di scherno, Nerina comprese che si stava mettendo in atto nei suoi confronti un comportamento ben più grave: veniva isolata. Nessuna le rivolgeva più la parola e lei ne soffriva molto».
Anche un tentativo di omologazione forzata intrapreso in buona fede da Grigiona fallisce miseramente e non fa altro che peggiorare la situazione: cammuffata da pecora bianca con una mano di vernice, Nerina viene smascherata dalla pioggia che rimuove facilmente la patina fasulla: «Ma quale sorpresa! Quando si rialzarono belle asciutte, tutte realizzarono che era improvvisamente ricomparsa la pecora nera. Il temporale aveva lavato via la vernice bianca».
Saranno l’intelligenza e le capacità di adattamento di Nerina a infrangere la gabbia della ghettizzazione, come accade quando, unica e temeraria nell’intero gregge fuggiasco, la pecora nera affronta il famigerato e temibile lupo predatore, e lo convince a desistere dal divorarla utilizzando come argomento la propria diversità, denigrando l’appetibilità delle sue carni con il colore del suo manto: «Tu, Lupo Argento, sbranerai sicuramente le pecore che ti capitano a tiro, ma non ho mai sentito dire che mangi quelle nere! Le mie sorelle dicono che assomiglio a te perché sono cattiva e, dato che mi nutro di erbe amare, la mia carne è immangiabile».
Il funerale della compianta Grigiona costituirà l’occasione ideale per stabilire, una volta per tutte, una pacifica convivenza fra lupi, pecore e montoni, nel nome della fratellanza universale: «Lupo Grigio e Nerina chiesero ai rispettivi gruppi, compresi i montoni, di disporsi in cerchio attorno alla bara di Grigiona e tutti insieme intonarono un sommesso canto funebre».
Morti inspiegabili, torbidi intrighi e crimini mentali
«È morto Flamini, il famoso faccendiere! L’hanno trovato stecchito nella sua casa di Città Alta. In un primo momento si era pensato al solito infarto, ma l’autopsia ha stabilito che si tratta di un decesso innaturale: aveva il cervello sciolto, come se gli avessero iniettato in testa un acido corrosivo che non lascia traccia». Con un incipit folgorante, duro e incisivo come un reportage di cronaca nera, nel suo più recente romanzo, La puntura del bombo, Stucchi si addentra nuovamente nei labirinti enigmatici e tortuosi delle cospirazioni, delle trame occulte e dei delitti apparentemente senza movente. L’implacabile scansione delle morti sospette, sulle quali indaga Gianni Lazzari, giornalista scorbutico e frustrato, ricorda molto da vicino l’atmosfera delirante e quasi metafisica di uno dei capolavori del regista Francesco Rosi, Cadaveri eccellenti.
Il secondo degli incomprensibili decessi è ancora più sconcertante, dato che si verifica per strada, in pieno giorno, e in pochi istanti: «Eppure, anche in questo caso nessun sospetto e, a maggior ragione rispetto al Flamini, è accaduto in pubblico, nel bel mezzo di una passeggiata per shopping. Al marito non ha detto una parola, nemmeno che si sentiva male, ed è collassata su se stessa, mentre una schiuma marrone iniziava a uscirle dalle narici. Non un gemito di dolore, non un grido di panico o sorpresa, la morte non le ha dato il tempo di accorgersene».
La terza vittima è un alto prelato, e anche stavolta un folto pubblico assiste in diretta al repentino collasso che lo abbatte: «Il vescovo non fece in tempo a pronunciare queste parole che si accasciò improvvisamente al suolo, sotto gli occhi esterrefatti dei ministri di culto che lo stavano assistendo nella funzione. I fedeli lo videro scomparire, avvertirono movimenti inusuali e un chiacchierio confuso all’altoparlante prima che venisse spento, ma non si accorsero di quanto fosse realmente successo finché un ecclesiastico comunicò con affanno di stare calmi ché il vescovo si era sentito male».
Il mistero si infittisce, la trama si complica e, nel risvolto dei suoi nodi cruciali, Stucchi affolla la narrazione di altri personaggi, come l’avvenente Laura, figlia della prima vittima, che affianca Lazzari nelle indagini e intreccia con lui una burrascosa relazione amorosa, e il cinico e ipocondriaco professor Marco Poppi, che in un modo o nell’altro appare sempre collegato alle morti sospette. L’autore entra in punta di piedi nella nicchia di un genere di ampia diffusione, il thriller, ma ne rovescia con piglio beffardo sia i significati che gli esiti, disseminando la narrazione di ombre inquietanti e di impennate dal gusto onirico e grottesco.
Vale la pena citare per intero, e gustare nella sua truculenza quasi barocca, uno dei brani più macabri e angosciosi dell’intera produzione letteraria di Stucchi. Si tratta del terrificante incubo del protagonista, da cui deriva il titolo stesso del romanzo, una castrazione simbolica ma nel contempo densa di traumatici dettagli iperrealisti, che riportano alla mente l’ossessione anatomica nutrita verso il mondo oscuro degli insetti da parte del cinema di David Cronenberg (La mosca e Il pasto nudo, soprattutto): «si trovava, senza capire come ci fosse arrivato, in un enorme nido di vespe, una caverna sotterranea scavata nel terreno, da cui riusciva a distinguere la lontana luce dell’entrata. Giaceva paralizzato al suolo senza riuscire a muovere un singolo muscolo, ma i sensi rimanevano molto allerti, tanto da fargli percepire il solletico provocato dagli insetti che ricoprivano il suo corpo nudo con un brusio incessante. Avrebbe voluto gridare, ma non ci riusciva. All’improvviso, aveva visto arrivare dal fondo buio del nido una vespa grande quanto un pugno, senza peluria, ma con una pelle deformata da pieghe di grasso bianco. La regina si era avvicinata pian piano: girò sopra il torace, esaminandolo attentamente, si soffermò sulle orecchie, poi passò sotto il naso, quindi prese a scendere lungo l’addome. Gianni continuava a ripetere dentro di sé che non poteva essere vero. Ma tutti i sensi gli indicavano che si trattava della realtà, perché poteva addirittura avvertire l’odore degli insetti, un sentore come di canfora. La regina individuò nel pene il suo obiettivo. Si fermò interessata, vibrò le ali e, a quel comando, tutte le altre vespe si scostarono, rimanendo attorno in un brulicante movimento giallo e nero, in attesa che la grande madre eseguisse il gesto tanto atteso. E così fu: estrasse un’appendice retrattile dalla punta dell’addome, dove di solito si trova il pungiglione, e la spinse nella fessura del prepuzio. L’operazione durò un attimo, poi la regina ritornò da dove era venuta. Subito Gianni iniziò ad avvertire un formicolio nei testicoli e che la pelle dello scroto si muoveva. C’era qualcosa all’interno che si nutriva di lui, benché non avvertisse alcun dolore. Mentre fissava terrorizzato i propri genitali, apparvero, bucando la cute, diverse larve che continuavano a masticare… e poi si svegliò».
In un crescendo devastante, che trasmette al lettore un disagio quasi insostenibile, Stucchi dilata la percezione sensoriale nella dimensione rarefatta e fluttuante del sogno, coinvolgendo tutti e cinque i sensi del protagonista: la vista con l’apparizione della mostruosa vespa regina, l’udito con il brusio incessante degli insetti, il tatto con il loro formicolio sulla sua pelle, l’olfatto con il sentore di canfora, il gusto con la nausea provocata da quella orripilante e claustrofobica situazione. E l’innesto delle larve nei genitali, che finiscono per implodere divorati dall’interno, appare come un’oscena fecondazione da parte di una divinità femminile cannibalesca con sembianze di insetto. Un cocktail funesto di tutti i più atavici terrori che si annidano nella psiche maschile.
Attraverso una concatenazione sempre più incalzante di vere e proprie “dissolvenze in nero”, Stucchi guida il lettore verso la soluzione dell’enigma, non senza costellare il percorso di nuovi orrori e di nuovi cadaveri: l’epilogo – che ovviamente non riveliamo lasciando questa opportunità ai futuri lettori – chiude la circolarità della vicenda, e trasporta il protagonista in una dimensione trascendente, dove i poteri della mente, adeguatamente amplificati dalla fenomenologia quantica, sono in grado di trasformare l’essere umano in un angelo della morte capace di migrare da una mente all’altra lungo il sentiero dei sogni e dei ricordi.
Nostalgia struggente per un mondo che va scomparendo
Concludiamo il nostro itinerario lungo la produzione letteraria di Gian Corrado Stucchi con un’antologia – basata su ricordi e appunti del padre – sul filo della memoria e del rimpianto, Ricordi lombardi, in cui sono rintracciabili echi suggestivi di capolavori cinematografici dedicati alla civiltà contadina di un secolo fa, come Novecento di Bernardo Bertolucci e soprattutto L’albero degli zoccoli di Ermanno Olmi (un riferimento d’obbligo, ambientato com’è in terra bergamasca).
L’autore descrive con commossa partecipazione emotiva il microcosmo rurale in cui il padre ha trascorso la sua infanzia, ed esalta, con qualche sfumatura di quieta rassegnazione, il mondo dei semplici e degli ultimi, il disadorno ma genuino incantesimo della quotidianità, addensato da morbidi chiaroscuri in cui palpitano sporadici sprazzi di luce: «Nonno Beppe la pensava così e, non diversamente da lui, anche Maria, mentre pettinava il lanuginoso cranio della nonna e si chiedeva il motivo per il quale il suo uomo persisteva a voler lavorare lontano da casa. Lei aveva fiducia in Dio e si rimetteva completamente alla sua volontà; ma era costretta a rimanere lì al paese, a consumare un’interminabile attesa nel vecchio cascinale isolato nei campi, circondati da poggi boschivi, dove la vita di uomini e animali si consumava lentamente in comunione di intenti, tra albe e tramonti che si succedevano senza eventi, eccetto nascite, matrimoni e morti».
Nel descrivere gli ambienti, Stucchi raggiunge risultati di forte suggestione pittorica, pennellando ogni singolo dettaglio nell’ambito della muta eloquenza di una malinconica, elegiaca “poetica degli oggetti”: «Entrò in cucina, si avvicinò a una fascina di legna sul pavimento e afferrò una manciata di rami spinosi che incrociò con poca paglia sul focolare. Quindi prese un fiammifero da una scatoletta metallica appesa alla parete e accese il fuoco, indugiando a scaldarsi le mani callose mentre osservava le ombre proiettate sulle pareti dalle fiamme come fantasmi venuti fino a lui dai secoli passati. Benché vivesse da quando era nato in quell’austero locale dal soffitto di travi gobbe, si sorprendeva sempre a scoprire particolari inaspettati: il tavolone sopra cui pendeva la lucerna a petrolio, le sedie spaiate bucherellate dai tarli, la madia tracagnotta piena di ruote di pane giallo. Passò pure in rassegna le pentole di rame appese alla parete e oltre, nell’angolo, l’imponente credenza stipata con marmitte di latte, fresco e cagliato, il lardo e la pancetta».
Nel contesto di un’esistenza segnata dalle privazioni, dove talvolta non si riescono a soddisfare nemmeno i bisogni primari, un evento in apparenza minimale come l’acquisto di una stufa assume agli occhi della famiglia contadina il valore di un miracolo, di un dono della provvidenza per la nonna afflitta da una penosa broncopolmonite causata dall’umidità dell’habitat rurale: «Accesa che fu in pochi minuti, la stufa diventò un globo di calore che diffondeva nel locale una profumata essenza di robinia. Le donne levarono dal letto tre coperte e il volto ossuto della malata fece capolino come la testa di una chiocciola dalla conchiglia. La nonna si guardò in giro con gli occhi acquosi, stupita dalla presenza di tanta gente in camera sua, tossì a colpi secchi, si palpò le ossa indolenzite e dopo aver ammirato il nuovo oggetto, radunò con voce flebile le nuore per recitare insieme un Pater ave gloria di ringraziamento».
La condizione femminile, soggiogata dal duro lavoro nei campi, dalle immancabili faccende domestiche, dalla quotidiana fatica di dover accudire i vecchi e i bambini, rispecchia una stanca ritualità, una serena rassegnazione rallegrata a tratti da qualche piccola soddisfazione, come il piacere di gustare un’arancia barattata con due uova: «Il pomeriggio le donne uscirono dalla stalla per ascoltare rapite i suoni e i canti che arrivavano fin su dal paese, portati dal freddo vento invernale. Quando imbrunì, zia Elvira si avvolse nello scialle e uscì con la scodella e un cucchiaio in mano. Indugiò ancora sotto il portico a riascoltare gli echi delle libagioni nuziali, poi si inoltrò pochi passi nel campo per chinarsi a raschiare la neve morbida sotto la crosta gelata. Al suo rientro, Maria levò dalla tasca del grembiule una piccola arancia, barattata quel giorno per due uova con il venditore ambulante, e con i denti lacerò la buccia, spremendovi sopra il succo. Le due donne degustarono quella delizia a piccole dosi, molto lentamente, per farla durare il più a lungo possibile».
Anche i riti che accompagnano la morte di un membro della famiglia sono racchiusi in una cornice di miseria (la bara ricavata dalle assi della stalla), di fame (il granoturco giallo come l’incombente pellagra provocata dalla malnutrizione), di isolamento (la barriera di neve che impedisce la celebrazione del funerale in chiesa): «Ricordava l’infanzia come se fosse ieri: la famiglia viveva in un paesino di montagna, circondato da prati sassosi e piccoli campi, dove veniva coltivato un granoturco giallo pallido che preannunciava la pellagra già dal colore. Quando la madre morì alla vigilia di Natale, suo padre scese nella stalla a recuperare alcune assi per costruire una bara che sistemarono provvisoriamente nel sottotetto della baita, in attesa che si sciogliesse almeno in parte la copiosa nevicata caduta nei giorni precedenti. Ogni sera, durante la recita del rosario, gli occhi di Maria, insieme a quelli del padre e dei cinque fratelli, si levavano verso il soffitto di legno a pregare per la morta e quando finalmente la neve si assottigliò, portarono la cassa in spalla alla chiesa del paese per chiedere al parroco la benedizione prima di seppellirla».
Eppure, anche nel momento in cui il progresso tecnologico, rappresentato dalla corrente elettrica approdata in paese, prefigura un miglioramento delle condizioni di vita, la mentalità contadina resta ancorata ai simboli del passato, manifestando una specie di sorda resistenza all’avanzare del nuovo, visto come una perdita irreparabile della propria identità. Emblematico a tal proposito l’atteggiamento diffidente e ostile di Maria verso la lampadina e, di contro, il suo attaccamento affettivo alla vecchia, cara lucerna: «I suoi pensieri andavano alla fiammella della lucerna come un’amica perduta: quando la accendeva e prima di spegnerla, le piaceva giocarci insieme, passandole sopra l’indice per osservare la fiammella che si fletteva o dondolava; se invece le soffiava addosso, sembrava voler fuggire per lo spavento o, al contrario, accennare passi di danza; insomma, era una cosa viva che illuminava l’ambiente ma anche il suo umore, mentre la lampadina emanava una luce fredda, immobile e priva di anima».
Il ventesimo secolo sotto il tallone di ferro dell’Asse
La nostra indagine sulla narrativa di Gian Corrado Stucchi si conclude con Come piegati dal vento, romanzo ucronico che s’innesta nel solco tracciato da La svastica sul sole di Philip K. Dick. Stucchi immagina che nel 1940, a causa della vittoria elettorale di un candidato neutralista negli Stati Uniti, la Gran Bretagna soccomba di fronte alla Germania hitleriana, alleata dell’Italia fascista. Ma il Duce muore d’infarto, e la spaccatura all’interno del regime da lui creato fra seguaci e oppositori del successore Galeazzo Ciano precipita la penisola in una sanguinosa guerra civile. Su questo sfondo si dipana la tormentata storia d’amore fra Vanni Conago, giovane e brillante fisico nucleare con qualche ambizione letteraria, ed Eloisa Guarneri, figlia naturale di Margherita, titolare di un laboratorio di bigiotteria e amante di Vittore Comaschi, un brutale gerarca fascista torturatore di partigiani.
Rimasto orfano di entrambi i genitori, Vanni viene adottato dalla famiglia aristocratica dei Gromini, e ne sposa la rampolla Tania; durante la guerra civile, entra in contatto con il movimento di liberazione antifascista e rischia di perdere la vita a causa di questo coinvolgimento. La vicenda si svolge fra Milano e Monza, ma i momenti più significativi sono vissuti nell’incantevole paesaggio montagnoso del Tirolo.
In questo singolare e movimentato romanzo Stucchi conferma le sue doti di narratore raffinato, estremamente attento nel rifinire i profili psicologici dei suoi personaggi, e questo non vale solo per i protagonisti, ma anche per le figure di contorno. Vanni, travolto dalla passione divorante per Eloisa fino al punto di abbandonare la sua famiglia, incarna una generazione disorientata e priva di punti di riferimenti, che nel turbinio della guerra civile non ha ancora scelto definitivamente da che parte schierarsi. Una sostanziale ambiguità che si estende ad altri personaggi (la dinastia dei Gromini, la madre di Eloisa, il fascista Comaschi).
Emblematiche, a questo proposito, le parole di Vanni sull’antisemitismo: «Io non odio gli ebrei, ma ci dovremo pur difendere… loro fanno lobby, si proteggono l’un l’altro, non si creano scrupoli a dare priorità ai propri biechi interessi, chi sono in realtà i veri razzisti? Se vuoi sapere la mia sincera opinione, mi appaiono esosi, antipatici e pure rompiballe». Opinioni che rispecchiano quelle, tristemente più attuali, di una “maggioranza silenziosa” facilmente influenzabile da demagoghi senza scrupoli. Altrettanto qualunquista è la concezione che Vanni nutre sulla democrazia: «Le mille parole inutili dei dibattiti democratici non portano mai a decisioni precise, fatti concreti nell’interesse della nazione. Vedi? Ci conosciamo da poco e quasi già litighiamo pur essendo in due, figurati decine, centinaia di opinioni diverse in una popolazione di milioni. Cesarismo, questa la via, il popolo è bue, va tenuto al giogo nel suo stesso interesse, solo così si può progredire». La propensione di certi intellettuali un tantino spocchiosi come Vanni al disprezzo verso le masse si salda all’istintivo complesso di superiorità che, per esempio, pervade il clan nobiliare dei Gromini che lo ha educato sulla base di tali principi reazionari.
Sul versante opposto, il puro e coerente idealismo di chi lotta per la libertà paga spesso un prezzo atroce. I feroci agguati dei partigiani non concedono tregua al nemico: «Il primo colpo di bazooka centrò da distanza ravvicinata il camion di testa. Lo scoppio alzò in cielo una nuvola di fumo nero insieme a pezzi di lamiera contorti. I soldati scesero dalle camionette con i mitra in pugno, guardandosi attorno per capire da dove provenisse l’attacco, ma una gragnola di proiettili li investì, falciandoli all’istante. Qualcuno prese riparo rispondendo al fuoco, ma i partigiani usciti dal bosco non lasciarono loro via di scampo. Fu una questione di attimi, i sopravvissuti, sperando di aver salva la vita, alzarono fiduciosi le mani ma furono crudelmente finiti a colpi di pistola». Dal canto loro i militi fascisti rispondono con efferate rappresaglie contro la popolazione inerme: «La reazione infuriata del regime non si fece attendere molto. Un’intera compagnia di Arditi giunse presto a Sarentino accampandosi nei locali della scuola ormai in disuso. Fu intimato a chiunque di non uscire di casa. Cominciarono gli interrogatori e alcuni delatori fecero dei nomi. Gli accusati vennero riuniti nei pressi del cimitero, vicino alla chiesetta delle stelle cadenti e fucilati senza pietà davanti agli abitanti di tutto il villaggio. Le loro case furono bruciate senza distinzione e le famiglie costrette a lasciare il paese».
Una spirale di odio e di vendette degenera in episodi di feroce umiliazione: ne paga lo scotto la madre di Eloisa, punita dai partigiani per la sua collusione con l’odiato Comaschi: «Margherita Guarneri strillava come una indemoniata: “Lasciatemi maledetti, comunisti, traditori, aiuto, aiuto!” “Grida quanto vuoi cagna! Non ti è bastato perdere il laboratorio per capire? Sei solo una prostituta, una donna per tutti. Quel tuo Comaschi non vuol conoscere ragioni, un ignobile aguzzino, e ordina torture, ma manca poco, poi anche lui… intanto tu devi pagare bastarda… fuori, fuori… portatela fuori per i capelli, deve servire da esempio… ma in fretta prima che arrivino le guardie… rapatela a zero e legatela al lampione”».
Uno dei personaggi più riusciti, vera e propria incarnazione della stupida e vigliacca arroganza fascista, è proprio quello dell’amante di Margherita, il federale Vittore Comaschi. Memorabile come l’Attila Melanchini impersonato da Donald Sutherland in Novecento di Bertolucci. Il colloquio fra Comaschi e Don Luigi ricorda molto quello fra Don Rodrigo e Padre Cristoforo nei Promessi Sposi. Un impianto drammaturgico di pregio assoluto, che fa lievitare lentamente la tensione prima dello scoppio di collera incontrollata da parte del tracotante gerarca fascista, in modo da far risaltare maggiormente la dignitosa fermezza del religioso venuto a implorare clemenza per Eloisa e Vanni: «“Come osate! Voi piccolo ecclesiastico, venire a farmi la ramanzina! Andatevene subito e ringraziate la vostra immunità! C’è un altro termine per definirla… altro che anima innocente… inoltre un marito comunista da appendere all’albero… e forse avrà anche amanti, non mi meraviglierei affatto, ma cosa ne potete sapere voi… andatevene, sparite dalla mia vista… guardie, guardie… accompagnate fuori questo prete da strapazzo, a calci in culo se necessario!” Accusati gli insulti, Don Luigi avrebbe voluto insistere, spiegare meglio le proprie ragioni, ma fu preso sottobraccio dagli sbirri. Sulla porta, colto da un impeto di orgoglio, riuscì a scrollarsi di dosso le mani ed emise la sentenza, una sola frase terrificante che valeva più delle minacce per il castigo divino: “Lei è un vigliacco!”».
In conclusione, il romanzo è impeccabile nella circolarità della trama (con il ricorso al flashback), affascina e coinvolge, tratteggia intriganti personaggi femminili (particolarmente riuscito il ritratto di Margherita Guarneri, che ne sottolinea sia la fierezza che l’avvenenza: «L’indole indipendente e fiera, dimostrata a volte nell’abitudine scandalosa di indossare pantaloni all’ultima moda, i capelli rossi raccolti in un semplice codino, non sminuivano affatto la prorompente sensualità del suo corpo perfetto e del viso di una bellezza radiosa, qualità trasmesse a Lisa tanto da farla apparire una sorella minore»); descrive le atrocità della guerra civile con crudezza ma senza eccedere nei particolari raccapriccianti. Cesellando inquietanti utopie negative in un crescendo di climax e di colpi di scena, Stucchi reinventa la realtà storica con espedienti narrativi di indubbia presa sul lettore.
Guglielmo Colombero
(www.bottegascriptamanent.it, anno XIII, n. 140, maggio 2019)
Ilenia Marrapodi