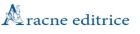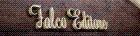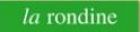Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Mario Saccomanno
A. XIX, n. 210, apr. 2025
 La Grande guerra
La Grande guerravista e narrata
in un secolo di film
di Guglielmo Colombero
Da Rubbettino, fotogrammi atroci
tra pacifismo e retorica patriottica
«“La guerra – scrive Musil tornato da Berlino a Vienna per arruolarsi – mi venne addosso come una malattia, o meglio come la febbre che la accompagna.” Lo scrittore austriaco, pochi giorni prima dello scoppio del conflitto, aveva conosciuto un giovane impiegato praghese, si chiamava Franz Kafka, che gli aveva consegnato un manoscritto dal titolo: La metamorfosi. Narrava di un uomo che un mattino si sveglia tramutato in insetto: è la mostruosa mutazione di un intero mondo». Il sonno della ragione, dunque, genera sempre mostri: un secolo fa, in un torrido agosto, in Europa si scatenava la terrificante carneficina che, nidiata di futuri orrori, avrebbe sprigionato da milioni di cadaveri i germi del totalitarismo nazifascista, dell’Olocausto e dei gulag staliniani. Non è casuale che il primo genocidio sistematico del XX secolo risalga alla primavera del 1915, quando l’agonizzante Impero ottomano, pochi anni prima di crollare nell’infamia, decretò lo sterminio di un milione di armeni, in maggioranza donne e bambini. Il centenario della Grande guerra, che ricorre dall’anno appena trascorso fino al 2018, ci spinge anche a riflettere su come sia stata rappresentata sul grande schermo, dal periodo in cui avvenne fino ai giorni nostri.
Abbondante materiale sia letterario che visivo ci offre a tal scopo il volume Le ceneri del passato. Il cinema racconta la Grande guerra (Rubbettino, pp. 264, € 16,00) realizzato da Giuseppe Ghigi, critico e saggista cinematografico, già docente di Storia del cinema italiano all’Università Ca’ Foscari, autore di La memoria inquieta. Cinema e Resistenza (2009), Dizionario dei veneziani del cinema (2010), Il tempo che verrà. Cinema e Risorgimento (2011). Si tratta di una vera e propria discesa nell’inferno della Prima guerra mondiale, al punto che ogni capitolo può essere paragonato a uno dei gironi danteschi. Infatti il lettore sprofonda in scenari apocalittici, in visioni di sangue e di terrore, nello schifo fangoso della non-vita di trincea, nei grovigli di filo spinato, nelle corsie degli ospedali militari traboccanti di corpi maciullati, non solo grazie alla suggestione evocativa che lievita nel testo di Ghigi, ma anche per l’efficace supporto iconografico dei circa settanta fotogrammi filmici inseriti nel libro, tutti accuratamente selezionati, in un bianco e nero volutamente livido come le divise grigioverdi dei combattenti. Oltre a Musil e a Kafka, Ghigi cita anche Hermann Häfker, uno dei primi teorici del cinema, il quale, allo scoppio del conflitto, «sostiene che la guerra è un temporale che purifica l’atmosfera e che consente finalmente “di vivere di nuovo e farci pronti a rischiare la vita in gesta degne dell’ora. La pace era divenuta insopportabile. Häfker, dopo aver combattuto per il Kaiser, diventerà antinazista e morirà a Mauthausen pagando di persona gli esiti nefasti di quel temporale». Quanto a Kafka, solo la morte prematura causata dalla tubercolosi gli risparmierà la sorte in seguito toccata alle tre sorelle, vittime dell’Olocausto, mentre Musil, insieme alla moglie ebrea, dopo l’annessione nazista dell’Austria troverà scampo a Ginevra, dove la morte lo coglierà nel 1942, impedendogli purtroppo di vedere la disfatta di Hitler da lui prefigurata (e auspicata) in alcune pagine dei suoi scritti.
La trasposizione sullo schermo di alcune celebri opere letterarie antimilitariste crea un legame significativo fra cinema e letteratura riguardo alla Grande guerra: Lewis Milestone e Delbert Mann attingono da Erich Maria Remarque per All’ovest niente di nuovo; Georg Wilhelm Pabst da Ernst Johannsen per Westfront; Frank Borzage e Charles Vidor da Ernest Hemingway per Addio alle armi; Stanley Kubrick da Humphrey Cobb per Orizzonti di gloria; Francesco Rosi da Emilio Lussu per Uomini contro, tanto per citare alcuni dei classici più noti. Purtroppo, nessun regista ha mai tentato di tradurre in immagini il libro forse più violento e dissacrante sulla Grande guerra, Viaggio al termine della notte di Louis-Ferdinand Céline, in cui il nichilismo furente dello scrittore francese esplode in una delle invettive più feroci mai scagliate contro la retorica patriottarda: «Li si faccia, per legioni e legioni ancora, crepare, saltare ai ferri, sanguinare, fumare negli acidi, e tutto questo perché la Patria sia sempre più amata, felice e dolce!».
Estate 1914, esaltazione e follia collettiva
Il primo capitolo del libro è dedicato all’iniziale entusiasmo dei coscritti diretti al fronte, che ben presto svanirà nell’orrore della guerra di trincea. All’ovest niente di nuovo, girato nel 1930 da Milestone in contemporanea con un altro capolavoro pacifista, Westfront di Pabst, si apre con il monologo del vecchio professor Kantorek, che arringa i suoi studenti. Ghigi osserva come il film «sottolinea la tronfia retorica patriottica del professore con la funzione prolettica di condannare l’ipocrisia con la quale si cercava di convincere migliaia di giovani ad arruolarsi portandoli al massacro». Sulla sponda opposta, Karl Ritter, regista amico di Hitler, gira nel 1938 Pour le mérite, così intitolato poiché fa riferimento ad una decorazione istituita da Federico il Grande quando in Prussia la lingua ufficiale era ancora il francese, e si accanisce non solo contro il pacifismo, ma anche contro la democrazia: «Nel film si sostiene che i veri soldati lottano anche contro il cancro weimariano; il capitano Prank (Paul Hartmann), eroe di guerra decorato con la Blaue Max, massima onorificenza militare prussiana, dichiara di fronte al tribunale democratico che lo sta giudicando: “Non ho assolutamente niente a che vedere con questo Stato. Io odio la democrazia come la peste”». Anche nell’Italia in preda alla febbre guerrafondaia futurista e dannunziana, si «andò alla guerra pensando alla bella morte, alla dignità della nazione, al dovere, e poi si fece fatica a elaborare il lutto: dapprima l’illusione della vittoria, poi il mito della vittoria mutilata, il fascismo che eleva la Grande guerra a mito fondativo, e infine la retorica cattolico-patriottica democristiana hanno impedito per decenni la raggelante presa di coscienza». Solo quattro decenni dopo, sottolinea Ghigi, il film di Mario Monicelli La grande guerra «nella trama di una commedia inserisce la sequenza del ritorno delle truppe dal fronte di Caporetto. Il campo totale si apre sulla piazza di un paesino del Friuli dove un oratore inneggia all’eroismo dei militari che stanno difendendo la patria. Ad un tratto il vociare della gente lo obbliga a fermarsi: stanno per arrivare i militari; la banda intona una fanfara festosa, la gente si apre allegramente per far passare i soldati e tutti sventolano fazzoletti e bandierine tricolori. Poi, a poco a poco la banda smette di suonare e cala il silenzio: resta solo lo scalpiccio dei passi di una truppa scalcagnata, sporca, sbrindellata, affamata, ferita e delusa». L’immagine del capolavoro di Monicelli scelta da Ghigi è fortemente emblematica: i due antieroi Sordi e Gassman che avanzano stracarichi di armi e cartucciere, ma con espressioni tutt’altro che bellicose. Gli occhi da pesce bollito di Sordi che guardano verso l’alto, specchio dell’ennesimo attacco di fifa, e lo sguardo stralunato e diffidente di Gassman che s’incrocia con quello del compare.
La divisa trasforma il postino in aguzzino
Il preludio in qualche misura anticipatore delle future atrocità della guerra è il duro e traumatico addestramento delle reclute. In All’ovest niente di nuovo Himmelstoss, un mite postino sbeffeggiato dagli studenti nella vita civile, assurge al ruolo di onnipotente riplasmatore, dotato di un potere assoluto sui giovani coscritti che intende trasformare in assassini in divisa: «L’ex-postino non è sadico per motivi personali, ma perché incarna il ruolo dell’omologatore: egli è uno degli agenti della macchina bellica di cui è parte». Il fotogramma riportato nel libro è una memorabile istantanea della più tronfia arroganza marziale: l’omuncolo Himmelstoss ingigantito dalla divisa nuova fiammante, con mostrine e bottoni dorati, le mani sui fianchi nella posa del boia che attende le vittime, i ridicoli mustacchi con le punte a uncino, la piega crudele della bocca, la visiera sbilenca sopra gli occhi ridotti a due fessure sature di boria rancorosa («Vi svezzerò dal latte di vostra madre!», urla in faccia alle reclute finite sotto le sue grinfie). Molto più caustica e umoristica la sequenza dell’arruolamento di Chaplin in Charlot soldato del 1918: «Charlot, tiranneggiato da una moglie isterica, quando arriva il postino con la cartolina precetto tira un sospiro di sollievo: meglio la guerra vera che quella in casa. Giunto all’ufficio reclutamento, gli viene detto di spogliarsi ed entrare; mezzo nudo, apre la porta sbagliata e si trova in un labirinto di stanze occupate da personale esclusivamente femminile. Finalmente trova l’ingresso giusto e un lugubre e barbuto medico militare inizia la visita che vediamo solo in silhouette attraverso un vetro smerigliato. Il dottore infila una sonda mostruosa nella gola di Charlot che prima la sputa e poi la ingoia completamente». Nel fotogramma scelto da Ghigi vediamo Charlot, pronto a balzare fuori dalla trincea con la baionetta innestata, un piede già appoggiato sulla scaletta, ma la goffaggine che traspare dal linguaggio del corpo, racchiuso in una divisa che gli casca addosso malissimo, più che a un eroe di guerra lo rende simile a un poveraccio che se la sta facendo nelle brache dalla paura.
Soldati ciechi che brancolano nella terra di nessuno
Un comune denominatore è rintracciabile negli stati maggiori degli eserciti contrapposti durante il conflitto: tutti gareggiano nel dimostrare un cannibalesco disprezzo per la vita umana. Il tedesco Von Falkenhayn e l’austriaco Conrad von Hötzendorf, come sul fronte opposto il francese Charles Mangin e l’italiano Luigi Cadorna, mandarono al macello centinaia di migliaia di disgraziati, falciati dalle mitragliatrici, dilaniati dalle granate, squarciati dalle baionette, asfissiati dai gas, per conquistare poche decine di metri di terra inzuppata di sangue. Sottolinea Ghigi che la «distanza che separava le trincee era terreno deserto, con enormi crateri creati dalle artiglierie, privo di vegetazione e melmoso in caso di pioggia, con reticoli di fili spinati, nel quale i soldati si muovevano scompostamente cercando di appiattirsi al suolo, di nascondersi e di rendersi invisibili al nemico, uomini talpa».
Analizzando in parallelo due classici del cinema antimilitarista come Orizzonti di gloria di Kubrick e Uomini contro di Rosi, Ghigi insiste sulla cecità delle alte gerarchie militari, che finisce per trascinare nel baratro del massacro intere generazioni, devastando il tessuto sociale delle nazioni da cui provengono. Il film di Rosi, «nonostante la carica ideologica, in parte datata, è, assieme a Orizzonti di gloria, il film che maggiormente penetra nelle dinamiche contraddittorie della Grande guerra, svelandone i punti ciechi, rendendoli visibili. Il generale Leone di Rosi, come il Mireau di Kubrick, sono figure del passato che incarnano la miopia dei comandi militari, vuoi nel senso quasi metafisico del primo, vuoi per gli egoismi e i calcoli di classe del secondo. Leone è più legato alla visione eroica della guerra, Mireau, militare di carriera, aristocratico da cavalleria ottocentesca, incarna il cinico calcolo e l’indifferenza arrogante nei confronti della massa plebea dei soldati di truppa». Nell’immagine tratta da Uomini contro spicca la posa enfatica di Alain Cuny nei panni del paranoico generale Leone, mentre manda a crepare sotto il fuoco delle mitragliatrici nemiche alcuni sventurati guastatori “protetti” da ridicole corazze che li rendono simili a grossi scarafaggi.
La guerra come incubo cubista
«La nuova guerra è cubista, secondo Gertrude Stein, troppo diversa dalla prospettiva rinascimentale, troppo incomprensibile visivamente; è difficile da capire, da predire, da filmare. La guerra della modernità non ha visivamente per la Stein né un inizio né una fine, “un angolo è importante quanto un altro angolo, di fatto è la composizione cubista”. Le linee geometriche delle battaglie kubrickiane combattute da Barry Lyndon sono ora impossibili: la prima guerra mondiale non ha più linee di fuga. “Non c’è niente di più cubista di una guerra come questa – scrive Léger – che divide in qualche modo un brav’uomo in mille pezzi spedendoli ai quattro punti cardinali”. L’immagine dello smembramento e disarticolazione dei corpi non è impropria o solo letteraria perché riflette ciò che realmente accadeva: in un materiale d’archivio, girato probabilmente a Verdun o sulla Somme, si vede il corpo di un militare francese smembrato e appeso a un albero completamente spoglio».
Ghigi va dunque a sondare uno degli aspetti meno considerati del legame fra la Grande guerra e la sua rappresentazione cinematografica: quello della “frammentazione cubista” del conflitto, in cui ogni logica tradizionale crolla, sostituita da bruschi mutamenti di prospettiva, da impennate visionarie che, se inizialmente disorientano, una volta decifrate contribuiscono a comprendere più a fondo la sostanza degli eventi storici. «Più i registi cercheranno di rispettare i luoghi, i tempi e le forme dei combattimenti, tanto più ne restituiranno il dissolvimento spazio-temporale e la cancellazione dei dettami euclidei». Illuminante, a questo proposito, la tecnica di ripresa utilizzata da Pabst in Westfront: «i soldati si muovono senza direzione precisa, si lanciano granate reciprocamente un po’ a caso e senza poter effettivamente vederne gli effetti: il nemico è da nessuna parte e allo stesso tempo dappertutto, visibile e invisibile, in una pura entropia spazio-temporale». E anche la cifra stilistica di Kubrick è decisamente trascendente: «il cinema può permettersi di non nominare i nemici, ma ha difficoltà a rendere del tutto anonimi gli amici. Senza viso sono i nemici di Orizzonti di gloria che, rintanati nel loro Formicaio, non si vedranno mai: Kubrick li eleva ad entità metafisica. Solo nel finale appariranno nelle vesti della povera fanciulla tedesca costretta a cantare per i soldati francesi».
Corpi distrutti, spettri, morti viventi
Bertrand Tavernier, uno dei cineasti francesi più rigorosi e controcorrente, getta in faccia allo spettatore la brutalità barbarica della guerra in Capitan Conan, girato nel 1996 in occasione dell’ottantesimo anniversario della carneficina di Verdun: i suoi “eroi di guerra” «sgozzano, amputano, strangolano, fracassano teste e non fanno prigionieri di sorta. Il loro è un combattimento fisico che ha bisogno di sentire da vicino il corpo da uccidere, come dice Conan: “tanto vicino al nemico da vedergli il bianco degli occhi”. Incarnano la massima hobbesiana dell’homo homini lupus, badando solo a salvare la propria pelle e a massacrare il nemico nel terribile gioco di sopravvivenza e di sterminio». Il fotogramma riportato nel libro, infatti, cristallizza l’immagine di due fanti francesi in fuga, simili a due lupi dalle zanne ancora intrise del sangue delle prede appena scannate. Nel film di Tavernier, puntualizza Ghigi, «non si muore da eroi, ma casomai da assassini, non si muore pulitamente senza donare morte e senza spargere sangue e budella, senza soffrire prima di diarrea, fame e pidocchi». Nel 1919, a guerra appena conclusa, l’allora celebre regista francese Abel Gance gira Per la patria: in occasione della parata vittoriosa del 14 luglio, la celebrazione è aperta «dal corteo dei mutilati di guerra, uomini in carrozzina, ciechi, senza braccia: morti viventi salutati con rispetto luttuoso e non festoso dalla folla. Gance sovrappone alle immagini dal vero la marcia dell’esercito dei morti: dunque, non c’è granché da festeggiare perché quella vittoria è costata milioni di caduti».
Spie, crocerossine e prostitute
Uno dei capitoli finali del libro di Ghigi è dedicato alle figure femminili nel cinema sulla Grande guerra, spesso collocate ai margini, raramente in ruoli da protagoniste. Confinate fra le pareti dei focolari domestici, o precettate nelle fabbriche per sostituire la manodopera maschile risucchiata dal reclutamento, le eroine dello schermo emergono solamente incarnando una Mata Hari romantica e passionale come Marlene Dietrich in Disonorata di Josef Von Sternberg del 1931: «Coraggiosa e altera, la bella spia X-27, prima di affrontare il plotone di esecuzione chiede di indossare i suoi vecchi abiti, si aggiusta il rossetto e le calze e muore con onore. Tutti piangono, compresi i soldati nemici: di fronte alla bellezza femminile non esistono frontiere». Oppure l’ambigua e quasi mefistofelica Suzy Kendall in Fräulein Doktor di Alberto Lattuada, del 1969: «Forse morfinomane, forse frigida o bisessuale, probabilmente morta in una clinica Svizzera, è un personaggio di donna-spia indecifrabile. Lattuada ne accentua il lato antieroico, la carica sessuale orientata a ottenere risultati più che piacere, e ne connette la figura con la macchina guerra che non ha nulla di eroico e di umano nella ricerca di negazione della vita». Sul versante edificante, Ghigi cita la crocerossina Edith Cavell, fucilata dai tedeschi nel Belgio occupato, protagonista nel 1939 di La storia d’Edith Cavell di Herbert Wilcox: «Melodramma bellico quasi perfetto; il suo amore non è per un uomo ma per tutti i soldati». Infine, in La grande guerra di Monicelli, Silvana Mangano interpreta l’indimenticabile Costantina, la prostituta (per necessità) innamorata del lavativo Gassman: «Figura antieroica, lo spazio della normalità perduta, che svela di lontano la società che stava alle spalle del fronte italiano e mostra la durezza del vivere di una povera donna ai tempi della Grande guerra. La commedia all’italiana è capace di far ridere aprendo squarci tragici».
Ceneri della memoria sparse su un orrendo concime umano
Nel suo romanzo antimilitarista Il buon soldato Sc’vèik, Jaroslav Hasek scrive che «per i contadini è molto vantaggioso quando nei loro campi vanno in putrefazione reggimenti interi; in sostanza è tutta roba che serve per arricchire il terreno. I cadaveri che non concimano i campi, vengono sepolti in mausolei pomposi, retorici, classicheggianti: è la patria, l’onore e la nazione che vi si celebra e non i singoli individui». Ghigi conclude amaramente la sua aspra requisitoria contro la stupidità non solo della Prima guerra mondiale, ma di tutte le guerre che l’hanno preceduta e seguita, un morbo da cui purtroppo l’umanità non è ancora guarita: «La Grande guerra ha lasciato troppa cenere, troppe lacerazioni, mutilazioni, dolori, odi, un’infinità di tracce materiali e mentali; cenere che ha covato ridando presto fuoco all’Europa, cenere rimasta viva nelle immagini di centinaia di film, ombre di un’immane tragedia che rimane nonostante tutto invisibile perché, come dice la giovane donna del film di Alain Resnais dopo aver a lungo visitato le ceneri atomiche: “Non hai visto nulla a Hiroshima”».
Guglielmo Colombero
(www.bottegascriptamanent.it, anno IX, n. 91, marzo 2015)
Ilenia Marrapodi