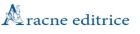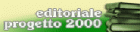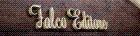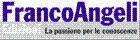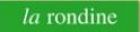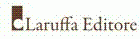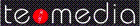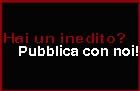Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Mario Saccomanno
A. XIX, n. 208, feb. 2025
 Apoteosi e declino
Apoteosi e declinodella democrazia
nell’era di Pericle
di Selene Miriam Corapi
Da Armando, un saggio approfondito
sulla società civile dell’antica Grecia
«Sono i Greci che hanno inventato la politica, la parola e la cosa. Politica viene infatti da pólis, termine greco che noi traduciamo con “città”. Quando i Greci tentavano di definire ciò che intendevano con questo termine, essi parlavano di una koinonía tôn politôn, di una “comunità di cittadini”». La Grecia non era uno stato, ma comprendeva una moltitudine di piccoli stati autonomi, accomunati tra loro per lingua, religione e cultura; di questi piccoli stati le póleis erano le strutture più forti. Ma quando nasce la città greca? E da quando si può parlare di cittadino e cittadinanza? Nell’opera Il cittadino nella Grecia antica (Armando editore, pp. 128, € 12,50), Claude Mossé racconta brevemente le diverse forme in cui le póleis greche hanno praticato quel tipo di rapporto tra individuo e comunità di appartenenza: la cittadinanza. L’illustre autrice ha condotto numerosi studi scientifici sul mondo greco, ciò è ampiamente confermato dalle sue numerose pubblicazioni tradotte nelle diverse lingue principali. Il periodo di riferimento preso in esame comprende la fase più arcaica fino alla “fine della democrazia ateniese”. Il sistema istituzionale privilegiato è quello di Atene, ciò dovuto alla moltitudine di documenti pervenutici; non mancano riferimenti ad altre grandi comunità, come ad esempio Sparta.
Al termine di ogni capitolo vi è una raccolta di documenti tratti dai testi degli autori antichi, molto interessanti, volti a esplicitare quanto precedentemente descritto, dando la possibilità di attingere alle informazioni direttamente dalle fonti originarie. Un supporto molto utile che aiuta a riflettere criticamente in maniera autonoma, e un valido strumento d’approfondimento e di studio per gli allievi. A conclusione della trattazione vi sono altri sussidi: il glossario delle istituzioni politiche, le informazioni principali sui personaggi storici menzionati, una tavola cronologica e una bibliografia; il tutto per solleticare e invogliare il lettore o lo studente più curioso ad approfondire questo argomento.
Le origini della città greca
Il problema delle origini è davvero molto dibattuto da parte degli storici; è quasi certo che nel secondo millennio nella penisola balcanica sopraggiunsero popolazioni che parlavano una lingua che poi divenne il greco; ma come avvenne e quale sorte subirono le popolazioni autoctone con cui si confrontarono restano ancora problemi insoluti. Abbiamo testimonianze antiche che i Greci tramandarono sulle loro origini, ma probabilmente sono ricostruzioni più tarde volte a giustificare ambizioni politiche posteriori.
Nel XVII secolo a.C. si formano in alcune regioni della penisola centri importanti dove si sviluppò una fiorente civiltà: i Micenei stanziatisi a Micene, in Argolide, a Nord-Est del Peloponneso, diedero luogo alla civiltà Micenea.
Le nostre conoscenze sulla fase arcaica sono descritte nelle due più celebri opere letterarie antiche pervenuteci, attribuite ad un illustre autore, Omero – o composte da una serie di autori riconducibili a questa figura –: ci stiamo chiaramente riferendo all’Iliade e all’Odissea, la cui autenticità è stata messa in dubbio dagli storici, che hanno dato luogo ad una vera e propria “questione omerica”, ma hanno ottenuto una parziale validità storica grazie alla scoperta dei siti archeologici da parte di un uomo d’affari, Heinrich Schliemann. Nel 1874 iniziarono gli scavi sul sito di Micene, dove furono riportati alla luce i resti di un palazzo fortificato, tombe con numerosi materiali e oggetti, e le note tavolette in lineare B, decifrate un secolo e mezzo più tardi.
Gli scavi e le tavolette ci hanno fornito una testimonianza importante: si è scoperto che l’antica civiltà aveva una struttura sociale complessa organizzata secondo il modello “palaziale”, cioè secondo una gerarchia piramidale, al cui vertice vi era il “re” o wanax, che controllava la produzione nel palazzo e dei villaggi limitrofi e intratteneva rapporti con altre località (Creta, Egitto, Siria, ecc.); seguiva il lawaghetas, che comandava l’esercito; poi c’erano i sacerdoti e gli aristocratici; i qasirewes (in greco basileis), che assegnavano le terre e riscuotevano i tributi; infine al gradino più basso c’erano i doeloi, gli schiavi.
Alla fine del XIII secolo a.C. questa civiltà venne brutalmente distrutta, probabilmente a causa del sopraggiungere di nuovi invasori; questo periodo e quello successivo, fino al momento in cui si avrà la nascita delle città greche, viene contrassegnato dagli storici come “Età buia”, una sorta di Medioevo greco di forte regresso culturale, sociale e politico.
L’archeologia rivela che a fine IX secolo vi fu una forte ripresa e crescita degli insediamenti umani, degli scambi commerciali, dell’uso della scrittura e, a partire dalla metà dell’VIII secolo, una notevole espansione nel Mediterraneo occidentale e poi in quello orientale. Nascono le città greche e il concetto di cittadinanza, che verrà elaborato lentamente attraverso una serie di “crisi”: quella agraria risolta da Solone (legata al problema della terra e alla base dell’espansione nel Mediterraneo); quella che sfociò nella tirannide, figura che nell’immaginario greco collettivo corrisponde all’anticittadino per eccellenza (a differenza del tiranno Pisistrato, che fu molto abile e utilizzò il suo potere assoluto per segnare l’inizio della grandezza di Atene); e con una serie di diversi fattori: economici; agrari, con lo sviluppo di attività non legate alla terra; l’introduzione della moneta; fattori sociomilitari con la creazione dello schieramento oplitico; e infine, grazie ai diversi provvedimenti presi con le riforme di Clistene, di Temistocle e di Pericle, si creò e si estese il diritto di cittadinanza, inteso come il diritto di tutti a dare il proprio contributo per poter così prendere le decisioni più importanti per la città.
Il “mestiere” del cittadino
Come si diventava cittadino? Per poter assolvere a questo compito bisognava possedere determinati requisiti. «I criteri di appartenenza alla comunità civica variavano sensibilmente da una città all’altra e si definivano essenzialmente attraverso forme di esclusione». Il corpo civico non si identificava con l’intera popolazione; perché in una grande città come Atene vi erano anche gli stranieri, i meteci (ossia gli stranieri con il diritto di cittadinanza) e gli schiavi. Uno dei primi criteri di cittadinanza era l’essere libero di nascita, ossia nato da genitori cittadini (strumento per porre fine ai matrimoni misti con stranieri). Da questo criterio erano esclusi gli artigiani e i commercianti, le cui attività erano considerate indegne per un cittadino; lo erano anche i poveri, poiché era richiesto un minimo di ricchezza per poter accedere al diritto; e lo erano pure le donne, le quali, benché avessero la cittadinanza e con il matrimonio la trasmettessero ai figli, facevano parte della comunità civica ma non di quella politica, per cui non potevano partecipare alla “cosa pubblica”. Si poteva, inoltre, essere ammessi nella comunità civica facendo parte delle phatríai, una forma di raggruppamento costitutivo della città, ossia delle aggregazioni integrate nell’organizzazione della città; o anche attraverso il demo, la circoscrizione territoriale ereditaria, che aveva le sue assemblee e i suoi magistrati e interveniva nella scelta dei cittadini che avrebbero dovuto organizzare le grandi feste. I giovani si potevano iscrivere alle liste dei cittadini all’età di diciotto anni e, dopo la loro iscrizione al demo, dovevano sottoporsi all’ephebeía, un periodo di due anni in cui venivano addestrati militarmente, al termine del quale potevano accedere, all’età di vent’anni, alla comunità politica vera e propria. Si poteva ottenere la cittadinanza per benemerito, per servigi nei confronti della comunità; oppure la si poteva ottenere illegalmente per frode e sotterfugi vari.
Il diritto di cittadinanza poteva essere revocato se ci si macchiava di determinati crimini; il termine per definire questa situazione d’esclusione era l’atimía, che comportava la perdita dei diritti politici e il divieto di accedere ai santuari della città, pur continuando a far parte del corpo civico; il provvedimento non era ereditario, tranne nel caso in cui il destinatario dell’atimía fosse un debitore dello stato, morto prima di aver assolto il debito: in tale circostanza l’atimía veniva ereditata dai figli fino a quando avessero estinto il debito.
Sebbene tutti i cittadini fossero chiamati a partecipare alla conduzione della vita politica della propria città, in realtà vi era una classe politica ristretta, una minoranza che disponeva di un ricco patrimonio e del tempo libero necessario e, ricoprendo cariche di alta magistratura, si occupava della conduzione della comunità; ed essa, in misura minore, era presente anche ad Atene.
Dibattito sulla politeía
Il concetto di cittadinanza si è formato lentamente nel tempo; nel V secolo a.C. gli intellettuali elaborarono la definizione di politeía, ossia “costituzione”. Lo storico moderno Edouard Will dà al termine un’altra sfumatura e afferma: «È il “diritto di cittadinanza o la “cittadinanza”; è anche l’insieme del corpo civico, di coloro che beneficiano della cittadinanza; infine è il sistema delle istituzioni della pólis e la maniera di farle funzionare. “Partecipare alla politeía” significa dunque beneficiare dei suoi diritti civili e di tutto ciò che ne deriva in materia di partecipazione alle istituzioni (politiche, militari, giudiziarie, religiose)». Già gli autori antichi si ponevano il problema di dover dare una definizione al termine politeía: Erodoto nelle Storie sostiene che il miglior regime politico era quello che si basava sull’isonomia, «in cui le magistrature sono estratte a sorte, si risponde dell’autorità esercitata e tutte le decisioni sono presentate alla comunità».
Platone, uno dei più illustri filosofi dell’epoca, elabora il progetto di politeía, immaginando una città ideale in cui tutti condividono tutto, i beni materiali e anche le donne e i bambini.
Anche Aristotele, nella Politica descrive una possibile città ideale, passa in rassegna tutte le forme di costituzioni; e si sofferma a definire cosa significa essere cittadino: «è colui che partecipa “alla krísis e all’arché”, cioè alle funzioni di giudice e di magistrato […] egli chiamerà cittadini tutti coloro che hanno la “possibilità” di partecipare al potere deliberativo e giudiziario, anche se vi sono dei momenti in cui non lo esercitano».
Cittadinanza greca versus cittadinanza romana
«La diffusione della cittadinanza nel mondo greco corrisponde dunque ad un momento relativamente breve della storia della civiltà occidentale. […] parallelamente alla sua elaborazione si è sviluppata ad ovest del Mediterraneo la cittadinanza romana». Tra l’una e l’altra vi sono però delle differenze: per Roma la cittadinanza non ha mai comportato l’uguaglianza, perché vi erano diversi gradi di potere; vi erano diseguaglianze sociali dovute al sistema censitario su cui si basava; inoltre, in un secondo momento, essa divenne uno status più che una funzione, quando venne estesa a popoli lontani dall’Urbe, a tutti gli uomini liberi, per volere dell’imperatore Caracalla. Ciò che le accomuna è che entrambe implicavano la sovranità della comunità civica, anche se per Roma questa sovranità era condivisa con il Senato.
La fine della pólis
«L’originalità della città greca […] risiedeva, infatti, soprattutto nel fatto che, in seno a questa comunità, le decisioni venivano prese in presenza di tutti, anche se il più delle volte si trattava solo di approvare quello che proponeva una minoranza detentrice della ricchezza, della forza militare e dell’autorità religiosa. […] la storia delle città greche è segnata dall’allargamento […] di questa minoranza, fino a quando essa finisce per inglobare tutti i membri della comunità, come avverrà nell’Atene democratica a partire dal V secolo. Fu lì che, al termine di un’evoluzione che durò due secoli, il cittadino diventò il detentore della sovranità e il “mestiere” di cittadino una realtà, fino a quando, vinta dalla Macedonia, la città dovette rinunciare a una parte della sua autonomia e i cittadini a una parte della loro sovranità».
Con l’avvento di Alessandro Magno e la creazione del suo grande impero, i cittadini dell’antica Grecia divennero sudditi e non più partecipi in prima persona alla conduzione della città. Ebbe così fine la pólis.
Selene Miriam Corapi
(www.bottegascriptamanent.it, anno VIII, n. 88, dicembre 2014)
Ilenia Marrapodi