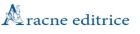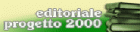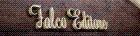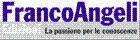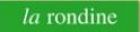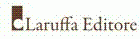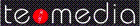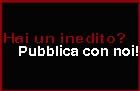Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Mario Saccomanno
A. XIX, n. 208, feb. 2025
 Le forze dell’ordine
Le forze dell’ordineal servizio della comunità
di Francesca Rinaldi
Da Castelvecchi, il racconto di quarant’anni
di polizia italiana tra lotte, riforme e democrazia
Quando Ennio Di Francesco vince il concorso in polizia è il 1969. È un laureato in Giurisprudenza con tanti ideali e, soprattutto, per lui la divisa è «una scelta di vita». Già nel 1965, subito dopo la laurea, aveva prestato servizio di leva come ufficiale dell’Arma. Suo padre era un sottufficiale dei carabinieri sempre al lavoro e ligio al dovere. È per lui dunque un grande onore iniziare il suo impegno come servitore dello stato dopo il corso di vicecommissario nel 1970 ed essere assegnato alla Questura di Genova.
Comincia così la storia professionale del commissario Di Francesco, che mai come in questo caso, possiamo dire, coincide anche con la sua vita personale.
Il racconto serio, documentato, ma sempre emozionante della sua vita in polizia, Ennio Di Francesco lo affida al libro autobiografico Un commissario. L’odissea di un funzionario dello Stato (Castelvecchi, pp. 374, € 18,50). Il sottotitolo fa subito pensare che non è la storia tranquilla e monotona di un normale funzionario ministeriale, ma quella della polizia italiana tutta e della sua trasformazione.
Le convinzioni che lo spingono a diventare poliziotto sono le stesse che lo guidano nel suo modo di agire come uomo, sempre pronto a farsi carico dei più deboli e a capire le ragioni e lo stato d’animo di chi commette dei crimini. La sua instancabile ricerca di giustizia lo porta anche a capire i problemi all’interno del corpo di polizia, che a cominciare proprio dal cosiddetto “autunno caldo” diventano vere e proprie istanze di rinnovamento.
La richiesta di democrazia e la spirale della violenza
Dopo il fascismo, il corpo di polizia venne sì epurato, ma portato verso un «vecchio modello di “polizia moderna”» (cfr. Donatella della Porta e Herbert Reiter, Polizia e protesta, il Mulino). Tuttavia, è con l’avvento del ministro Mario Scelba che il modello cambia e si riaffermano vecchie concezioni autoritarie, che sembrano sopportare poco la nuova Costituzione repubblicana. Quella di Scelba è, per capirci, la polizia della Celere, la polizia militarizzata con armamento pesante per affrontare le esigenze di ordine pubblico. E non dimentichiamo il divieto d’iscrizione a un sindacato per i poliziotti di qualsiasi ordine e grado.
Negli anni Sessanta, l’Italia è un paese in trasformazione, nel quale sta giungendo a conclusione la cosiddetta “prima transizione demografica”, che porta con sé sia il baby boom sia la piena occupazione e, con essa, una rivendicazione di maggiore potere da parte dei sindacati.
Di pari passo con le manifestazioni studentesche e con la conflittualità operaia, che infervorano l’Italia tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta, viaggia anche il movimento di democratizzazione della polizia.
E proprio a Genova il giovane commissario si rende conto di quanta distanza ci sia tra la polizia, la società e il mondo del lavoro, di quante cose potrebbero essere migliorate, e inizia a scrivere sulla rivista Ordine pubblico diretta da Franco Fedeli, che già ospitava un aperto dibattito su un rinnovamento del corpo. Così, Di Francesco comincia a lavorare per una polizia diversa, più specializzata, più competente: un processo di trasformazione che riguarda non solo i funzionari, ma anche e soprattutto la base, e che auspica la smilitarizzazione del corpo e la sua sindacalizzazione.
A causa del suo impegno e della sua attività, Di Francesco viene trasferito da Genova a Roma, all’Ispettorato generale per l’azione contro il terrorismo, dove diventa un esperto di terrorismo anche a livello internazionale, studia la Raf tedesca e l’Esercito rosso giapponese. Sono anni complicati, il paese è ferito, si indaga sugli attentati di piazza della Loggia e dell’Italicus. Con l’aumento della tensione cresce anche il livello di scontro nelle piazze: i poliziotti, mal pagati e con scarsissimi diritti, spesso diventano un facile obiettivo sia per i dimostranti che per la stampa engagée. Per Di Francesco e altri suoi colleghi una riforma che preveda anche il diritto al riposo e alle ferie si fa sempre più necessaria. Le riunioni clandestine dei «poliziotti carbonari» continuano: incontrano parlamentari e leader dei sindacati. Il nostro commissario a Roma riesce a ottenere proprio dalla Federazione unitaria dei sindacati Cgil-Cisl-Uil una stanzetta in via Sicilia, che ben presto si trasformerà nella prima sede di un sindacato di polizia.
Art. 3: «L’amministrazione della pubblica sicurezza è civile»
Il 21 dicembre 1974 è una data storica per la polizia italiana. Nella sala congressi dell’hotel Cavalieri Hilton di Roma ha luogo il primo pubblico convegno sulla riforma della polizia, cui partecipano, assieme ai poliziotti, anche alcuni parlamentari e sindacalisti del Comitato di studio della Federazione unitaria sindacale per la creazione di un sindacato di polizia.
A carico dei poliziotti che pubblicamente si sono esposti scattano i provvedimenti di disciplina con inchieste, relazioni al veleno e “veline” interne non sempre veritiere. Anche su Di Francesco, trasferito intanto presso la squadra mobile di Roma, sezione narcotici, si avvia un procedimento disciplinare per «avere svolto attività sindacale», vietata in polizia anche ai funzionari da un decreto luogotenenziale del 1944, «pena la decadenza dall’impiego». La difesa del commissario, presentatosi dinanzi alla commissione disciplinare, rimarca l’incostituzionalità di quel decreto in palese contrasto con la Costituzione repubblicana, che sancisce il diritto di associazione e la libertà sindacale sebbene entro certi limiti. Ed è proprio ciò per cui si battono in quegli anni i «poliziotti carbonari», spiegando che le restrizioni per le categorie speciali, tra cui i poliziotti, avrebbero dovuto essere esplicitate e introdotte.
E mentre l’inasprimento del conflitto nel paese con uccisioni, gambizzazioni e rapimenti di politici e magistrati porta alla promulgazione di leggi reazionarie come la legge Reale, al Ministero dell’Interno si susseguono i ministri, da Luigi Gui a Francesco Cossiga a Virginio Rognoni, e con loro le varie circolari interne, fino ad arrivare alla circolare Cossiga 555/318 che «resta una pietra miliare di democrazia: “I poliziotti potranno liberamente esprimere giudizi e opinioni relativamente alla riforma di Polizia […]. Potranno riunirsi negli uffici, al di fuori dell’orario di servizio, nell’assoluto rispetto della libertà e del pluralismo”».
La strada è aperta: le riunioni pubbliche, i convegni nazionali non possono essere perseguiti con sanzioni disciplinari. Ed ecco, il 17 luglio 1975 a Roma, il primo convegno nazionale in via Sicilia con la creazione dei “libri bianchi” dei poliziotti. Il 18 luglio, sempre a Roma, al Teatro delle arti, il convegno “Polizia in uno stato democratico” con vari giuristi e rappresentanze politiche tra i relatori. Il 18 aprile 1977, al cinema parrocchiale “Don Orione” la prima assemblea costitutiva del Sindacato autonomo di polizia. E il 2 ottobre dello stesso anno, al Palazzetto dello sport all’Eur, quattromila poliziotti giunti da tutta Italia nominano seicento delegati che il 10 dicembre alla Domus paci di Roma votano i loro undici rappresentanti dell’esecutivo nazionale tra cui Di Francesco. Il 20 dicembre la Federazione unitaria sindacale indice uno sciopero nazionale di un’ora per la riforma della polizia e dire basta al terrorismo.
Il dado si può dire ormai tratto. Il 1° aprile 1981 viene promulgata la legge n. 121: Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. La legge nei suoi 115 articoli porta molte innovazioni, tra cui l’articolo 3, il cui primo comma recita: «L’amministrazione della pubblica sicurezza è civile». Lo status civile contiene il diritto di sindacalizzazione, benché in forma limitata, non potendo infatti iscriversi a «sindacati diversi da quelli del personale di polizia né assumere la rappresentanza di altri lavoratori».
Successi internazionali, blocco nazionale
Nonostante i successi extranazionali di Di Francesco alla Criminalpol regionale prima e nazionale poi e fortemente voluto dai colleghi esteri presso il segretariato generale dell’Interpol in Francia a Saint-Cloud, alla fine del 1984, dopo dieci anni di collaborazioni con le polizie degli altri paesi e di permanenza in organismi internazionali, con un bagaglio di esperienze e conoscenze indiscutibile, il ritorno in Italia viene imposto in tempi strettissimi, con un reintegro a Roma nel servizio centrale antidroga e la stessa qualifica di dieci anni prima. Il Consiglio di amministrazione per le promozioni riunito al Viminale gli ha negato, infatti, la promozione a dirigente. Il commissario Di Francesco, avvalendosi della possibilità offerta dalla nuova legge di riforma, transita al Ministero degli Esteri e, «con la morte nel cuore», lascia la polizia.
Gli anni alla Farnesina sono colmi di tristezza e rimpianti per la polizia, ma dedicati con tenacia alla lotta al traffico internazionale di droga durante il giorno e alla scrittura di notte. Tuttavia, alla fine il suo animo di poliziotto non resiste: decide di rientrare nonostante l’iter di reintegrazione sia lungo e farraginoso. E, nel 1997, il vicequestore aggiunto Di Francesco sale i marmorei scaloni del Viminale. Da quel giorno, sempre con la tempra del poliziotto di rango, svolge qualunque compito gli venga affidato con puntualità, senza mai ottenere una promozione e, nonostante i ricorsi al Tar, sarà «collocato a riposo d’ufficio per limiti d’età» nel 2004, nel bel mezzo di un’importante trattativa internazionale per aumentare il peso della polizia italiana all’interno del Cepol (l’agenzia di alta formazione per le polizie europee).
Di sicuro la pensione “forzata” non ha messo a riposo un “radicalmente sbirro” come Di Francesco, che oltre a questo volume – riedizione ampliata di un testo del 1990 edito più volte da Marietti –, ha al suo attivo altri titoli. Inoltre, ha il merito di aver contribuito a dare visibilità e luce alla vicenda umana e tragica di Giovanni Palatucci, irpino questore di Fiume che, nel 1944, venne internato a Dachau per aver aiutato molti ebrei a fuggire alle persecuzioni nazifasciste.
Una riforma incompiuta
Il libro di Di Francesco ha il pregio di spiegare e raccontare il difficoltoso percorso che ha portato alla riforma della polizia. Percorso fondamentale tanto se non quanto la riforma stessa. Lo spirito di servizio, l’attitudine a sentirsi dalla parte del cittadino, il proposito di difendere i più deboli a cominciare dal “corpo delle guardie”, di lottare anche per i loro diritti, l’orgoglio di far parte di una forza di rinnovamento: tutti questi sentimenti hanno portato un gruppo di persone a creare un movimento condiviso sia dall’opinione pubblica che da tutte le forze politiche, aprendo dibattiti su riviste specializzate e riuscendo ad arrivare anche alla stampa considerata “ostile”. La legge 121/1981, però, risulta “mutilata” perché sicuramente ha raggiunto in maniera limitata l’obiettivo della smilitarizzazione e, inoltre, perché una successiva legge, la n. 78/2000, sul riordino di carabinieri, corpo forestale, guardia di finanza e polizia di stato e sul coordinamento dei corpi di polizia ha di fatto aumentato di molto l’autonomia dei carabinieri, rafforzata e sganciata dal capo della polizia (quindi creando una forza di polizia ampiamente militarizzata).
È in questo contesto che la Nota aggiuntiva, capitolo finale del libro di Di Francesco, citando anche il caso Biagi, i fatti della scuola Diaz di Genova, il caso kazako, descrive quasi il fallimento dello spirito originario della riforma, in una situazione attuale dove la specializzazione in ordine pubblico viene superata dalla difficoltà di coordinare corpi diversi e l’autonomia sindacale sembra essere un coacervo di siglette rivali fino ad arrivare alla discrezionalità nelle promozioni. Anche gli storici sono concordi nel sostenere che «se la riforma – e più ancora la lotta per la riforma – ha profondamente cambiato il volto della polizia italiana, le sue molte potenzialità saranno frustrate dal prevalere, nelle forze politiche e all’interno della polizia, di componenti ostili al mutamento» (cfr. Polizia e protesta, op. cit.).
Francesca Rinaldi
(www.bottegascriptamanent.it, anno VIII, n. 88, dicembre 2014)
Ilenia Marrapodi