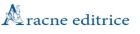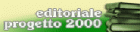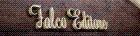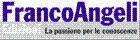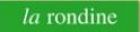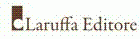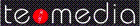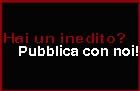Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Graziana Pecora
Anno VIII, 87, novembre 2014
 L’idea nuova
L’idea nuovadell’ecocritica
di Federica Lento
Natura e letteratura
si intrecciano.
Un libro Donzelli
Quando parliamo di letteratura immaginiamo, ingenuamente o per rassegnata assuefazione, comodi salotti in cui geniali uomini e donne di penna si confrontano sulla scrittura; un mondo chiuso, quasi orgogliosamente ermetico. Pensare a questa disciplina aperta ad altri ambiti potrebbe disorientare cultori e specialisti della materia . Eppure negli Stati Uniti, di recente, si è parlato di un contatto tra il mondo della letteratura e quello dell’ecologia, tra il “dentro” e il “fuori”, di un modo per alzare lo sguardo dal proprio “Io” e aprirsi alla natura, prendendo in seria considerazione i rischi cui oggi è soggetta. Nella raccolta di saggi Ecocritica. La letteratura e la crisi del pianeta (Donzelli, pp. 240, € 27,00), a cura di Caterina Salabè, i numerosi studiosi interessati al tema dell’ecocritica si muovono tra ecologia e critica letteraria, cercando il legame tra la vita umana e l’universo in una sorta di nuovo umanesimo.
Il punto sull’ecocritica
Grazie agli studi del biologo tedesco Ernst Haeckel, nella seconda metà dell’Ottocento si ha una vera e propria rivoluzione antropologica che vede nascere, circa un secolo dopo, negli Stati Uniti, l’esigenza di nuove riflessioni sull’interdipendenza tra gli esseri viventi. Il termine “ecocritica” apparve per la prima volta nel saggio Literature and Ecology: An Experiment in Ecocriticism, in cui l’autore William Rueckert proponeva di ricorrere agli strumenti della letteratura, nella quale il fattore umano è prevalente, per esplorare e descrivere la natura e l’ecologia. Raccogliendo i saggi di Lawrence Buell, Maria Letizia Costantini, Roberto Della Seta, Emilia Di Rocco, Lorenzo Franchini, Amitav Ghosh, Daniele Guastini, Robert Pogue Harrison, Serenella Iovino, Giorgio Mariani, Piero Marietti, Andreas Puff-Trojan, Francesca Orestano, Anna Re, Loreto Rossi, Niccolò Scaffai e Scott Slovic, Caterina Salabè lancia la nuova immagine di un letterato ecologico, lontano dalla chiusa arroganza accademica, interessato al mondo esterno.
Ecocritica come riavvicinamento di uomo, testo e mondo
La raccolta si apre con alcuni versi di Derek Mahon, tradotti da Caterina Salabè, e dedicati a Pier Paolo Pasolini: «E il poeta della povertà, cenere sul vento notturno, / luce di stelle e blocchi di torri sul suolo incolto, / discariche di periferia dietro al rumore / di un circo, dove ragazze e ragazzi sedati, / si danno per due soldi in qualche cantiere / dentro all’impero annuvolato della notte antica / e tra le rovine, in mezzo a vite sconsolate / al margine della città ricca d’ingegno, un mito sopravvive. / La sua è la giusta direzione che abbiamo smarrito / da quando il suo cadavere apparve sulla spiaggia di Ostia / e la vita che conosciamo si è evoluta in immagine, / valori di produzione, storia preconfezionata, / l’imperativo genocida d’impresa / e la luminosa immondizia sulla marea montante, / visibile al meglio nel traffico mattutino sotto una pioggia sferzante: / «Nei rifiuti del mondo nasce un nuovo mondo». Pasolini aveva distinto, anticipando straordinariamente i tempi, l’idea di sviluppo economico da quella di progresso: la prima fondata sull’infinito guadagno materiale, la seconda sulla conoscenza, sulle idee, con l’inesorabile vittoria della prima sulla seconda. Lontani dalla rivoluzionaria Età dei lumi, quando tutto si poteva spiegare razionalmente, oggi il progresso non riguarda più soltanto «un ideale di educazione alla virtù (o alle virtù), all’essere uomini e donne secondo verità, giustizia, bellezza». Il nuovo orientamento antropologico, infatti, rimanda all’ambito ecologico, quello dei luoghi o, meglio, «delle relazioni dell’organismo con l’ambiente circostante», come affermava il biologo tedesco Ernst Haeckel nel libro Generelle Morphologie der Organismen del 1866. L’ecologia studia il rapporto tra gli esseri viventi e, nell’accezione di ecocritica (crasi per “ecologia” e “critica letteraria”), si concentra sui luoghi che indirizzano la ricerca letteraria «verso un ripensamento dell’umanesimo tradizionale che accolga la nuova consapevolezza di una interdipendenza tra la vita umana e tutta la diversificazione di esseri viventi, di elementi naturali, e di beni culturali che compongono la sua dimora terrestre». L’ecocritica studia pertanto la letteratura come strategia di sopravvivenza dell’essere umano che si avvicina al testo letterario, che a sua volta racconta il mondo.
Il letterato ecologico nell’era postintellettuale
Nel testo si chiama ancora in causa Pasolini, definito “letterato ecologico” quando scriveva: «[il] primo dovere di un intellettuale [è] quello di esercitare prima di tutto e senza cedimenti di nessun genere un esame critico dei fatti […] dimenticando le rabbie manichee contro tutto il Male, rabbie che oppongono ortodossia a ortodossia». L’intellettuale deve confrontarsi con l’ecologia; egli non è un profeta di disastri ambientali e sociali ma interprete, come scrive Ernst Bloch, «di una pedagogia della speranza». Il testo, insomma, ci spinge a riflettere sull'importanza dell'educazione al tema della costruzione piuttosto che alla demolizione, in una condivisione tra essere umano e natura, o meglio tra ogni forma vita.
Federica Lento
(www.bottegascriptamanent.it, anno VIII, n. 87, novembre 2014)
Francesca Buran, Ilenia Marrapodi, Pamela Quintieri, Francesco Rolli, Fulvia Scopelliti
Simona Baldassarre, Maria Laura Capobianco, Maria Assunta Carlucci, Alberto Cazzoli, Guglielmo Colombero, Selene Miriam Corapi, Veronica Di Gregorio Zitella, Giacomo Dini, Riccardo Fiorenza, Maria Francesca Focarelli Barone, Vilma Formigoni, Federica Lento, Chiara Levato, Giuseppe Licandro, Flavia Maccaronio, Irene Nicastro, Maristella Occhionero, Giusy Patera, Stefania Pipitone, Luciana Rossi, Martino Santillo, Maria Saporito, Paolo Veltri, Andrea Vulpitta, Carmine Zaccaro
Denise Amato, Selene Miriam Corapi, Vilma Formigoni, Aurora Logullo, Rosina Madotta, Manuela Mancuso, Ilenia Marrapodi, Pamela Quintieri, Francesca Rinaldi, Francesco Rolli, Fulvia Scopelliti