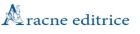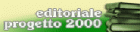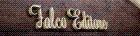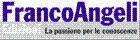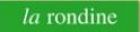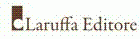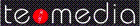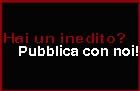Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Graziana Pecora
Anno VIII, n 84, agosto 2014
 Coltissime poesie dell’istante
Coltissime poesie dell’istantetra filosofia e immaginazione
di Ettore Rocca
Un’intelligente summa condensa gli affascinanti attimi della vita,
e coglie gli aspetti delle riflessioni di Kierkegaard e dei presocratici
I componimenti di Natina Pizzi, appena pubblicati da Città del sole editore, tanto enigmatici quanto pregnanti, assurgono a versi che abbracciano una dimensione cosmica, temporale, nell’adoperare un «linguaggio alato», per dirla come Elsa Morante, che sa toccare altezze e precipizi.
Qui di seguito ripubblichiamo il Saggio introduttivo dell’insigne studioso Ettore Rocca.
La scrittrice inizia, una decina d’anni fa, la sua produzione poetica con la silloge Che senso ha (Kaleidon, 2005), cui segue Afrodite (Calabria Letteraria – gruppo Rubbettino, 2007), premio “Città di Palmi” 2008, quindi L’istante perfetto (Iride – gruppo Rubbettino, 2009) e Lo spigolo del cerchio (Iride – gruppo Rubbettino, 2012). Ogni silloge è accompagnata da importanti Prefazioni: Pasquino Crupi, Rocco Familiari e Walter Pedullà. L’opera è l’assembramento delle tre raccolte già citate, Afrodite, L’istante perfetto, Lo spigolo del cerchio: Trilogia dell’istante (Città del sole edizioni, pp. 312, € 20,00).
Si indaga l’istante che ci porta dall’essere al non essere e viceversa; Natina percorre le pieghe del tempo e istituisce un perfetto dialogo con i classici. Come afferma Ettore Rocca, uno dei massimi esperti viventi di Søren Kierkegaard, nel suo Saggio introduttivo all’opera poetica: non si tratta «di illustrare poemi o rinarrare miti, bensì di utilizzare la propria voce poetica per dialogare con essi»; ad affascinare è la novità del dialogo, la sorprendente freschezza, il ritmo ben delineato – per aumentare la fluidità del dettato poetico l’autrice elimina la punteggiatura –, le nuove immagini che vengono scolpite e delineate.
L’istante è anche, a livello temporale, la divisione del tempo che viene scardinato e tagliato per suo mezzo. La poetessa si dilunga, così, a sperimentare le gioie e le trepidazioni di tali attimi (gli «istanti miei istanti» dello scritto introduttivo dell’autrice alla trilogia) nelle piccole vicissitudini quotidiane, momento perfetto in cui avvengono, prima, la percezione e la sensazione, poi, la versificazione. Si cattura, così, il ricordo in fugaci, ma intensissimi, tableaux.
Le poesie sono oramai percepite come pensieri, attimi, istanti, tramutati in immagini, parole leggere, fugaci che colpiscono il lettore, nel profondo, con un andamento dolcissimo. È poesia che insegna a vivere, ad amare, ad andare al di là, a soffermarci sulla bellezza delle cose. Leggendo questi versi lirici, così colti e profondi, che sgorgano spontaneamente come acqua, e con infinito amore (l’amore per la vita), avvertiamo che la poetessa, da anni ed anni “non vedente”, coglie ciò che l’occhio umano non vede e non può vedere: abbraccia il mondo e lo disegna rimodellandolo con l’occhio della mente.
Bottega editoriale
Saggio introduttivo
Pensiero dell’istante, poesia dell’istante
Trilogia dell’istante è il titolo che Natina Pizzi ha dato alle sue tre raccolte Afrodite, L’istante perfetto e Lo spigolo del cerchio [1], che qui sono pubblicate in un unico, prezioso volume. La parola poetica ha il potere di sottoporre l’esperienza a uno straniamento, che sia quella quotidiana, culturale o di pensiero. È come se la nostra esperienza, che giorno dopo giorno si solidifica, sia resa di nuovo fluida, per sorprenderci, inquietarci o riscaldarci di nuovo. La poesia ci chiede il coraggio di tornare nel luogo dove le convenzioni non sono ancora stabilite, dove i costumi non sono ancora codificati, dove i concetti non sono ancora fissati.
Questa fluidificazione è quasi programmatica in Afrodite, in cui ciascuna lirica porta il titolo di un personaggio della mitologia, del pensiero o della letteratura classiche. Il fine non è quello di illustrare poemi o rinarrare miti, bensì di utilizzare la propria voce poetica per dialogare con essi. Darò qualche esempio del colloquio che Natina Pizzi instaura con alcuni pensatori, per mostrare come avvenga questo straniamento nell’incontro tra la poesia e il pensiero.
La storia della filosofia viene spesso fatta cominciare da Talete. Sostenne, così ci è stato tramandato, che «il tutto è pieno di divinità»; che «l’acqua è il principio di tutte le cose»; che «Dio è la mente che dall’acqua ha costruito tutte le cose» [2]. Dio è presente in tutto e la fluidità dell’acqua, nelle sue mani, dà origine all’universo e alla vita.
Pizzi risponde: «Dimmi dentro la bocca che mi ami / ingoierò / innaffierò le parole con l’acqua dell’illusione» [3]. L’acqua, principio della vita, diventa l’acqua con cui innaffiare e ingoiare le parole dell’amore, quasi fossero bocconi solidi che solo l’acqua può aiutare a deglutire. Quell’acqua, con cui per Talete il Dio ha dato forma a ogni cosa, diventa in Pizzi – improvviso rovesciamento – l’acqua dell’illusione.
Parmenide non fu solo pensatore. Il suo scritto Sulla natura è un poema in versi di aspra bellezza. Racconta un viaggio iniziatico: delle cavalle trascinano il suo carro dalle «case della notte» verso la luce, al cospetto della Dea che gli rivela «sia l’animo inconcusso della ben rotonda verità / sia le opinioni dei mortali». La verità è l’Essere, che non nasce né muore, ma sempre sta tutt’intero, unico, immobile, identico a se stesso. Solo l’Essere può essere davvero pensato, la molteplicità dell’universo, invece, è illusione ed errore: «Perciò saranno tutte soltanto parole / quanto i mortali hanno stabilito, convinti che fosse vero: / nascere e perire, essere e non essere / cambiamento di luogo e mutazione del brillante colore» [4].
Pizzi gli fa eco con il proprio viaggio iniziatico [5]: «Ho indirizzato la magica scala / squarciato l’azzurro del cielo / volta di tutte poesie / mancava la mia del mistero». Ma nella volta della poesia e del pensiero Natina Pizzi non ritrova la condanna del mutamento e della sensazione, bensì la rivendicazione dei sensi e dei colori, fino all’oblio del pensiero: «versi di tutti i colori / rime d’amore accese / incastonate in quel cielo / dimentico del mio pensiero». Riaffermare i sensi è esperienza così forte da oscurare perfino le parole: «cielo che tutto comprende / non è distratto non vuole / cielo a cui tutti s’appendono / oscura le mie parole». Parole nude, parole senza pelle, che sgorgano dalla sofferenza e che paiono esser rifiutate dal cielo: «versi sgorganti dall’alma / profonda sincera sofferta / rime senza un velo / neanche il cielo le accetta». Più che dire le proprie parole, si tratta allora di ascoltare quelle dell’altro, scritte anch’esse, nella loro vellutata materialità, per i sensi: «le tue rime sotto la volta / col velluto erano scritte / rime da me ascoltate». La sfida all’essere immutabile e insensibile di Parmenide, fatta sotto il cielo del tempo, fa però aprire le nostre ferite. È questo il prezzo da pagare, sigillato nel verso conclusivo: «man mano che si aprìan le ferite».
La ribellione a Parmenide avviene allora in nome del mutamento, della fluidità, della contraddizione, della fedeltà al ritmo del nascere e del morire. La parola chiave di questo colloquio ribelle è: l’istante.
Parola che ci porta di nuovo a Parmenide, non però alla figura storica, bensì all’omonimo dialogo di Platone. È proprio per comprendere il nascere e il morire – contra Parmenide – che Platone introduce l’istante. Come è possibile assumere o abbandonare l’essere, come è possibile pensare il nascere e il perire? L’istante, to exaiphnes, è il passaggio, è «ciò da cui qualche cosa muove verso l’una o l’altra delle due condizioni opposte». L’istante è un passaggio dal non essere all’essere, dall’essere al non essere. Tuttavia non è in nessuna delle determinazioni opposte tra le quali passa, è una «cosa assurda», al di fuori del tempo e al di fuori dello spazio [6].
Ecco, a Natina Pizzi interessa proprio questa cosa assurda, che è tra il nascere e il morire, tra il moto e la stasi. «Istante sei perfetto / nell’improrogabile brevità / dove continui l’eterno» [7], leggiamo nella folgorante lirica da cui scaturisce il titolo della seconda raccolta della trilogia, L’istante perfetto. E non solo uno, bensì tanti istanti: «Collana d’istanti / cadente sul petto / pulviscolo di tempo / che scardina l’eterno» [8].
L’istante è polvere di tempo che continua, anzi scardina l’eterno. In che senso?
Il pensiero corre a un altro filosofo dell’istante, Søren Kierkegaard, forse il miglior commento ai versi di Pizzi: «L’istante è quell’ambiguità in cui tempo ed eternità si toccano, e con ciò è posto il concetto di temporalità, in cui il tempo continuamente taglia l’eternità e l’eternità continuamente penetra il tempo» [9]. Nell’istante il tempo taglia l’eternità, scrive Kierkegaard; nell’istante il tempo scardina l’eternità, gli fa eco, con parola ancor più radicale, Pizzi. Kierkegaard aggiunge poi che solo l’istante è capace di dare senso alla temporalità. Senza l’istante il tempo sarebbe solo un succedersi di punti tutti uguali a se stessi, indifferenti, senza storia. L’istante dischiude le dimensioni del ricordo e della speranza, del passato e del futuro.
Lo sa bene Natina Pizzi, che così prosegue la lirica che apre L’istante perfetto [10]: «grate di prigione / chiave di secondini / graffi di smeraldi / all’India rubati / cerchi di futuro / pansé di ricordi». Come un sasso nell’acqua cheta, l’istante genera cerchi di futuro, e insieme ricordi che sono come un fascio di fiori.
L’istante dà senso al tempo, afferma Kierkegaard. Non solo, chiosa Pizzi, l’istante restituisce il tempo ai sensi. Solo così il tempo può fecondare, e insieme scardinare, l’eternità.
Ma c’è già una nuova contraddizione. La collana d’istanti è grata di prigione e al tempo stesso chiave per aprirla. Continuiamo allora il dialogo con Il concetto di angoscia di Kierkegaard. In quanto apertura al futuro e al passato, l’istante è la libertà. Tuttavia per noi la libertà non è qualcosa di ovvio, da sempre lì, a disposizione, bensì qualcosa da conquistare, sempre di nuovo. Più che essere liberi, siamo in perpetuo cammino verso la libertà: è questo il compito della nostra vita. Ciò significa che, proprio perché destinati alla libertà, iniziamo da uno stato di non libertà. L’istante ci fa rendere conto di questo nostro stato di non libertà nel momento in cui ci apre alla libertà.
Di qui i versi di Pizzi [11]: in «grate di prigione», l’istante è «chiave di secondini»: è ciò che ci libera. È un processo che dà dolore; tuttavia, se desideriamo la libertà, siamo chiamati ad amare questo dolore. Siamo così condotti ai versi seguenti della lirica: «amanti di dolore / nel viola svanito / nodi di trasgressione / dove inceppa il cuore». Non c’è cammino di libertà che non trasgredisca, che non vada oltre lo stato di privazione di libertà in cui siamo. Questo faticoso percorso si chiude con un’immagine leggera, che ci rimescola ancora le carte e ci apre al sorriso: «istante di lucertola / con la coda nel mutevole». Prima di essere una visione, la lucertola è spesso un rumore che ci sorprende, come l’anelito alla libertà ci sorprende nella «quiete della non speranza», per dirla con il Vittorini di Conversazione in Sicilia.
Un’ultima riflessione possiamo trarre da Il concetto di angoscia: l’istante della libertà getterà sempre la sua ombra di angoscia. In una società che ci vorrebbe sempre falsamente felici; che vorrebbe estirpare ogni radice d’angoscia come se fosse solo una mala pianta; che vorrebbe fare di noi tanti Peter Schlemihl senz’ombra, Kierkegaard ci ricorda che non c’è libertà senz’angoscia. Non a caso Schlemihl, nel racconto di Adelbert von Chamisso, poté privarsi dell’ombra solo grazie a un patto con il diavolo. Allo stesso modo rimuovere l’angoscia è atto diabolico. L’angoscia è l’alter ego da prendere per mano, se vogliamo essere liberi.
Da qui sorge il risuonare in sottofondo dell’angoscia nei versi di Natina Pizzi. Altre volte, invece, l’angoscia viene in primo piano, per esempio in questa lirica dell’ultima raccolta della trilogia, Lo spigolo del cerchio [12]: «Ti batte l’angoscia sul cuore / è toro che non vuole morire / è torero che insiste veloce / è drappo scarlatto che freme». Nel dramma del combattimento tra uomo e animale l’angoscia è una e trina: è toro, è torero, è drappo. «è voce soffocata lontano / è abito silente ai tuoi piedi». È all’orizzonte come una voce lontana, è vicinissima come gli abiti che portiamo addosso; «è strada che fa tangenziale / è vicolo cieco che spranga». È grande arteria di comunicazione che accomuna gli esseri umani, perché il vero comunicare è sempre una comunione; ma è pure vicolo cieco di solitudine che ti annoda la lingua impedendo ogni comunicazione; «è mente dell’uomo che esplode / è corpo che lento si annoda». È esplosione centrifuga della mente ed è groviglio centripeto del corpo; «è madre che dona il seno / è padre che nega il pane / è sguardo che avido trancia / la mano di un girotondo». L’angoscia è severità incomprensibile di padre che distrugge il gioco, quello stato di meditazione profonda del bambino; ma l’angoscia è anche infinito dono di amore di madre.
Pare singolare accoppiare angoscia e amore, comprendere l’angoscia a partire dall’amore. Questo ci ricorda però Natina Pizzi: l’amore è principio dell’angoscia. Basti ripensare all’angoscia di Gesù nell’orto di Getsemani: alla vigilia del suo atto di amore l’angoscia si fa più lancinante. Vale a dire, l’amore per l’altro è fonte di angoscia. Ma l’amore di sé genera non meno angoscia. Amarsi è per lo meno altrettanto difficile quanto amare l’altro.
Ritorniamo allora ad Afrodite, la raccolta che porta il titolo della dea dell’amore: è aperta, in modo sorprendente, dalla lirica intitolata Narciso. Per poter amare il “tu” bisogna passare attraverso la porta stretta dell’amarsi. Il che non significa rimirarsi tronfiamente allo specchio, bensì ricordarsi che io sono il primo “tu”: io sarò sempre un essere a me sconosciuto e incomprensibile, tanto quanto mi è sconosciuto e incomprensibile ciascun altro “tu”. Senza il Narciso bene inteso non c’è accesso ad Afrodite. Leggiamo allora Narciso: «Àmati quando il vento / strusciandosi farà di te / un fascio di aria / àmati quando la solitudine / ti prenderà per mano / e ti condurrà a casa / àmati quando al mattino / ti ritroverai vuota / perché i pensieri sono finiti / àmati quando nell’orto / sarai costretta a bere / fino all’ultimo sorso / àmati quando / con le rughe del tuo viso / faranno un ventaglio / àmati quando sarai cenere» [13]. Amarsi quando si ha la sensazione pànica di sciogliersi nell’universo. Amarsi nell’istante dell’angosciosa solitudine, nella fiducia che quell’angoscia è il nostro compagno di viaggio da prendere per mano, senza il quale non potremo tornare nella casa del nostro sé. Amarsi nello scoraggiamento, quando si è costretti a vuotare il proprio calice di disperazione. Amarsi nella debolezza della vecchiaia. Amarsi nell’istante della morte. A questo ci chiamano i versi di Natina Pizzi.
Ettore Rocca
[1] Afrodite (Calabria Letteraria Editrice – gruppo Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007), L’istante perfetto (Iride – gruppo Rubbettino, Soveria Mannelli, 2009) e Lo spigolo del cerchio (Iride – gruppo Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012).
[2] H. Diels - W. Kranz (a cura di), I presocratici. Testimonianze e frammenti, ed. it. a cura di G. Giannantoni, Laterza, Roma-Bari, 1983, p. 94.
[3] Infra, p. 38.
[4] Diels - Kranz, I presocratici, cit., frammento 8, pp. 275-276.
[5] Infra, p. 69.
[6] Platone, Parmenide, 156d, in Id., Opere complete, vol. 3, tr. it. di A. Zadro, Laterza, Roma-Bari, 1985, p. 46.
[7] Infra, p. 213.
[8] Infra, p. 151.
[9] S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, in Id., Opere, a cura di C. Fabro, Sansoni, Firenze, 1972, p. 156 (traduzione modificata).
[10] Infra, p. 151.
[11] Ibid.
[12] Infra, p. 264.
[13] Infra, p. 31.
(www.bottegascriptamanent.it, anno VIII, n. 84, agosto 2014)
Francesca Buran, Ilenia Marrapodi, Pamela Quintieri, Francesco Rolli, Fulvia Scopelliti
Simona Baldassarre, Ilaria Bovio, Maria Laura Capobianco, Maria Assunta Carlucci, Alberto Cazzoli, Guglielmo Colombero, Veronica Di Gregorio Zitella, Giacomo Dini, Riccardo Fiorenza, Maria Francesca Focarelli Barone, Federica Lento, Chiara Levato, Giuseppe Licandro, Flavia Maccaronio, Irene Nicastro, Maristella Occhionero, Giusy Patera, Stefania Pipitone, Elisa Pirozzi, Luciana Rossi, Martino Santillo, Maria Saporito, Maria Carla Sicilia, Paolo Veltri, Andrea Vulpitta, Carmine Zaccaro
Denise Amato, Selene Miriam Corapi, Vilma Formigoni, Mariacristiana Guglielmelli, Aurora Logullo, Rosina Madotta, Manuela Mancuso, Elisa Pirozzi, Pamela Quintieri, Francesca Rinaldi, Francesco Rolli, Fulvia Scopelliti