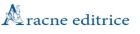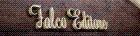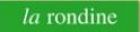Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Mario Saccomanno
A. XVIII, n. 206, dic. 2024
 Il cibo come opera d’arte
Il cibo come opera d’artein un Sud Italia dinamico
ed esuberante di sapori
da conoscere e gustare
di Guglielmo Colombero
Da Città del sole edizioni, una squisita antologia dedicata agli aromi
di una terra che sempre si ravviva grazie a una robusta gastronomia
«Un uovo ad occhio di bue può essere un’opera d’arte? Andate a Camigliatello da Pietro e Denise Lecce e scoprirete che non vi sto propinando una bufala. Ne parlo per competenza perché amo quel piatto, così semplice e straordinario se l’uovo è fresco, l’olio eccellente e la cottura perfetta. Ma non pensavo che potesse trasformarsi in un prodigio». Con queste parole Matteo Cosenza, nella Prefazione ad un’antologia deliziosa sia sotto il profilo letterario sia sotto quello sensoriale, in quanto fortemente evocativa per il palato, per la vista e per l’olfatto, racchiude la filosofia ispiratrice di La Rivoluzione è un pranzo di gala. Storie di cibo e di Calabria (Città del sole edizioni, pp. 224, € 15,00), volume che raccoglie una cinquantina di testi di autori vari, suddivisi in otto aree tematiche dai due curatori, il presidente di “Slow Food Calabria” Nicola Fiorita e la giornalista Mita Borgogno. Una terra di mezzo del palato è il titolo dell’Introduzione firmata da Borgogno: «pagine che ho curato, amato, titolato, letto, odorato, gustato quasi». Dal canto suo, ne Il pranzo sostenibile, Fiorita sottolinea che «la gastronomia – come anche il diritto alla felicità – è di tutti, ma proprio per questo ha bisogno di cultura, di partecipazione e di sostenibilità, ovvero di una coscienza critica che ne governi gli impulsi e ne guidi il tragitto. Sulla scorta di queste convinzioni, è nata la collaborazione fra Slow Food e il Quotidiano della Calabria che ora viene trasfusa in questo volume».
Squame variopinte e caglio lattescente
Nel capitolo Il pesce povero Silvio Greco, Nicola Fiorita, Luigi Monaco, Antonio Abbruzzino, Mariano Calogero e Silvia Ceriani affrontano la questione della pesca nel Mediterraneo: in altre parole, si cerca di individuare da dove proviene, e come, il pesce che troviamo sulle nostre tavole. «Chiudete gli occhi, fate il conto di quello che consumate e vedete che ci verranno in mente tonno, spigole, orate, alici, naselli, triglie, seppie, calamari, polpi, gamberi. E siamo a dieci, poi baccalà, sogliole e poco altro. Eppure i nostri mari ci offrono oltre duecentocinquanta specie consumabili», scrive Greco (Povero pesce, poveri noi). E, prosegue Monaco (Crotone e il suo mercato del pesce), l’odore del pesce sui banchi «contiene la vita del mare e delle coste, la storia della città, la sapienza degli uomini che con il pesce lavorano, la fatica e il guadagno dei pescatori e una promessa di gusto che solletica l’istinto di tutti gli avventori». Lo chef Abbruzzino (Il pesce povero e la buona cucina) tesse un elogio del pesce azzurro, spesso emarginato dai ristoranti snob: «oltre al beneficio salutare che questi pesci ci donano, essi ci regalano emozioni di gusto impareggiabili». Sul versante più politico dell’arte culinaria (Guarda che Mao), Calogero ammonisce: «una pesca responsabile e, soprattutto, un consumo consapevole possono contribuire a invertire (e questa è la rivoluzione) l’attuale processo di impoverimento delle risorse del mare». E, conclude Ceriani (Siamo giunti al capolinea?), «i consumatori si informino sul pesce che acquistano – che pesce è, dov’è stato pescato, proviene da pesca legale o illegale? – perché sapere è potere. Bisogna gestire il mare per farlo rinascere».
Nel capitolo sui latticini, Calabria, terra di formaggi, Piero Sardo, Cristina Ciccone, Virginia Aloi, Danilo Colabraro, Roberto Rubino, Orazio Lupia e Pietro Rizzo si addentrano nello squisito labirinto della produzione casearia calabrese. Un vero gioiello incastonato nella filiera alimentare del Mezzogiorno. A Ciminà, nella Grecia calabra (terra del cumino selvatico, da cui deriva il nome del paese), scrive Sardo (Investire in formaggio: accadde a Ciminà): «il caciocavallo si fa a due testine, un formaggio piccolo, allungato, chiuso da due nodi terminali, direi caso unico nel panorama caseario». Manualità trasmessa attraverso le generazioni che non si limita a impastare il formaggio: lo modella, lo plasma come una scultura da ingoiare poi nel rito conviviale, gustandone non solo la consistenza ma anche la forma. Tassello di quel mosaico che Ciccone (Come nasce un presidio) definisce «circuito sensibile di consumatori e produttori che stringono un’alleanza per la difesa e la diffusione di quelle tradizioni che compongono l’ineguagliabile ricchezza alimentare del nostro paese». E che Aloi e Colabraro esemplificano (Formaggi/birre: l’abbinamento) in un fastoso connubio fra gastronomia e creatività: «Abbinare formaggio e birra della stessa intensità gustativa per evitare che uno dei due alimenti sovrasti l’altro, oppure creare abbinamenti per contrasto». Un esempio concreto? Il Castelmagno e le birre d’abbazia: laici e chierici che vanno a nozze! Proseguendo sul sentiero dei formaggi calabresi, ecco il Monte Poro, principe dei canestrati: «al latte in caldaia viene aggiunto caglio in pasta di agnello e ciò fa sentire in bocca una sensazione di pungente che è una variazione più tenue della piccantezza vera e propria» (Aloi in La tradizione del caseificio calabrese). E, altro segreto, per la ricotta affumicata si utilizza un «miscuglio di essenze legnose da ardere, affinché il fumo prodotto possa conferire caratteristiche organolettiche uniche. Dall’arancio al mandarino, dal ginepro all’alloro, dal lentisco al mirto, l’ulivo sempre come “base”, dall’eucalipto al cedro, tutte essenze aromatiche sempre usate in consociazione». Esiste purtroppo anche il rovescio della medaglia: scrive Rubini riguardo alle mozzarelle (Latti e misfatti) che «all’assenza di sapore per colpa di un latte insipido si associa una mancanza di vitalità per la scomparsa della flora lattica». Ma ci consolano Lupia e Rizzo (I formaggi e lo chef) con la ricetta della fonduta di caciocavallo silano con porcini e filetti di coniglio lardellato (la troverete a pagina 71: sconsigliata unicamente a chi soffre di colesterolo alto!).
L’olio calabrese, figlio della Terra e del Sole
Luccica come un serpente d’ambra, l’olio che proviene dai frantoi di Cerchiara, di Siderno, di Strongoli di Marina, di Rossano e di Dolce di Rossano, di Cassano allo Jonio, di Corigliano Calabro, di Cariati, di Bisignano, di Vaccarizzo Albanese, di Cirò Marina, di Soverato, di San Giorgio Morgeto, di Sellia Marina, di Guardavalle, di Trebisacce, di Crosia. Ne ripercorrono la scia densa e odorosa, nel capitolo Puro come l’olio, Giuseppe Giordano, Mimmo Gangemi, Marco Ferrini, Stefano Alcaro e Ada Celico. Per la Calabria l’oro verde possiede un intenso valore emblematico: «è cultura», scrive Giordano (L’Olio e la Calabria), «scandendo il tempo, i ritmi e i riti di generazioni e generazioni di calabresi fin dalla media età del bronzo». La memoria storica dei frantoi possiede un sapore quasi proustiano: ricorda Gangemi (Quando eravamo contadini) che «mi estasiavo già prima di arrivarci, per gli odori che mi raggiungevano lungo la Statale: dell’olio appena spremuto, quello più penetrante della morga, delle olive in attesa, della sansa ammucchiata». Del resto, assaggiare l’olio, provarne sapore e intensità attraverso le papille gustative, odorarlo dopo averlo contemplato mentre sgocciola lento e sinuoso su una crosta di pane fragrante, è un rituale senza tempo che conserva sempre una specie di ancestrale sacralità. Scrive Ferrini (Olio extravergine d’oliva, salute e territorio) che dall’olio di Calabria si sprigiona «l’inequivocabile essenza del territorio nei nostri piatti», e, all’insegna di una persistenza tenace anche nei residui, specifica Alcaro (Le sostanze “magiche” dell’Olea europaea L.) che persino dallo scarto di produzione olearia conosciuto come “acqua di vegetazione” si ricava «il componente antiossidante che diventa un utile integratore alimentare». Conclude Celico (Per un filo d’olio sulla nostra tavola): «L’olio sembra dunque essere uno di quei prodotti magici, oltre che sacri, per l’implicita capacità che possiede di unire passato e presente sotto una stessa emozione e uno stesso gusto».
Una genuina convivialità che rivive ancora
Nel capitolo Mangiare in Calabria, sulle osterie e sulle taverne della regione argomentano Eugenio Signoroni, Vito Teti, Nicola Fiorita, Giuseppe Giordano, Ottavio Cavalcanti e Filippo Veltri. Per Signoroni (Il valore del territorio) le osterie sono «i più importanti custodi della cucina tradizionale». Ricorda Teti (La cantina di nonno Peppe e altre cantine) che «Le osterie del calabrese erano baracche precarie, incompiute, provvisorie, quasi a raffigurare una terra segnata da ripetute catastrofi, da abbandoni e ricostruzioni, da spostamenti e da esodi. Una “terra in fuga” non poteva che avere “cucine” improvvisate e alimentare un legame affettivo ed emotivo con il cibo». Fiorita e Giordano (Le osterie calabresi di oggi: istruzioni per mangiare bene) inquadrano questo legame «in un’ottica di sacralità totalizzante, sempre più incalzata e scalzata dal suo ruolo dominante dalla laicità contemporanea». Spiega Cavalcanti (Osterie, taverne, cantine) che «Tra tutti i termini citati (osteria, taverna, locanda, bettola) e quelli non citati (bottiglieria, enoteca, fiaschetteria, mescita) in Calabria quello comunemente usato è cantina e sta a indicare uno dei tre luoghi delegati alla produzione, conservazione, consumazione di cibi e bevande: “’A cantina, ’u trapitu e ru furnu” perfetta sintesi della trinità mediterranea: pane, vino, olio, la cui importanza è sancita dalla proiezione nella dimensione sacrale». Innegabile l’evoluzione verso forme di ristorazione sempre più raffinate: ne prende atto Veltri (Quando si mangiava di cantina in cantina…) constatando che «Dove oggi c’è la Tavernetta, più o meno, un tempo non lontano da noi c’era un posto dove si mangiava assai bene: pasta e patate alla sangiovannese, pasta alla pecoraia, la salsiccia con i broccoli di rapa, le patate ’mbacchiuse, con un bel fuoco per le giornate invernali».
La tradizione non cede al rullo globalizzatore
Nel capitolo Morzello, stocco e frittole: il cibo come bandiera Achille Curcio, Nicola Fiorita, il cuoco di Durruti e Michelangelo D’Ambrosio ci offrono alcuni esempi di civiltà che trova il proprio riflesso nell’arte culinaria: per Curcio (Pepè le rouge, ultimo principe del morzello) nel morzeddhu, piatto tipico catanzarese, «fu elevata a nobiltà la povertà della trippa e delle frattaglie». Per Fiorita (Catanzaro: morzelle e putiche) «la tradizione del morzello sembra aver resistito alle ventate modaiole che hanno ridisegnato il volto di molte città italiane». E, ci informa il cuoco di Durruti (Lo stocco di Cittanova e Sabato frittole) che «lo stocco è così saporito che lo si può mangiare perfino crudo», e che la preparazione delle frittole, ricavate dal grasso di maiale, si trasfigura in «una vera e propria liturgia del cibo». Anche D’Ambrosio (Più stocco per tutti e Le Frittole di Reggio Calabria fra mito e rito) rammenta che «lo stocco arrivava sulle coste calabresi per mare, veniva sbarcato nel porticciolo di Pizzo Calabro e di qui, a dorso di mulo, trasportato a Mammola e Cittanova per essere poi ammollato nelle pure e fresche acque dello Zomaro», e che la preparazione delle frittole appare ancora oggi «imperniata su un vero e proprio codice linguistico e immersa in un microcosmo in cui tutto ha una sua funzione, un significato, un ordine irrinunciabile senza il quale tutto diventa vano».
Alimentare il corpo e nutrire la mente
Dal punto di vista squisitamente letterario, nel capitolo Cibo è cultura Nicola Fiorita, Pierluigi Tavella, Gianluca Pitari, Domenico Levato, Michele Salazar e Fabrizio Scarfone si spingono alla ricerca dell’orizzonte dove Cibo, Parola e Immagine si confondono. Sostiene Fiorita (Confesso con gusto) che «il cibo ha una relazione stretta, strettissima con la cultura e che a questo nesso inestricabile di sensi e piaceri occorre dedicare le nostre più ardite riflessioni». Approfondisce ulteriormente il nesso Tavella (Il cibo e i libri: i consigli di un libraio): «il consiglio è quello di approcciarsi alla letteratura così come ci avviciniamo a un profumato piatto di pasta e fagioli, a un sontuoso bollito, a un delicato soufflé, con la stessa predisposizione a procurarsi piacere di quando ci sediamo a tavola». E rincara la dose Pitari (Cibo e poesia), sul versante della creazione poetica: «noi Poeti calabri non possiamo che aggrapparci ai frutti più dolci di questa nostra aspra e seducente terra… sono le eccellenze che si attraggono reciprocamente!». Dalle parole alle immagini: la panoramica tracciata da Levato (Cibo e Cinema) sul filo che lega la gastronomia alla Settima arte pullula di citazioni classiche (Il pranzo di Babette, Il fascino discreto della borghesia, La grande abbuffata, La ricotta) e per il cinephile che ama anche la buona cucina è un invito a nozze. Con qualche risvolto inquietante, in riferimento al capolavoro di Marco Ferreri: abbuffarsi di cibo è «un modo perfetto per stordire i sensi, per addormentare il pensiero e astenersi dal giudizio proponendo un’analogia “anestetica” tra cibo e droga che i moderni sintomi del comportamento alimentare confermano». Tornando ai classici della letteratura, per Salazar (Il Cibo in Cervantes tra sogno e realtà) il creatore di Don Chisciotte «inneggia alla libertà sottolineando che solo chi non dipende da altri per sfamarsi è libero dal bisogno». E conclude Scarfone indagando sulla “magnifica ossessione” da cui era posseduto Mario Soldati riguardo al vino (Un libro divino): proprio nel vino «si scorge la sintesi dell’equilibrio necessario all’uomo perché la sua esistenza abbia un senso compiuto: quello fra natura e cultura».
Una Terra risanata che produce frutti sani
Nel penultimo capitolo, Terra Madre, Sabrina Garofalo, Isabella Giunta, Silvia Sivini, Nicola Fiorita e Marisa Gigliotti ci raccontano storie di terreni confiscati al crimine organizzato e rifioriti grazie alla produzione di eccellenze alimentari. Garofalo (Libera terra: guida al mangiare pulito) racconta come «melanzane a filetti, pesto di peperoncini piccanti, miele, olio extravergine di oliva sono i prodotti che hanno vinto la doppia sfida sul piano della legalità e della qualità». Anche Giunta (Diritto al cibo: percorsi di sovranità alimentare) sottolinea che «la sovranità alimentare reclama la necessità di non ridurre il cibo a mera mercanzia e di tutelarlo di fronte agli attuali processi speculativi». Focalizzando il discorso sulla Calabria, Sivini (A Terra Madre passando per la Calabria) evidenzia l’emergere di «effervescenze interessanti volte a far riacquistare il controllo della filiera alimentare alle aziende agricole». Mentre Fiorita (Il sapore della legalità) e Gigliotti (Il valore degli agricoltori) ribadiscono che «combattere le mafie mangiando bene, non è forse uno straordinario e invidiabile progetto di vita?» e che «Slow Food pensa alla promozione di un nuovo concetto di agricoltura che pone al centro la qualità del cibo ma anche il rispetto dell’ambiente».
Anche in Calabria il tubero che vale più dell’oro
L’epilogo del volume è incentrato su una triade di rango supremo, e non a caso s’intitola Per finire: pane, vino e tartufo. Le firme sono di Antonio Blandi, Giovanni Gagliardi e Gianfranco Manfredi. Per Blandi (Pane al pane) «Il pane costituisce una sinfonia di sensazioni che pervade i nostri sensi: il sapore, la fragranza, il crepitio della sua crosta, le sfumature dei colori». Non si può che concordare con una percezione quasi mistica del pane quotidiano: nella visione evangelica dell’Occidente cristiano, il Pane e il Vino dell’Eucaristia incarnano tuttora la sacralità dell’Ultima Cena. Sulla riqualificazione recente dei vitigni calabresi si sofferma Gagliardi (Il vino e la Calabria): «oggi si può parlare di un rinascimento del settore vitivinicolo dell’intera regione grazie alla caparbietà e alla lungimiranza di quanti hanno tenuto ferma la barra anche quando il vino calabrese era poco o niente considerato». Dulcis in fundo, Manfredi (Il mistero dei tartufi calabresi) ci rivela che «i tartufi, in Calabria, ci sono, eccome. Anzi, ci sono sempre stati. Solo che non sono stati mai cercati bene». Si annidano nelle falde del Reventino, nel Pollino, nella Sila Grande, nelle Serre, nell’Aspromonte. E gli chef calabresi ne cospargono le lamelle sulla carne cruda di vitello, sui risotti, sulla crema di patate silane in simbiosi con il pecorino, sulle linguine con gamberi rossi di Capo Vaticano e, suprême delicatessen, sulle uova di quaglia!
Guglielmo Colombero
(www.bottegascriptamanent.it, anno VII, n. 68, aprile 2013)