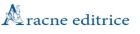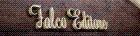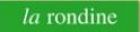Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
ANNO I, n° 0 - Agosto 2007
 La vita e l’amore visti coi versi di Ottavio Rossani
La vita e l’amore visti coi versi di Ottavio Rossani
di Adele Desideri
Il ricorso alla metafore per la realizzazione del percorso dell’Autore
verso la ricerca di sè. Per la conquista di un’autonomia espressiva
L’ignota battaglia. Romanzo in versi (Iride-Rubbettino, pp. 64, € 6,50), la più recente e intensa raccolta di Ottavio Rossani, presenta un fraseggio allungato e ondulato, segna un’onda stilistica riflessiva e ponderata, nella quale le pulsioni, i sentimenti non spaventano e sono anzi matrice di creatività. Il libro, dedicato alla moglie del poeta, Teresa, testimonia una sedimentazione profonda della lingua e crea una musicalità malinconica ma non rassegnata. L’incedere è disteso, il linguaggio è quello interiore, dell’anima, quando esplora le sue medesime profondità. L’effetto lirico rimanda all’immagine di un’onda marina: a tratti il movimento è schiumoso come gli spruzzi che si infrangono sugli scogli, a tratti diviene lento come le oscillazioni delle maree. Il canto è fluente, morbido, disteso e dilagante.
È un romanzo in versi, per esplicita dichiarazione del sottotitolo, che registra la storia per metafore della vita dell’autore: «Ho amato verdi splendori inventati, // ho attraversato torrenti argentati, // ho trovato esemplari sotterrati, // ho inseguito contatti inesplorati. // Spesso sono tornato nei luoghi amati: // mi sono apparsi sempre più desolati». Rossani inserisce le proprie vicende personali in una cornice corale di significati, perché il dolore appartiene all’uomo, a tutti i popoli; e l’inquietudine, pur essendo un vissuto individuale, ha risonanze simili in ogni essere umano. Forte e significativa è l’angoscia per il futuro, quello individuale – che è corsa, battaglia, lavoro, viaggio - e quello collettivo - che è guerra, disastri, crimini –, tutta vissuta sulla pelle, «nell’intarsio di mille latitudini // dove si sogna, dove si soffre».
E torna ancora, come in molti suoi testi precedenti, il tema della metropoli milanese, che «Ha fretta di fermarsi»: è la logica del quotidiano, vissuto in una corsa folle per arrivare a sera e riposarsi, dopo avere fatto tutto, come si è soliti dire, dopo avere adempito ai tanti piccoli e grandi obblighi di tutti i giorni, per ricominciare da capo, il mattino seguente.
C’è – già presente ne Le deformazioni (Campironi Editore, pp. 96) – l’interrogazione sul tempo che stanca la passione e usura l’ardore dei sensi: «Scontate le lusinghe, bruciata l’iniziazione, // non gradisci più il solletico del rischio».
La donna amata è qui la metafora della casa, dei desideri sciolti e riannodati; rappresenta forse la figura della madre che accoglie il figlio-marito; frena la voglia di fare, quando è eccessiva, e cura il mal di vivere che ne consegue. Allora, nella pausa degli affetti, il tempo si ferma, non corre più, il «[…] tempo […] non esiste». Arriva quindi anche il momento della gioia, mai assoluta però, perché «Se c’è gioia è quasi angoscia».
C’è nel poema una profezia mancata, scritta molto prima della morte di Teresa, che l’autore ha inteso non rimuovere al momento della pubblicazione: «Ci troveremo canuti a centellinare // i fantasmi del bene e del male // insieme amandoci come prima, // aspettando il ritorno di esuli figli, // come mio padre, come tua madre. // Come accadde già, così accadrà». È l’immagine dei giorni senili, nei quali l’autore si proietta e si vede in compagnia della moglie. Il poeta però sa bene che le profezie purtroppo sono solo sogni: «La vita è un dolce canto. // Lo so, lo so, è anche sterile grido». Significativo è quindi il tema della morte: «L’arrivo di Lady M s’annuncia // sempre con complicanze illeggibili? // No, tocca gentilmente la spalla. // Ti giri, la sorprendi a sghignazzare, // e… comprendi». La morte arriva inaspettata e strappa, lacera affetti e speranze; distrugge i sogni e annulla i desideri.
«I poeti, sì, che gridano il vero. // In un attimo di eternità», registra Rossani. Ma la vita è, come la verità, antitetica, ambigua, aperta al dubbio, alla contraddizione, e perciò feconda: «Rimane un dubbio o, forse, solo un suono. // Ma tra grido e sorriso non c’è dissonanza». La vita è una danza degli opposti, è l’accenno di un’incontro con se stessi e con l’altro da sé. La via della coscienza passa attraverso l’esperienza del nulla, della negazione, tutto ciò che è positivo è tale perché in se stesso implica una negatività superata, dialettizzata: «Sono tornato alla coscienza/ precipitando nel vuoto».
E, dopo le difficoltà, si riparte, ancora si ritorna alle origini, per ritrovare l’energia, il gusto della creatività, il desiderio: «Possiamo anche ipotizzare un’altra partenza. // Quasi…un ritorno. Un febbrile ritorno».
Nella riflessione poetica di Rossani è centrale l’antitesi tra le duplici polarità parola-salvezza e silenzio-malattia: questo tema, già presente ne Il fulmine nel tuo giardino, (Nicolini Editore, pp. 64, 1994), ne L’ignota battaglia diventa essenziale. Da una parte sta la parola che trafigge e arriva al cuore, dall’altra il silenzio che genera la malattia. L’autore, è bene ricordarlo, ha dedicato una vita, come giornalista, scrittore e poeta, al controllo delle parole, sulle parole e tramite le parole. Il silenzio, scrive infatti Rossani, ammala: «Anni contati per un’intesa // coi roventi silenzi». Un silenzio, quello con se stesso, forse speso nel rincorrere i gravosi impegni della quotidianità, ma anche le passioni e gli amori della vita: «Tempo amato per raccontare // a poche persone ammirate // strade, paesi e strane verità. // […]Vinse la progressiva // insistente bellezza // del desiderio più tenace».
In questo libro il poeta canta dunque la storia accorata e dolorante della malattia che lo affligge, o, se vogliamo, che affligge ogni uomo troppo sensibile, che non ha risolto il rapporto tra ciò che è e ciò che avrebbe voluto essere; una malattia che ha assunto tante forme, tante sintomatologie. L’approccio alla comprensione del malessere è intellettuale: «La mente interroga, il corpo nega», «Lotta e vinci […] col nobile cervello. // […] // Se vuoi vincere devi comandare». Il Super-Io, nella sua funzione raziocinante, cerca di controllare, di dirimere la marea delle note inconsce dell’Es che trafiggono il corpo: «Il dito giudicante segue il fiume // che turbina nelle zone di contrasto // e registra, infinitesimali scoperte, // le differenze dei toni e dei suoni». La malattia è debolezza, viltà verso se stessi e gli altri, è illogicità, strappo della razionalità morale e biologica: «Viltà immotivata si camuffa // in visioni sminuzzate di maghi // che predicono illogiche analogie». Qui nessuno è normale: «I sani soffrono più dei malati», nessuno è sano, allora, o forse c’è la pacata saggezza di chi sa che non deve invidiare l’erba del vicino, che pare essere più verde finché non è posseduta. Si intuisce subito, sin dall’inizio, che la vicenda personale del poeta è anche, in buona parte, allegoria del mondo contemporaneo, del male di vivere dell’uomo post-moderno, chiuso in un dettato autoreferenziale, in un egotismo che dimentica troppo spesso il tema dell’alterità, dell’amore, della solidarietà e che non soddisfa bensì ammala.
È da notare che nel poema ci sono tre soggetti evocati ad ascoltare, a recepire il senso raccontato: il tu dell’autore, quello del medico o dei medici che curano le varie patologie del malato - giacché anche e soprattutto di queste egli qui scrive - e quello di Teresa. Questi tre tu, che rappresentano in realtà l’io terapeutico dell’uomo inquieto - un non-eroe invischiato nella misteriosa e irrisolvibile “battaglia” contro il disagio e l’inadeguatezza - si identificano e si sovrappongono, anteponendosi al tu delle varie forme della malattia, descritta come un nemico ignoto. L’oscuro virus dell’esistenza risulterebbe risiedere, ad un’attenta analisi, nell’Es del poeta: infatti, dice egli stesso, è nel sangue, quando sgorga «rosso vivo», che si annida il male, il male del corpo e dell’anima. Ma il sangue è da sempre, nei miti antichi e nello scritto biblico, archetipo di vita e morte, simbolo dell’anima appunto, di quell’anima che oggi, dopo la lezione di Freud, è identificabile nell’Es. Dunque il corpo è una pagina scritta in codice, il codice sono i sintomi ed il linguaggio da decifrare è il male dell’anima, dell’Es: «Il tarlo rode dal cervello al fianco. // […] // Non c’è risposta alla mano che tocca».
Le diramazioni dell’intruso - che rappresenta il male nelle sue diverse ramificazioni - sono ben collocate sui pentagrammi del corpo e si annidano «[…] tra il pube e l’ombelico». L’intruso si mimetizza o sfugge per tornare beffardo e non risponde ai tentativi di dialogo, alle questioni poste dal poeta per carpirne il segreto maleficio e debellarlo. Rossani a lungo insiste nell’indagare, ma ad un certo punto scrive: «[…] deve esserci, poi, una risposta?». La risposta forse c’è ed è eventualmente da ricercare non già nelle cause e nei termini medico-tecnici, bensì nel linguaggio onirico, dell’Es ancora, quindi dell’analogia e dell’archetipo.
Il nemico segreto, che distrugge e annienta, ma nonostante tutto non vince, pare essere in realtà la malattia delle malattie, l’ipocondria, che equivale poi ad una meta-malattia, alla paura di ammalarsi, a quello stato di allerta dello spirito che genera un corpo a disagio, disturbato: «Ora vegli per un dolore senza firma // e non c’è musica adatta per la cantata // delle notti invase dai fantasmi». Non a caso la malattia è vissuta dal poeta anche come una forma di vigliaccheria, come tradimento, ipocrisia, mancanza di coraggio, che sono poi i vizi dell’anima.
Si profila allora una battaglia interminabile e soprattutto ignota, perché il nemico è sfuggente, anonimo, clandestino, è «quel pugno che mi voleva schiacciare», è «[…] lo straniero» che «[…] rovistava nella pancia», è il «[…] malefico vile intruso». Rossani cerca «da tempo… di snidarlo», «Lungo i bordi del torrente». E il torrente pare proprio essere simbolo del corpo, dell’esistenza concreta, della sfera conscia, ma pare anche rimandare a ciò che sta sotto lo scorrere dell’acqua, perciò all’inconscio, a ciò che fluisce dentro di noi nella zona più profonda nonostante la nostra volontà.
L’emorragia, uno dei sintomi narrati ne L’ignota battaglia, appare come il segnale doloroso della fatica compiuta dall’autore per partire da Soverato, il suo paese d’origine, per costruire un destino, per se stesso e per la moglie, per fare, per poiein. I poeti, si dice spesso, sono sempre pigri: sembra che, in effetti, combattere la pigrizia dell’indole artistica sia stato per Rossani, vero poeta, una fatica improba e un ulteriore viatico verso le vere o presunte patologie. Gli attacchi di panico qui descritti sono forse proprio indicativi di quanto la sensibilità dell’autore sia stata ferita dal ritmo incessante della sua attività creativa, dai sacrifici compiuti per arrivare a costruire la non facile professione del giornalista e una condizione di vita più agevole e più consona alle sue “vene nascoste” di quanto non lo fosse quella vissuta da ragazzo e da adolescente. Ma non è solo questo disagio esistenziale ad emergere nel racconto. È chiara la discrasia tra il presente e il futuro, tra la realtà e il desiderio, tra l’esistente e l’ipotetico, tra i sogni e le attese, tra il visibile e l’immaginario.
Il malato, che sia invischiato in una sindrome psicosomatica o meno, non tollera di non essere al centro dell’attenzione. È d’altronde noto che molte patologie derivano dalle piaghe di un eccessivo narcisismo, di una esasperata concentrazione sul sé e si palesano spesso con i sintomi della nevrosi. È pure noto che la struttura nevrotica è spesso l’unica via di salvezza, un modo per contenere le più marcate sofferenze: «[…] cercare dunque un equilibrio, // primitiva tecnica di sopravvivenza». Rossani in questo testo ben conosce le dinamiche dell’ombra e scrive un libro in cui la libido nevralgica e dolorante si libera dalle trappole della nevrosi per sprigionare e dirigere la creatività in precise tinte poetiche, determinando l’auspicata autoguarigione.
La malattia, i disturbi che di volta in volta si presentano, sono vivisezionati dunque attraverso lo spasimo lirico e sono vissuti nella logica del terrore, della paura, come si notava in precedenza. Non mancano tuttavia tratti di leggera autoironia, quando l’autore tratteggia le piccole coscienti e sarcastiche superstizioni che la sua intelligenza e la sua cultura gli concedono: «Dal cervello il messaggio di terrore // si sgancia sul sangue che obbediente // inonda segrete ferite», e «Nel taschino serbavo il piccolo // pavido avvizzito corno ungherese».
C’è un sogno interessante, che il poeta ha vissuto in tenera età: «Quando la casa di legno scricchiolava, // spalancavo gli occhi nel buio compatto // alla sciabola minacciosa e sfolgorante. // Ma non vedevo il saraceno che ghignava // in attesa di vibrare il colpo mortale. // Reprimevo il fiato per svenire. // “Se non mi sente vivo, rinuncerà”».
Interessante è anche il sogno in cui una puzzola viene scaraventata addosso al poeta ed egli, nel difendersi, la soffoca nella mano; una madre feroce aveva lanciato quella puzzola mortale e mortifera. È questa una rara immagine, tra tutti i testi poetici di Rossani fino ad oggi pubblicati, in cui il femminile è totalmente negativo: è un’immagine che affonda le radici nell’inconscio, nel sogno appunto, quasi che non fosse lecito esprimere in termini razionali una concreta malignità del femminile.
L’origine della sofferenza potrebbe essere dunque rintracciata nei sogni riportati. E il saraceno del primo quadro onirico chi è? La paura del ragazzo, di notte, di stare solo? La mancanza di un affetto fondamentale, quello materno? O forse l’origine del male sta nell’avere cercato di razionalizzare troppo, di mettere appunto sotto silenzio emozioni, paure e fragilità? «Credevo fosse indistruttibile // la forza dell’intelligenza. // Sempre indifeso raccolsi e archiviai // sconfitte, ferite, cicatrici». Oppure la malattia nasce dai sensi di colpa? «Spera che non sia tu // a pagare il peccato non commesso». O, ancora, la causa di tutto risiede nella predisposizione del poeta all’indignazione nei confronti delle ingiustizie subite dal singolo individuo o dalla collettività? «Le forze ancora non ti sorreggono, // come quando affrontavi le contrarietà // con costante spietata indignazione». O forse a sconquassare anima e corpo sono le paure ancestrali, come pietre aggregate e levigate dal tempo dell’esistenza, quelle che il bambino prima, l’adolescente e l’adulto poi, hanno soffocato negli studi e nel lavoro? «Sei tu, paura, a scaraventarmi giù, // nel flusso di una violenta traversata». O forse “l’ignota battaglia”, nella quale lo scrittore è rimasto irrimediabilmente segnato, è quella di un doloroso bilancio della propria esistenza? «Volevo essere ammirato vincitore // oltre i confini non prevedibili. // Ho vinto, lo so. E dunque ho perso». Quel che ha perso lo sa solo lui, quel che ha pagato in sovrappiù è scritto proprio nel suo corpo e nel suo spirito ed è velatamente alluso nei suoi versi incandescenti.
Gli interrogativi che abbiamo posto sono illazioni; illazioni plausibili però.
Rossani tuttavia non vuole fermarsi, se non per poco, lo stretto necessario per rinfrancarsi e poi ripartire: «Così, a tratti dormo e mi rigenero. // E quando tornano gli assalitori // sono pronto a ricominciare la battaglia». L’Autore appare teso a costruire castelli e roccaforti per gran parte della sua vita. Ma c’è stato chi ha pensato anche per lui al pane quotidiano, ai bisogni dello spirito, e a quelli più prosastici del corpo: è Teresa a ricordare all’autore che ha «fame», cioè che esiste, oltre al lavoro, la vita quieta dei giorni qualunque. Chi è poeta sa di possedere l’inquietudine, sa di essere logorato dai sogni e dalle illusioni: «bambino e vecchio, di sogni consunto, // col mio amore che forte s’espande». Il poeta è perciò testimone e vittima del bisogno di andare, di evadere: «Preda di me stesso ancora m’avventuro // alla conquista di un continente lontano, // come quel perduto giorno quando vidi // dalla terra passare un bastimento». Rossani ha seguito l’istinto primigenio di partire. Resta però, nel suo vagare, un punto oscuro: non ha smascherato la paura, gli ignoti desideri: «Ho varcato portoni tra luci e frastuoni. // Senza merito ho raccolto derelitti. // Carichi di emozioni mi hanno soggiogato. // Ho sgominato arroganti masnadieri. // Ma ignoti desideri temevo di smascherare». Forse la sua sensibilità, se ascoltata, lo avrebbe reso meno avventuroso, non lo avrebbe portato così lontano: «devo pagare l’ignobile contraddizione // di quel che ero e non potevo essere».
Non c’è pace, in questo itinerare, e Rossani percepisce se stesso come una «[…] indifesa apparenza […]», ove apparenza non è sinonimo di ipocrisia o falsità, ma indica il configurarsi, sulla scena del mondo, dell’uomo di ogni tempo e segna il suo dover essere, l’irrinunciabile necessità di soffocare le proprie fragilità per costruire e combattere in un consorzio, quello umano, più hobbesianamente competitivo che non cristianamente amicale.
Ben presto nel libro arriva un segnale diverso, qualcosa che indica la strada, la prospettiva della guarigione: «S’alza la visibilità nel vischioso teatro. // Riemerge dal ventre una strana avidità», «[…] la vita ricresce dopo l’eruzione // risalendo dal fondo del cratere?». Ed è subito chiaro che la salvezza non sarà determinata dalla bontà delle cure mediche, ma operata in prima persona dall’autore, attraverso la parola giornalistica, artistica, anche pittorica, e, soprattutto, attraverso la parola detta a se stesso, la parola che ha la potenza di espellere l’intruso, lo rende cosciente e dunque lo annienta, la parola che smaschera il silenzio. La guarigione è essenzialmente il ritorno del desiderio, del canto, del vento: «e dirigi dunque verso l’isola del desiderio. // […] // Salpa, e al richiamo un buon compagno // ti risponderà, fosse anche solo il vento». Allora arriva, con le vestigia della salute, l’«uomo che sa ascoltare», che sa cioè scrutare con occhi nuovi «[…] nella geografia del malumore», perché le parole dette e ascoltate fanno bene, «le parole fanno bene», ma «vogliono il loro tempo».
Come non individuare qui un riferimento alla salvifica terapia psicoanalitica, nella quale, attraverso un tempo a volte molto lungo, si dice il proprio male e, dicendolo, se ne guarisce? Se poi ci avviciniamo a Jung, nella creatività sta l’espressione più salvifica del male, la via della guarigione. E non ci interessa sapere se il poeta sposa un credo o l’altro del variegato panorama psicoanalitico, né tanto meno se ha intrapreso un itinerario di tal genere per guarire; l’importante è che qui Rossani è veramente poeta perché interpreta, in forme nuove, linguisticamente forti e semanticamente coinvolgenti, forse anche inconsciamente, archetipi universali, modi dell’anima antichi quanto l’uomo, se ricordiamo che in alcune popolazioni primitive la colpa veniva espiata urlandola nell’incavo di una caverna.
Gnòsi seautòn, conosci te stesso, suggerisce l’oracolo delfico: è la ricerca affascinante dell’«[…] arcano che si profila distruttivo», del nostro provenire da padre e madre e poi diventare padre e madre, del senso del latte ricevuto o meno, della carezza materna mancata o meno, di quel che siamo nel profondo e non diventiamo mai. Il male allora ci pare veramente scaturire dallo scarto che c’è, nel destino personale di ogni uomo, tra il Dna ricevuto, biologico e psichico, e l’ambiente vissuto, il contesto di convivenza che ci accoglie o ci respinge.
Resta la salvezza intesa come saggezza: vedere la vita con occhi poliedrici, essere consapevoli che tutto scorre, tutto fluisce, diviene e trapassa: «Di qua o di là, s’invecchia e basta». Resta la consapevolezza che “niente è nuovo sotto il sole” (Qoelet 1,9) e che forse vale la pena di sposare la massima di Orazio, il carpe diem; o, meglio ancora, di recuperare gli affetti sicuri, il senso dell’amore, della sensibilità accondiscendente: «Ma qualcuno, dentro aloni di mistero, // si sorprenderà in un gorgo di bontà». Il primo rimedio per guarire è incominciare a sorridere, anche delle piccole cose, anche di ciò che non pare vero e ci lascia increduli: «Tra brama e sgomento inseguivo // il necessario antagonista del dolore, // quella teoria inconsapevole // di gioire anche delle incredulità». E il secondo è fermarsi, concedersi del tempo vuoto, del tempo di festa: «Adesso dormi! Ricomincerai domani».
C’è il desiderio di guarire, dichiarato: «[…] mi trovo qui, con il buio più stellato, // nel gracidio carezzevole della palude, // solo, incontaminato, disperato, // innamorato della scia di una cometa // paziente di guidarmi verso l’uscita». C’è la volontà di annientare l’intruso: «Tu, non avvicinarti più. // Ti rifiuto, ti resisto, ti respingo. // E non sarai tu a decidere // il finale di partita». C’è, in questi ultimi versi, il germoglio della guarigione, perché il buio è stellato e il gracidio della palude carezzevole; e poi perché la cometa guiderà verso lidi salubri. E notiamo che la fata buona, la medicina, è una cometa, termine femminile: la salvezza, come in Falsi confini (Xenia, pp. 72), è ancora affidata al ventre, all’utero, ai seni di donna.
Alla fine dunque il poeta non è sconfitto dalla sua intensa vita, dalla mole pesante delle sue esperienze: «Ho cercato musiche nel vuoto. // Inseguito, derubato, insultato, // ho pregato, ho odiato, ho amato. // E ho sempre resistito ai fantasmi. // […] // […] io da solo mi salverò, // solo con tutte le mie illusioni» e poi, ancora, «L’energia sta di nuovo dilagando».
È la rinascita: «A ottobre mangeremo ancora castagne», la rinascita dei cicli naturali che tornano e danno sicurezza. Il nuovo autunno significa che c’è stata l’estate. Riprende l’esplosione dei colori e della vitalità: «Il vento tornerà col galoppo di un cavallo».
Il libro si chiude con un quadro senile di speranza e amore, un quadro di conforto, ancora una volta attraverso la compagnia di Teresa, del suo femminile caldo e avvolgente, un quadro latore di buone novelle: è, questa, un’immagine scritta da Rossani quando la moglie era viva e qui pubblicata dopo la sua morte. La divinazione è stata beffata dalla realtà, rimane solo come sogno infranto: «Ad uno ad uno se ne andranno via // e noi due soli a leggere poesie, // come in una lontana notte sul balcone // nel fruscio rinfrescante degli ulivi. // Eri allora la mia luna. // Ci sarai ancora, mia fortuna?».
L’avventura della lunga, faticosa, minacciosa “battaglia” si conclude con la parola fortuna, con una parola, cioè, non solo ancora femminile, ma anche dal significato aperto, che allude alla buona sorte, ad una sospensione del giudizio, alla speranza; è una pagina di poesia, quella vera, che celebra l’attenzione alla vita dopo avere cantato le donne, i cavalier, l’arme, gli amori, le cortesie, l’audaci imprese.
Adele Desideri
(www.bottegascriptamanent.it, anno I, n. 1, agosto 2007)