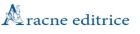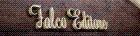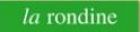Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Anno I, n° 4 - Dicembre 2007
 L’ordine internazionale nel Ventunesimo secolo
L’ordine internazionale nel Ventunesimo secolo
di Mariangela Monaco
Le tipologie possibili, il forte impatto sul sistema globale della politica
dell’amministrazione Bush e il suo fallimento. In un volume il Mulino
Dal 1989, con la caduta del Muro di Berlino e la fine della Guerra fredda, è acceso il dibattito tra gli studiosi di Relazioni internazionali riguardo alla nuova configurazione del sistema e dell’ordine internazionale. Che tipo? Quali sono le caratteristiche? Due domande che non sono di semplice risposta, e per due motivi fondamentali: primo, il sistema internazionale post-1989 si presenta con caratteristiche nuove e inediti rispetto, almeno, agli ultimi 3-4 secoli; secondo, l’11 settembre e la svolta unilaterale dell’amministrazione di George W. Bush, sancita in particolare dalla guerra irachena, hanno introdotto un elemento della politica estera americana che mai si era visto e che, sostanzialmente, entra in contraddizione con la stessa storia statunitense.
Un recente studio di Filippo Andreatta, politologo e docente all’Università di Parma, intitolato Alla ricerca dell’ordine mondiale. L’Occidente di fronte alla guerra (il Mulino, pp. 154, € 10,50), traccia il quadro teorico del dibattito, con giusta attenzione al comportamento e al ruolo degli Stati Uniti, ipotizzando quale sia l’ordine che, al momento attuale e nel prossimo futuro, possa avere maggiori probabilità di successo: un ordine multilaterale in cui la potenza americana svolga una funzione di leadership (e non di egemonia).
La necessità di un ordine e il suo fondamentale carattere anarchico
Nell’analizzare l’ordine internazionale, la prima cosa da tener presente è che si tratta di un’istituzione anarchica, in quanto manca un governo mondiale che possa far rispettare le regole a tutti gli attori e che abbia il monopolio della forza legittima. Non tragga d’inganno l’esistenza delle Nazioni Unite: non sono e non possono essere per loro stessa natura – ossia, le norme della Carta Onu – il governo mondiale (a meno di una radicale quanto improbabile riforma).
Il carattere anarchico dell’ordine internazionale è importante perché pone continuamente il rischio di un collasso della cooperazione. E questo, precisa Andreatta, per tre ragioni: non esiste nessun agente che possa fermare un attore che decide di sfidare l’ordine costituito; gli stati sono costretti a coordinare decisioni con attori molteplici e autonomi, generando quindi problemi di scambio di informazioni e di fiducia reciproca; gli stati sono costretti a proteggersi da soli, e dunque assicurarsi, anche con azioni aggressive, che gli altri stati non possano nuocere.
Come ha scritto Gallarotti «l’ordine è assistito, piuttosto che imposto, dalle istituzioni»: questo significa che gli ordini internazionali, ancorché in quanto anarchici, si reggono sulla volontà dei principali attori. Da ciò consegue anche che non tutti i tipi di ordine si adattano ad un particolare sistema internazionale: dipende dagli incentivi presenti. Tali incentivi possono essere “naturali” oppure “istituzionali”. Quello più importante, che spinge gli stati a dar vita ad un ordine (cioè a delle regole condivise nei rapporti internazionali) attiene certamente al primo tipo: ridurre il più possibile l’incertezza presente in un ambiente totalmente anarchico e, dunque, aumentare il più possibile la propria sicurezza.
Una maggiore prevedibilità comporta poi tutti i vantaggi tipici delle istituzioni politiche: una diversa cornice temporale, perché i rapporti sono reiterati e non occasionali; un rafforzamento del livello di cooperazione; la riduzione dei costi del negoziare, elemento quest’ultimo che aumenta la durata degli ordini, in quanto negoziare e legittimare un ordine diverso risulta essere di gran lunga più costoso che mantenere quello esistente.
Quattro tipologie basilari
Nota Andreatta che gli ordini internazionali si possono distinguere sulla base del loro grado di autonomia, cioè «dal loro grado di indipendenza dagli incentivi “naturali” presenti nel sistema internazionale». Gli ordini unilaterali sono dunque quelli meno autonomi, in quanto si basano solo sull’interesse nazionale delle grandi potenze; gli ordini multilaterali invece, scrive l’autore, «cercano di introdurre regole istituzionali “autonome”, cioè diverse da quelle spontanee che emergono dai vincoli sistemici».
Possiamo individuare quattro tipi di ordini, due puri e due ibridi.
Un meccanismo di alleanze competitive è un tipico esempio di ordine unilaterale, minimo e poco ambizioso, fondato solo sulla prevedibilità nascente dal desiderio di sopravvivenza degli stati. È caratterizzato da informalità (le regole non sono istituzionalizzate) e da esclusività (le parti sono divise in alleati e avversari e la comunità internazionale in campi contrapposti). All’opposto vi è il tipo puro multilateralismo, cioè un meccanismo di sicurezza collettiva, che è inclusivo – in quanto comprende al proprio interno tutti gli stati, incluse le potenziali minacce, e chiede a tutti gli stati di intervenire a favore di eventuali vittime, a prescindere dai rapporti di amicizia o inimicizia – e formale (le regole sono chiare e istituzionalizzate).
È molto difficile, secondo Andreatta, che si possano instaurare gli ordini puri; molto più probabile, invece, che abbiano successo quelli ibridi, e cioè il concerto, caratterizzato da inclusività e informalità e che attiene all’ambito multilaterale, e la difesa collettiva, basato su esclusività e formalità, attinente all’unilateralismo.
Quale ordine: 1989-2001
Il sistema globale dopo
Inoltre, è soggetto a due forti rischi: la proliferazione nucleare e il terrorismo. Queste due minacce non sono nuove, ma presentano caratteri diversi. La prima, durante
Detto ciò, e precisato che l’autore argomenta convincentemente i motivi per cui la sicurezza collettiva e le alleanze competitive non sono ordini compatibili con l’attuale sistema internazionale, dalla fine della Guerra fredda – che a differenza di altre epoche storiche (come nel caso della Restaurazione ottocentesca o dopo i due conflitti mondiali) non ha offerto un momento per negoziare e stabilire nuove regole – al settembre 2001 abbiamo avuto un ordine basato su un certo equilibrio tra concerto e difesa collettiva, il quale ha conosciuto, sostanzialmente sotto l’egida dell’Onu, momenti di vittoria e di sconfitta. In particolare, il concerto che è stato compatibile con il necessario obiettivo dell’allargamento delle aree democratiche. E questa compatibilità, puntualizza Andreatta, si è mantenuta specialmente perché «si è ritenuto che il miglior contributo per lo sviluppo economico e politico delle zone di instabilità fosse fornire un sistema internazionale il più ordinato e cooperativo possibile, anche perché il processo di democratizzazione era spontaneo e andava solo incoraggiato».
Ma questa compatibilità, argomenta ancora l’autore, poteva reggere fintantoché non si fosse verificata una delle seguenti condizioni: una potenza non democratica si contrappone all’Occidente, erodendo il consenso internazionale; il processo di democratizzazione si ferma, facendo emergere contraddizioni tra concerto e difesa collettiva; la percezione della minaccia si acuisce al punto tale da rendere impazienti alcune grandi potenze. L’ultima condizione si è verificata con l’attacco alle Torri gemelle e al Pentagono.
Caratteristiche della politica estera statunitense
Il più importante motivo, rileva Andreatta, per cui gli attentati del 2001 hanno avuto conseguenze storiche è perché sono stati diretti contro gli Usa. Infatti, essi sono il più potente stato del pianeta e l’unico in grado di modificare da solo, attraverso la propria politica estera, gli equilibri a livello globale; da soli hanno rotto l’equilibrio tra concerto e difesa collettiva a favore di quest’ultima (nel caso della guerra in Afghanistan).
Inoltre, bisogna tener presente altri due elementi peculiari: primo, gli Stati Uniti hanno un livello di tolleranza alla minaccia di gran lunga minore rispetto al Vecchio Continente. E questo per ragioni storiche e geografiche: gli Usa non hanno mai visto la guerra sul proprio territorio –se non ai tempi dello scontro civile tra nordisti e sudisti –, protetti dall’Atlantico e dal Pacifico, mentre l’Europa è stata martoriata dai conflitti, da ultimi quelli devastanti del Novecento. Secondo, negli Usa la democrazia ha un impatto più determinante sulla politica estera rispetto agli altri paesi. Ciò perché, mentre in Europa alla democrazia ci si è giunti passando attraverso vari regimi – e dunque la fonte della sovranità degli stati è esterna, basata sul principio del mutuo riconoscimento sancito dalla pace di Westfalia –, gli Stati Uniti nascono come democrazia, sancendo il primato assoluto della sovranità popolare: quindi, precisa Andreatta, «il rispetto delle regole internazionali viene dopo la deliberazione degli organi democratici e se c’è un conflitto tra le due fonti, la seconda prevale sulla prima. E così sufficiente una disposizione sfavorevole del Congresso perché non venga ratificato un accordo internazionale».
Già Tocqueville scriveva che «ci sono due cose che un popolo democratico troverà sempre difficili: cominciare una guerra e finirla»; un pensiero esplicitato successivamente da George Kennan, il quale sosteneva che una democrazia è pacifica, è lenta ad entrare in un conflitto, ma «quando è stata provocata fino al punto di dover impugnare la spada, non perdona facilmente l’avversario per aver creato tale situazione». Ciò spiega alcuni atti molto bellicosi compiuti dagli Usa nel XX secolo, quali l’introduzione del concetto di resa incondizionata ed assoluta o l’utilizzo della bomba atomica in Giappone.
A questo quadro va aggiunta, secondo l’autore, un’altra considerazione: la tendenza americana ad esportare la democrazia come panacea per risolvere i problemi del sistema internazionale. Tendenza che nasce da due ragioni: «Da un lato, c’è la speranza che, se solo le altre potenze adottassero il sistema politico che vige negli Usa, la loro politica estera cambierebbe radicalmente. Dall’altro lato, l’assenza di minacce contigue spinge gli Stati Uniti ad intraprendere “guerre di scelta” nelle quali è necessario mobilitare l’opinione pubblica con obiettivi idealistici». Una propensione messa sempre in secondo piano, tranne se si verificavano due particolari situazioni che spingevano al cambiamento del regime di un altro stato: «primo, quando era sufficiente un uso di strumenti a bassa intensità e soprattutto nell’emisfero occidentale; secondo, quando gli Stati Uniti erano già in guerra per ragioni più “tradizionali”». Non c’è mai stato, dunque, da parte statunitense, un intervento violento per esportare la democrazia. Nell’alveo della prima situazione rientrano casi di interventi regionali come quello in Grenada nel 1983 o ad Haiti nel 1994-96, mentre in quello del secondo tutti i maggiori conflitti del XX secolo a cui gli Usa hanno preso parte: le due guerre mondiali, le guerre in Corea e Vietnam, gli interventi in Iraq, Bosnia e Kosovo. In alcuni di questi casi gli Stati Uniti hanno cercato di promuovere la democrazia (come in Germania e Giappone dopo
La svolta unilaterale di Bush
La prima reazione all’attacco alle Torri Gemelle, cioè l’intervento in Afghanistan, rientrava nei parametri discussi nel precedente paragrafo, e, in particolare, vi era un chiaro casus belli nonché il consenso della comunità internazionale. Cioè prefigurava quindi una forte continuità con il passato. Finché Bush non ha deciso di modificare strategia in senso unilaterale.
Ab origine, c’è un retroterra ideologico molto forte che spiega tale cambiamento: l’amministrazione di Bush nasce dal connubio di due filoni di pensiero. Da una parte, la propensione “jacksoniana”, che sancisce la supremazia dell’interesse americano e l’uso della forza per difenderlo, tradizionale filone del pensiero repubblicano (Dick Cheney, Donald Rumsfeld). Dall’altra i “neoconservatori”, che sostengono che il ruolo storico degli Stati Uniti è quello di promuovere la democrazia nel mondo, per migliorarlo, a tutti i costi (Paul Wolfowitz, Richard Perle).
L’influenza della nuova amministrazione sulla politica estera, nota Andreatta, si è vista ben prima della guerra in Iraq del 2003: Bush infatti ha subito manifestato la sua propensione all’unilateralismo ritirando gli Usa da tutta una serie di accordi multilaterali prima dell’11 settembre: dal Protocollo di Kyoto, dal Trattato di proibizione dei test nucleari, dalla Corte penale internazionale, dalla Convenzione sulle armi biologiche e, nel 2002, dal Trattato sui missili antibalistici.
È evidente, comunque, che è con la guerra irachena che l’amministrazione Bush ha operato una vera e propria rivoluzione: l’intervento contro Saddam ha evidenziato, rileva l’autore, che, per la prima volta, la volontà di modificare il sistema internazionale – esportando la democrazia – prevale sulla tendenza a difenderne la stabilità. E per fare ciò, gli Usa sono disposti ad usare la forza su larga scala, in tutto il mondo, e se necessario in maniera unilaterale. L’11 settembre ha reso vulnerabili gli Stati Uniti, e Bush ha deciso, conformemente al suo background ideologico, di ridurre il pericolo utilizzando lo strumento più evidente della supremazia statunitense: quello militare. L’intervento iracheno era, a conferma di ciò, privo sia di casus belli sia di consenso internazionale.
Quale ordine per il futuro?
Questa svolta politica e l’intervento in Iraq non ha reso gli Usa più sicuri, ma ha, viceversa, avuto diversi effetti negativi: un certo isolamento diplomatico, un indebolimento della credibilità statunitense, in particolare della sua intelligence, e non sono chiari i benefici della guerra irachena rispetto alla più ampia lotta al terrorismo.
Insomma, prosegue Andreatta, «l’approccio radicale insito nella svolta di Bush non costituisce una solida base per un nuovo ordine internazionale. Un ordine basto sulla difesa collettiva [non dimentichiamoci della “coalizione dei volenterosi”, Ndr] sembra infatti più adatto ad una situazione difensiva [...] che ad una situazione, come quella odierna, nella quale è necessario esportare stabilità da una zona del mondo all’altra». Inoltre, entrano in gioco altre quattro considerazioni:
1) il voler forzare il sistema politico di altri stati porta con sé il rischio di antagonizzare vaste parti del mondo sulla base del loro regime politico interno, e non del loro comportamento internazionale;
2) un eccessivo attivismo degli Usa incentiverebbe le altre potenze a non impegnarsi nelle situazioni più complicate, causando una fuga dalle proprie responsabilità di attori essenziali per risolvere problemi di carattere regionale;
3) una sistematica politica di esportazione della democrazia correrebbe il rischio di minare l’ordine internazionale stesso;
4) l’esportazione è, infine, un processo molto complesso e per nulla scontato (come del resto testimonia proprio l’Iraq).
Alla luce di tutto ciò, e delle difficoltà incontrate nella ricostruzione post-bellica irachena, è molto probabile che gli Usa tornino [magari alla fine del mandato di Bush, Ndr] ad appoggiare il multilateralismo. Del resto, nota Andreatta, nel sistema internazionale contemporaneo l’ordine più praticabile è sicuramente il concerto, i cui principi sono incorporati dalle Nazioni Unite: è quello infatti il luogo in cui è possibile promuovere il più ampio consenso internazionale, sia nel campo democratico che in quello non democratico. Un ordine in cui l’Europa, seconda potenza mondiale, dovrà certamente svolgere un ruolo maggiore nel mondo (e, in tal senso, è stato molto importante il riavvio del processo di integrazione a Lisbona). Dalla fine della Guerra fredda i rapporti tra le grandi potenze sono insolitamente cooperativi: si tratta dunque, conclude l’autore, di «un’occasione imperdibile».
Luigi Grisolia
(www.bottegascriptamanent.it, anno I, n. 4, dicembre 2007)