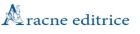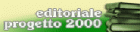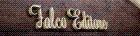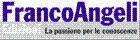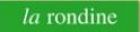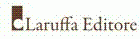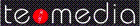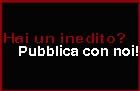Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Giovanna Russo
Anno V, n. 41, gennaio 2011
 Palestina e Israele:
Palestina e Israele:un fomentato odio
logora i due popoli
di Guglielmo Colombero
La storia della questione palestinese
in un libro edito da Città del sole
La questione palestinese, spesso fagocitata da convinzioni ideologiche, viene invece affrontata da un punto di vista oggettivo da Patrizia Fabbri, giornalista milanese esperta in questioni mediorientali, autrice del libro Israeliani e palestinesi. Le ragioni degli altri (Città del sole, pp. 192, € 12,00). L’autrice premette che «è importante capire che stiamo parlando di nazionalismi, di colonialismi, di interessi economici e geo-politici delle grandi potenze, di conflitti sociali, di sfruttati e sfruttatori, di vittime e persecutori. Vittime e persecutori che, in più di 100 anni, non hanno mantenuto staticamente il proprio ruolo: stiamo parlando di vittime che si trasformano in persecutori, di persecutori che si trasformano in vittime, in un’alternanza che si ripete ciclicamente». Patrizia Fabbri, giornalista e saggista esperta in politica mediorientale, affronta la questione con incisiva chiarezza di esposizione.
Gli antefatti: due nazionalismi contrapposti
L’avvio della colonizzazione ebraica della Palestina, spiega Fabbri, coincide con il primo embrione di progetto sionista, per cui anche il nazionalismo arabo (inizialmente fondato sull’assimilazione di valori occidentali come il liberalismo e la modernizzazione) subisce una metamorfosi regressiva, radicalizzandosi in funzione antisionista. Il sionismo affonda le sue radici in un retroterra originato dalla diaspora consumatasi fra il 70 d.C., quando le legioni romane distrussero il Tempio di Erode a Gerusalemme, e il 135 d.C., data della fallita insurrezione di Simone Bar Kochba, che segnò l’annientamento definitivo dell’identità nazionale ebraica.
Nel Medioevo la comunità ebraica venne marchiata dal papato come deicida e dai ceti dominanti come ricettacolo di usurai, creando così i presupposti per le future persecuzioni.
L’autrice sottolinea come in un Occidente scosso da «quel grande movimento innovatore che è stato l’Illuminismo, le comunità ebraiche della diaspora ne rimarranno ai margini […] alla rescissione del legame tra politica e religione, uno dei principi cardine dell’Illuminismo, gli ebrei contrappongono il tenace autoriconoscimento basato proprio sulla solidità di questo legame». L’emigrazione ebraica verso la Terra promessa inizia alla fine del XIX secolo (alle soglie della Prima guerra mondiale gli ebrei insediati in Palestina ammontano a quasi centomila unità, un settimo della popolazione complessiva), mentre il primo Congresso sionistico di Basilea risale al 1897.
Sul versante arabo, è da rimarcare che «la società arabo-palestinese ha ancora una struttura quasi feudale e non si presenta come una forza coesa contro la radicale trasformazione che il territorio palestinese sta vivendo». La classe dirigente palestinese, formata da alcune dinastie che esprimono anche l’élite intellettuale, esercita un controllo diretto sulla vita politica: i partiti sono emanazioni dell’oligarchia al potere, mentre i contadini poveri, i fellah, vivono fra l’incudine dello sfruttamento da parte dei latifondisti locali e il martello della pressione esercitata dalla crescente immigrazione ebraica.
Mito e realtà della Terra promessa
Il 2 novembre 1917 la dichiarazione di Lord Balfour sull’eventuale creazione di un “focolare ebraico” in Palestina, nel territorio appena strappato all’agonizzante Impero ottomano e incluso nel mandato britannico dalla Conferenza di pace di Sanremo del 1920, rivitalizza le speranze del movimento sionista. Fabbri osserva come la potenza mandataria appaia «continuamente in bilico, a seconda degli interessi tattici che via via si manifestano, tra appoggio e freno al progetto sionista». L’ondata migratoria ebraica verso la Palestina nel periodo fra le due guerre mondiali assume un’importanza fondamentale: «si tratta di giovani», scrive l’autrice, «formatisi nei circoli sionisti e socialisti dell’Europa orientale, dotati di altissimo spirito di sacrificio e una fede ardente, il cui ideale è un socialismo comunitario e fraterno: sono i pionieri che daranno vita ai kibbutz».
La colonizzazione ebraica produce risultati economici strepitosi: «l’agricoltore arabo nel 1936 ha un reddito medio pro capite di 7 sterline palestinesi contro le 34 del contadino ebreo. È in questo clima di progressivo impoverimento che si verificano le prime frizioni tra la popolazione araba e i coloni ebrei». Fra il 1929 e il 1938, la Palestina è teatro di violente sommosse antiebraiche, con centinaia di vittime da entrambe le parti: l’amministrazione britannica colpisce duramente i capi arabi della rivolta, e si fa strada l’ipotesi della spartizione del territorio fra arabi ed ebrei. La spirale sanguinosa è alimentata da un odio etnico che tende a espandersi a macchia d’olio: i sionisti più radicali formano organizzazioni terroristiche come l’Irgun e il Lehi, che si macchiano di crimini odiosi come l’assassinio dell’inviato svedese dell’Onu, Folke Bernadotte, e la bomba al King David Hotel di Gerusalemme. Dal canto loro, alcuni esponenti arabi come il Gran Muftì di Gerusalemme approvano con entusiasmo le leggi antisemite naziste di Norimberga del 1935.
Israele e la diaspora palestinese
Il trauma della Shoah accelera il cammino verso il coronamento del sogno sionista: il 29 novembre 1947 l’Assemblea dell’Onu approva la Risoluzione 181 (con 33 voti favorevoli contro 13 e 10 astenuti), che contiene il piano di spartizione della Palestina in due stati, uno ebraico e uno arabo, e l’internazionalizzazione della zona di Gerusalemme e di Betlemme.
Il 14 maggio 1948, a Tel Aviv, David Ben Gurion proclama la nascita dello stato di Israele: dopo duemila anni gli ebrei hanno nuovamente una patria. Il guaio è, sottolinea l’autrice, che «questo innegabile diritto viene esercitato non su un territorio deserto, disabitato, abbandonato all’incuria, ma su un territorio abitato da un’altra popolazione che non si sente affatto, come di fatto non è, responsabile di quelle persecuzioni perpetrate da altri. Quello che è un diritto per gli ebrei è sentito come un sopruso dagli arabi palestinesi […]. Altrettanto inaccettabile, per gli arabi, è l’assunto teologico che fa della loro terra prescelta dal popolo ebraico la pretesa promessa fatta da un dio migliaia di anni prima».
E subito esplode il primo conflitto arabo-israeliano. Superando luoghi comuni e banalità, nel libro emergono le vere ragioni della vittoria israeliana contro forze nemiche soverchianti (gli eserciti regolari di Egitto, Siria, Libano, Giordania e Iraq più la Legione araba e i volontari palestinesi): «gli ebrei hanno la certezza che si stanno giocando il tutto per tutto, sono consapevoli che le grandi potenze mondiali li potranno supportare nella difesa di quello che loro riusciranno a costruire ma che difficilmente, in questa fase, interverranno direttamente in un conflitto; sanno che, se non conquisteranno una terra da poter considerare saldamente loro, saranno sempre alla mercé di discriminazioni e persecuzioni. L’Europa, in secoli di persecuzioni culminati con lo sterminio nazista, ha azzerato le aspettative degli ebrei di trovare solidarietà (se non quella formale delle dichiarazioni) al di fuori della propria comunità: quella che si apre nel 1948 è la loro unica possibilità di costruire un luogo “sicuro”».
La Nakba, la diaspora palestinese (sette palestinesi su dieci abbandonano i loro villaggi durante il conflitto, e, nei dieci anni successivi, quasi un milione di ebrei sono parimenti costretti a emigrare dai paesi musulmani in cui vivevano: la metà di essi si stabilisce in Israele) rappresenta una delle catastrofi umanitarie più allucinanti del secolo scorso: l’autrice ne attribuisce la responsabilità in parte all’insorgere di sentimenti anti-ebraici che rendono impossibile la convivenza pacifica delle due etnie entro i confini israeliani e in parte alla volontà del governo di Israele, dato che «il ritorno di migliaia di arabi altererebbe la composizione etnica dello stato ebraico con la presenza di una “minoranza” araba pericolosamente corposa». Inoltre, e si tratta di un aspetto che raramente ha ottenuto l’approfondimento che meritava, la legislazione israeliana ha carattere etnico e confessionale: «essere laico in Israele, indipendentemente dalla comunità di appartenenza, è piuttosto complesso».
Dalla Guerra dei sei giorni all’Intifada
Le prime azioni di lotta armata contro Israele da parte di al Fatha, nucleo originario dell’Olp, il movimento nazionalista palestinese fondato da Yasser Arafat, risalgono al 1965. Due anni dopo, il 5 giugno 1967, l’esercito israeliano annichilisce la coalizione araba nella Guerra dei sei giorni, occupando Gaza, la Cisgiordania, Gerusalemme Est, il Sinai egiziano e il Golan siriano. La guerra dello Yom Kippur, scoppiata il 6 ottobre 1973, scatena il primo shock petrolifero in Europa, e imprime una svolta decisiva alle trattative di pace fra Egitto e Israele: nel 1979 la più importante delle nazioni arabe riconosce allo stato ebraico il diritto di esistere. Nel frattempo maturano i presupposti per la prima Intifada del 1987: osserva l’autrice che «all’insofferenza verso il perseguimento israeliano della strategia dei “fatti compiuti” con il crescere degli insediamenti in Cisgiordania e a Gaza, accompagnati da piccoli e grandi soprusi quotidiani (scarico di acque nere dagli insediamenti sulle terre coltivate dei villaggi palestinesi, taglio di ulivi ed espropriazioni di terre per motivi di “sicurezza”, ecc.) si unisce la definitiva presa di coscienza dell’indifferenza dei governi arabi per la “causa palestinese”». La prima Intifada incendia i territori occupati, dove cresce l’influenza politica dei movimenti radicali islamici come Hamas e Jihad, che perseguono apertamente la finalità di distruggere Israele. Secondo l’autrice, «la popolazione palestinese di Cisgiordania e Gaza, pressata tra indigenza economica, il perdurare dell’occupazione israeliana nella maggior parte del territorio e un’Autorità autocratica e corrotta, è poco incline a manifestare solidarietà con le vittime “nemiche”». E, riguardo ad Arafat, primo presidente dell’Autorità nazionale palestinese insediata a Gaza nel 1996, «il vecchio combattente di mille battaglie, quando passa a governare il coriandolo di paese che gli è concesso di amministrare, non si comporta diversamente dagli altri rais dei paesi arabi». La situazione economica della popolazione palestinese nei territori occupati subisce un vero e proprio tracollo nei primi anni Novanta: quasi decuplica il tasso di disoccupazione (il crollo dell’Urss fa affluire in Israele un milione di nuovi immigrati, manodopera a basso costo che rimpiazza gli stagionali arabi, e inoltre il Kuwait punisce l’appoggio di Arafat all’invasione irachena espellendo in massa i lavoratori palestinesi). Il 28 settembre 2000, alle soglie del terzo millennio, la temeraria incursione di Ariel Sharon nella spianata delle moschee getta benzina nel fuoco e innesca la seconda Intifada, che perdura tuttora con l’attivo sostegno del radicalismo islamico venuto alla ribalta dopo l’attentato alle torri gemelle e gli interventi militari dell’Occidente in Afghanistan e in Iraq.
Inseguendo la chimera della Pace
Quali le prospettive residue di pace dopo la guerra del Libano dell’estate 2006, la presa di possesso della striscia di Gaza da parte delle milizie armate di Hamas nel giugno 2007 e il bombardamento israeliano della stessa Gaza iniziato il 27 dicembre 2007 e concluso tre settimane dopo con un bilancio di oltre mille morti, quasi tutti palestinesi? Così conclude amaramente l’autrice: «La società palestinese, ostaggio di condizioni di vita al limite della sopravvivenza, e la società israeliana, annichilita dall’ondata di terrore che l’ha resa insicura come neanche le guerre hanno fatto, maturano un odio, continuamente fomentato dai loro stessi leader, che appare insanabile. Odio che è alimentato dalla reciproca non conoscenza e dalla separazione sempre più netta fra le due società».
Guglielmo Colombero
(www.bottegascriptamanent.it, anno V, n. 41, gennaio 2011)
Carla Campana, Agata Garofalo, Francesca Rinaldi, Angelica Terrioti
Giulia Adamo, Maria Elisa Albanese, Mirko Altimari, Simona Antonelli, Marika Balzano, Claudia Barbarino, Maddalena Beretta, Anna Borrelli, Valentina Burchianti, Elisa Calabrò, Valentina Cangemi, Maria Assunta Carlucci, Camilla Manuela Caruso, Alberto Cazzoli, Paola Cicardi, Guglielmo Colombero, Irene Crea, Monica De Francesco, Marina Del Duca, Maria Rosaria Ferrara, Elisabetta Feruglio, Vilma Formigoni, Maria Grazia Franzè, Angela Galloro, Manuela Gatta, Barbara Gimigliano, Eliana Grande, Giuseppe Licandro, Antonella Loffredo, Rosina Madotta, Daniela Malagnino, Stefania Marchitelli, Paola Mazza, Valentina Miduri, Elena Montemaggi, Sara Moretti, Valentina Pagano, Chiara Pennacchi, Anna Picci, Serena Poppi, Irene Pratesi, Giuseppe Pulvirenti, Mariastella Rango, Alessia Rocco, Roberta Santoro, Maria Saporito, Annalisa Scifo, Francesca Stella, Valentina Stocchi, Sara Storione, Pasquina Tassone, Alba Terranova, Laura Tullio, Monica Viganò, Andrea Vulpitta, Carmine Zaccaro, Paola Zagami, Ida Zicari
Carla Campana, Giulia De Concilio, Maria Franzè, Maria Grazia Franzè, Angela Galloro, Rosina Madotta, Francesca Rinaldi, Marilena Rodi, Giovanna Russo, Cecilia Rutigliano, Fulvia Scopelliti